Le politiche sanitarie e il coronavirus -Carlo Saitto
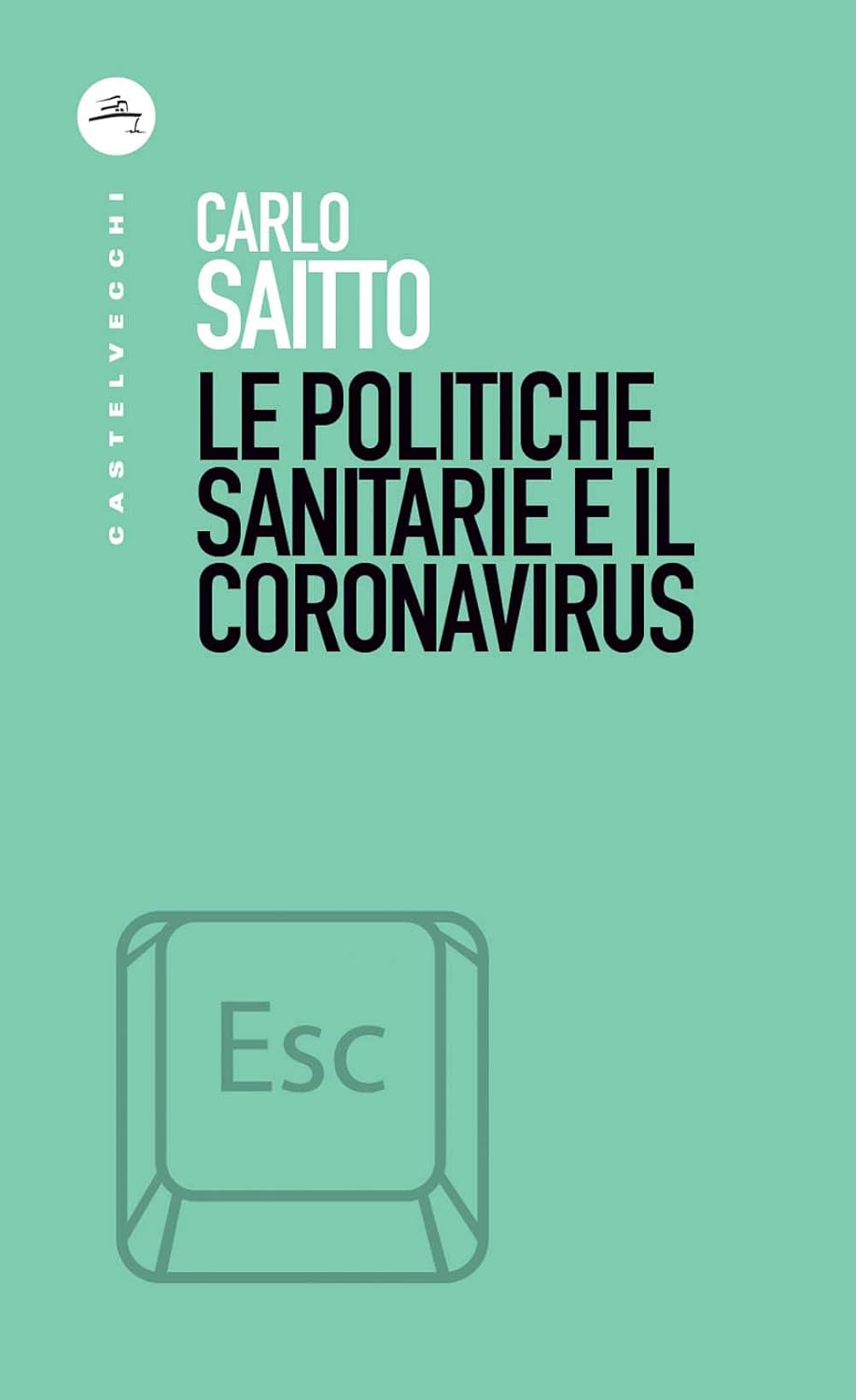
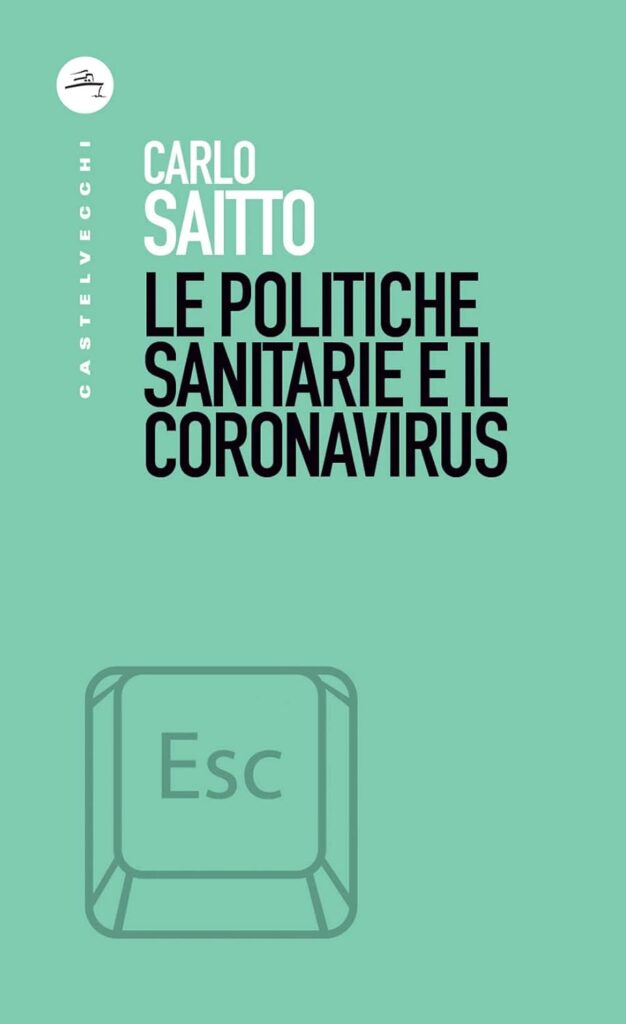
SINTESI DEL LIBRO:
Siamo di fronte a un evento straordinario: straordinario nelle
proporzioni, straordinario nelle risposte che ha indotto, straordinario
per la discussione che ha sollecitato e anche per le polemiche che ha
sollevato. In un clamore informativo, affollato di cifre non sempre
coerenti o comprensibili, di preoccupazioni e paure, di previsioni
inesistenti o incerte, di notizie banali e di annunci sensazionali, di
discussioni e di polemiche, rimane una quotidianità sospesa,
incapsulata dal buon senso di regole che limitano gli spostamenti e
alterano le relazioni.
Per noi, per tutti noi, questa è un’esperienza nuova che speriamo
rimanga unica, ma che pretende un aumento di curiosità e di
intelligenza; vorremmo, credo, in questo clamore trovare una griglia
di lettura: non certezze e non ulteriori informazioni, ma una chiave
per ordinare quelle esistenti e provare a dare loro un senso. A rischio
di perderne qualche particolare, vorremmo riuscire a guardare la
situazione da un punto di vista sufficientemente elevato per vedere
l’epidemia nella sua complessità, per riconoscere i suoi antecedenti,
per immaginare quali ne potranno essere gli esiti e come fare a
governarli.
In questo tentativo può essere utile porci alcune domande
utilizzandole come traccia per una riflessione e provando a dare, in
modo problematico, alcune possibili risposte. L’utilità di queste
risposte risiederà anche nella loro capacità di evidenziare i dubbi, di
valorizzare la loro provvisorietà e di rivendicare i presupposti ideali o,
se si preferisce, i pregiudizi che le sostengono.
I
quesiti sui quali si sviluppa questa riflessione sono dunque i
seguenti:
• quanto è grave questa epidemia?
• cosa abbiamo sbagliato nell’affrontarla?
• come possiamo cambiare?
Quanto è grave questa epidemia?
Credo che il modo migliore per valutare la gravità di questa
epidemia non sia guardarla dall’interno ma dall’esterno. I dati sui
contagi o, meglio, sul numero di tamponi positivi, come quelli sui
guariti e come, purtroppo, anche quelli sui decessi descrivono
l’epidemia come un evento isolato di cui provare a comprendere
caratteristiche e andamento. I numeri non esprimono sempre
fedelmente la realtà che vorrebbero rappresentare. Il numero dei
tamponi positivi, ad esempio, dipende dal numero dei prelievi che
vengono eseguiti e dai criteri adottati per la loro effettuazione: più
basso è il numero di prelievi e più stringenti sono i criteri per
effettuarli, più aumenta la probabilità di risultati positivi e più aumenta
tra i positivi la proporzione dei casi gravi. Come conseguenza
aumenta però anche il numero delle persone contagiate che non
effettuano il test e, dunque, il numero dei positivi finisce per risultare
inferiore a quello dei soggetti che hanno contratto l’infezione.
Perplessità analoghe riguardano anche il dato sui guariti, che può
essere ovviamente riferito solo a persone risultate positive e alle quali
sia stato applicato un criterio, spesso disomogeneo, di guarigione,
come un tampone negativo o la dimissione in caso di ricovero, o la
scomparsa del virus dal sangue o, semplicemente, la scomparsa dei
sintomi. Neppure il numero dei decessi attribuiti all’infezione appare
totalmente affidabile perché l’attribuzione è subordinata a un risultato
positivo del test, escludendo tutti quei casi che il test non hanno
eseguito e comprendendo anche quei pazienti che, morti per altre
cause, siano risultati positivi al test. La combinazione di questi dati
può talvolta arrivare a distorcere la rappresentazione dell’epidemia
come accade, per esempio, per la stima della letalità e cioè del
rapporto percentuale tra morti e contagiati: se in una fase di
espansione del contagio il numero dei test effettuati non cresce in
modo corrispondente e quindi una quota rilevante di positivi non
viene censita, la proporzione dei decessi sul totale dei positivi
osservati tende inevitabilmente ad aumentare come è successo in
Lombardia, dove la letalità apparente è cresciuta in un breve
intervallo temporale dal 4% al 13%.
Nonostante limiti e incertezze nel descrivere in modo puntuale
l’epidemia, queste cifre ci restituiscono comunque un quadro
tempestivo e indispensabile sul suo andamento e sull’efficacia delle
misure adottate per contrastarla; quello che questi numeri non ci
raccontano è invece l’impatto dell’epidemia sulla salute della
popolazione, cosa succede insomma per effetto dell’epidemia al di
fuori di quelli che in questa descrizione ne sarebbero i confini.
Per provare a valutare questa dimensione è interessante
confrontare la mortalità generale nel 2020, soprattutto nel periodo
corrispondente alla comparsa dell’epidemia di coronavirus con la
mortalità degli anni precedenti. Questo approccio consente di
osservare in che misura l’epidemia abbia influenzato la mortalità, a
prescindere dalle cause specifiche alle quali i decessi sono stati
attribuiti, e di avere quindi un quadro d’insieme del suo impatto
(
Figura 1).
Figura 1. Andamento stagionale della mortalità per
settimana nelle città italiane* (gennaio 2016 – 17 marzo 2020)
http://www.epiprev.it/sites/default/files/SISMG_COVID19_28032020-2.pdf
La
Figura 1 è stata estratta dal rapporto più recente del Sistema
di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) gestito dal
Dipartimento di Epidemiologia del SSR Lazio-ASL Roma 1, su
incarico del Ministero della Salute, e mostra l’andamento della
mortalità settimanale tra il 2016 e il 2020 per la popolazione di età
uguale o superiore ai 65 anni in 18 città italiane confrontandola con la
mortalità media dei 5 anni precedenti.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo