Le incredibili curiosità di Genova – Laura Guglielmi
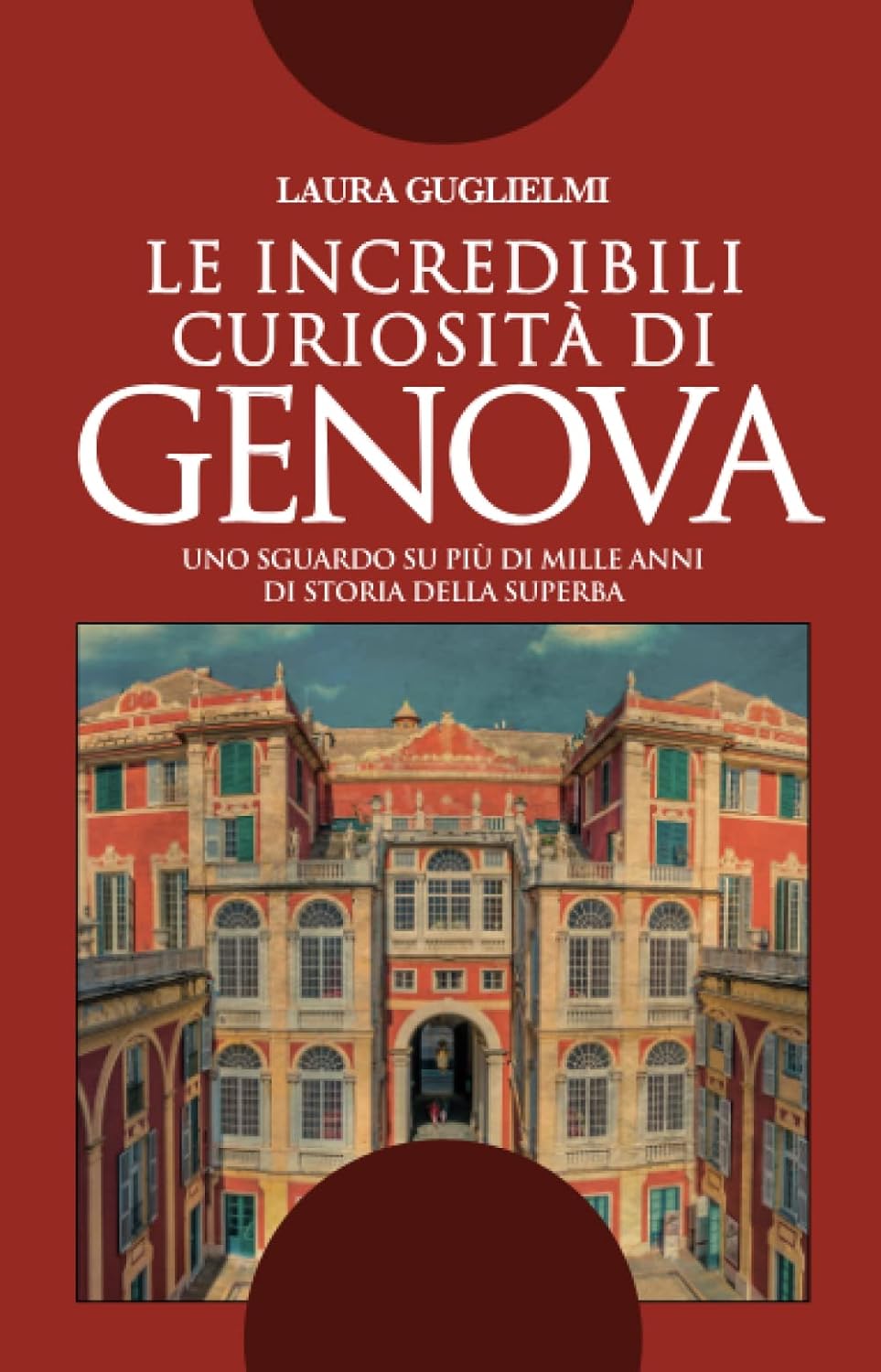
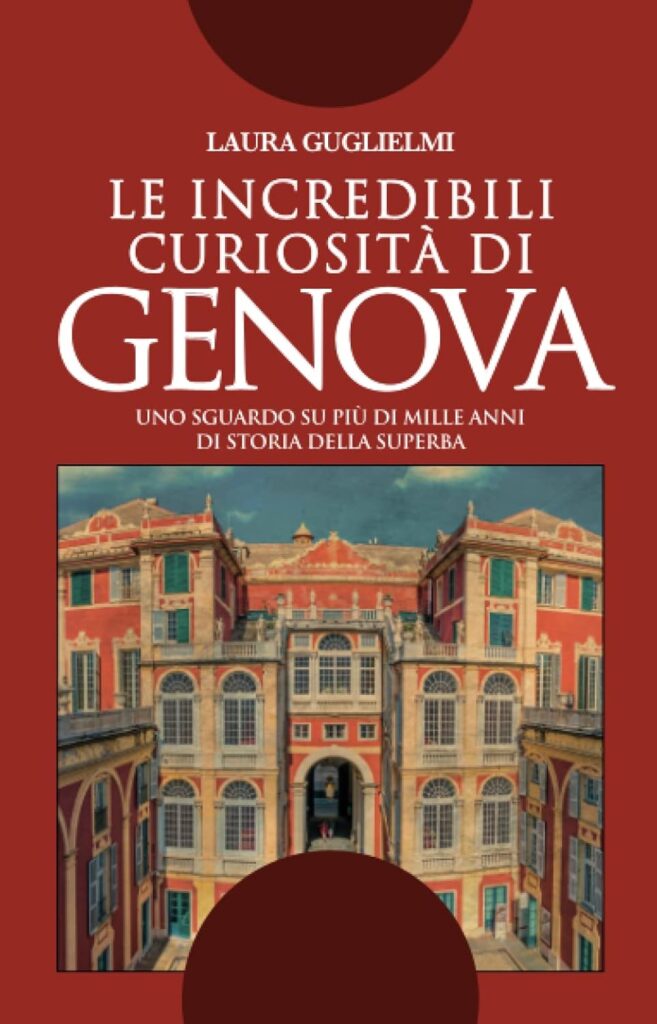
SINTESI DEL LIBRO:
Guglielmo Embriaco, chi era costui? Oggi è sconosciuto ai più,
eppure è stato protagonista di un momento fondamentale della storia
dell’Occidente. Simbolo della Genova marinara e medievale,
guerriero e mercante, venne soprannominato Testa di Maglio, che
significa qualcosa come “testa di martello”. Non doveva essere una
persona affabile.
Le sue imprese di guerra furono immortalate negli Annali del
Caffaro, che fu un grande testimone di quel periodo, partecipò alla
spedizione in Terrasanta e alla dieta di Roncaglia. Anche il grande
poeta Torquato Tasso parlò dell’Embriaco nella Gerusalemme
Liberata: «Guglielmo, il Duce Ligure che pria / Signor del Mar
corseggiar solia».
Per il peso che ebbe nella storia di quel periodo dovrebbe essere
ricordato di più, come d’altra parte Andrea Doria. È forse colpa
dell’isolamento della città, appoggiata sul mare al riparo delle sue
montagne scoscese, una vera barriera che ancora oggi rende difficili
le comunicazioni? Un mistero difficile da risolvere.
Ritornando all’Embriaco, piano piano si fece conoscere a Genova,
fino a diventare uno degli uomini più potenti. Nel 1099 salpò a capo
di due sole navi per la Crociata in Terrasanta, insieme al fratello
Primo. Giunse a Giaffa, il porto più vicino a Gerusalemme, nel mese
di giugno. Con i suoi uomini si diresse verso l’entroterra, la Città
santa distava dal mare una sessantina di chilometri. Quando
arrivarono in vista delle mura, i genovesi stanchi, affamati e male
armati si unirono agli altri Crociati.
La
situazione era disperata, come fare a conquistare
Gerusalemme? Testa di Maglio portò a compimento un’impresa, le
cui gesta sembrano uscire dall’Odissea o dall’Eneide. Ce la racconta
sempre il Caffaro: l’Embriaco ha paura che i saraceni distruggano le
uniche due galee, ancorate nel porto di Giaffa. Le fa smontare e
trasportare a Gerusalemme. Da bravo genovese, ricicla il materiale
per costruire due torri di legno, vere e proprie macchine da guerra,
pronte per l’assedio. Ci riesce e i Crociati conquistano la Città santa.
Chi volesse oggi vedere una scena di questa epica battaglia, non
ha che da visitare la cappella di Palazzo Ducale, nel centro di
Genova. Il conflitto è al suo culmine e sulla torre costruita con il
legno delle galee stazionano decine di uomini armati di tutto punto,
mentre altri soldati salgono con le scale. È un affresco del Seicento
del pittore genovese Giovanni Battista Carlone.
Quando Embriaco tornò a casa, ebbe il suo momento di gloria. Nel
frattempo, Goffredo di Buglione fece incidere sopra la porta del
Santo Sepolcro Praepotens Genuensium Praesidium, per ricordare
le strabilianti gesta dei genovesi.
Ormai in città era l’uomo più potente, infatti poco tempo dopo gli
affidarono trentadue imbarcazioni e, si narra, quattromila uomini per
tornarsene in Terrasanta e combattere i turchi, conquistando altri
lucrosi territori. Quindi Testa di Maglio tornò a Giaffa e incontrò
Baldovino di Buglione, fratello di Goffredo, con il quale decise di
conquistare Arsuf e Cesarea alla cristianità. Una bella scusa per il
nostro genovese che non vede l’ora di tornarsene in patria con il
bottino. Così come i suoi uomini, che sudano remando nelle galere.
In realtà non sono schiavi, sono liberi e con l’idea fissa in testa di
guadagnare il più possibile da questa impresa. Ricorrere ai buoni
sentimenti e ai sacri valori per giustificare le guerre è una cosa che è
sempre andata e va ancora di moda. Poi quando mai i genovesi
avrebbero investito così tanti denari in galee, equipaggio, armi e
viveri, per riconquistare la Terrasanta, solo per timor di Dio e senza
averne un tornaconto?
Giovanni Battista Carlone, Guglielmo Embriaco alla conquista di
Gerusalemme, Genova, Palazzo Ducale (foto di Davide Papalini, su
licenza Wikimedia Commons).
Arsuf cadde subito nelle mani dei Crociati. Cesarea invece
resistette.
«Salite, salite e prendete in fretta la città!», si sono appena rotti i
grandi pioli di una delle scale appoggiate alle mura, e molti Crociati
sono precipitati a terra, ma Testa di Maglio è già in cima. L’assedio di
Cesarea è appena iniziato e il nostro sta incitando i suoi uomini a
non scoraggiarsi, a prendere possesso delle mura e a invadere la
città. Scrive il Caffaro: «E tutti allora si inerpicarono, con eguale
audacia per il muro, e di lassù balzarono a inseguir i Saraceni che
fuggendo […] cadean morti sotto lor furia».
Apriamo una parentesi: nelle cronache del tempo vengono chiamati
saraceni tutti gli islamici, ma in realtà in Terrasanta c’erano i turchi
Fatimidi. I saraceni erano le popolazioni del Nord Africa di origine
araba, che nulla avevano a che vedere con i turchi, religione a parte.
Correva l’anno 1001: i Crociati entrarono a Cesarea, la
conquistarono, e si portarono a casa il ricco bottino che tutti
bramavano, tra cui un piatto esagonale verde smeraldo, che
secondo alcuni sarebbe il mitico Sacro Graal, il piatto usato da Gesù
durante l’Ultima Cena, ancor oggi custodito nel museo del Tesoro
della Cattedrale di San Lorenzo. I genovesi lo chiamano, con il loro
solito understatement, il Sacro Catino.
Che sia o no il Sacro Graal, che esista o sia un’invenzione, molti
personaggi famosi, ospiti di Genova, ne hanno parlato. Lo scrittore
inglese John Ruskin nel 1840 lo definì, con un disprezzo perfino
eccessivo, «un falso pezzo di vetro», mentre il francese Alexandre
Dumas, l’autore dei Tre moschettieri, nel 1841 scrisse: «Tra le
numerose curiosità, la chiesa di San Lorenzo racchiude il famoso
piatto di smeraldo nel quale, secondo quanto si dice, Gesù Cristo
consumò la cena e che fu donato a Salomone dalla regina di Saba».
Diatribe a parte sulla leggenda del Sacro Graal, il sacco di Cesarea
e il Sacro Catino sono i simboli di un momento cruciale nella storia
della città. Genova mette le basi per lo sviluppo di un’estesa rete di
snodi commerciali e fondaci nel Mediterraneo che tanta ricchezza
porteranno nei secoli a venire. Diventerà una potenza economica di
tale forza che Testa di Maglio mai avrebbe immaginato, quando
lassù in cima alle mura di Cesarea incitava i suoi uomini.
Se si vuole incontrare oggi l’Embriaco, basta mettersi davanti
all’entrata principale di Palazzo San Giorgio, dando le spalle alla
rumorosa sopraelevata. In cima all’entrata, campeggia la figura del
santo che uccide il drago. Sotto l’imponente san Giorgio,
troneggiano sei statue dipinte all’interno di finte nicchie, il quarto da
sinistra è proprio lui, l’Embriaco, e alla sua destra maestoso si erge
un altro genovese ben più famoso, Cristoforo Colombo, che se ne
andò senza mai più tornare.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo