Le guarigioni del cervello- Le nuove strade della neuroplasticità- terapie rivoluzionarie che curano il nostro cervello – Norman Doidge
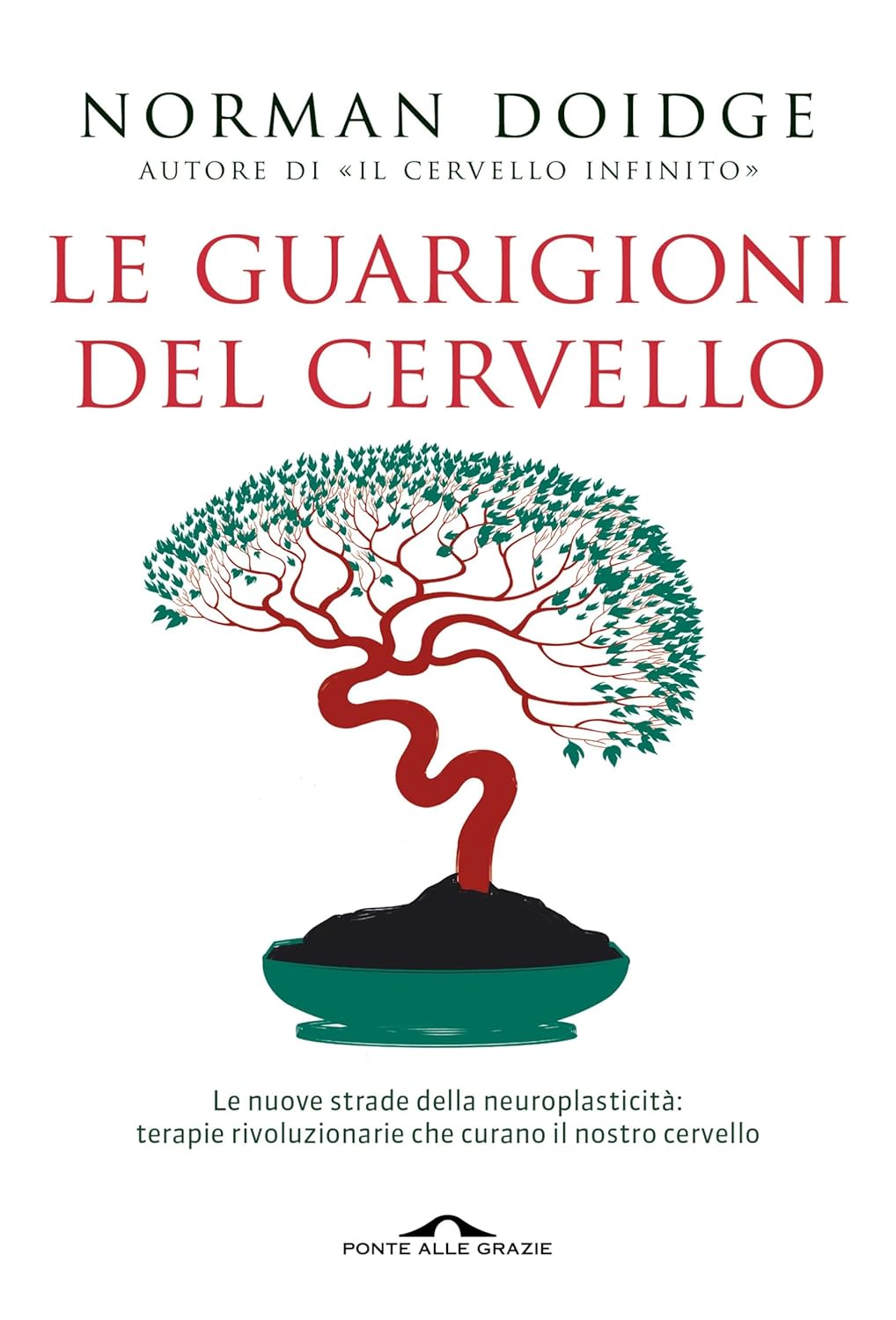
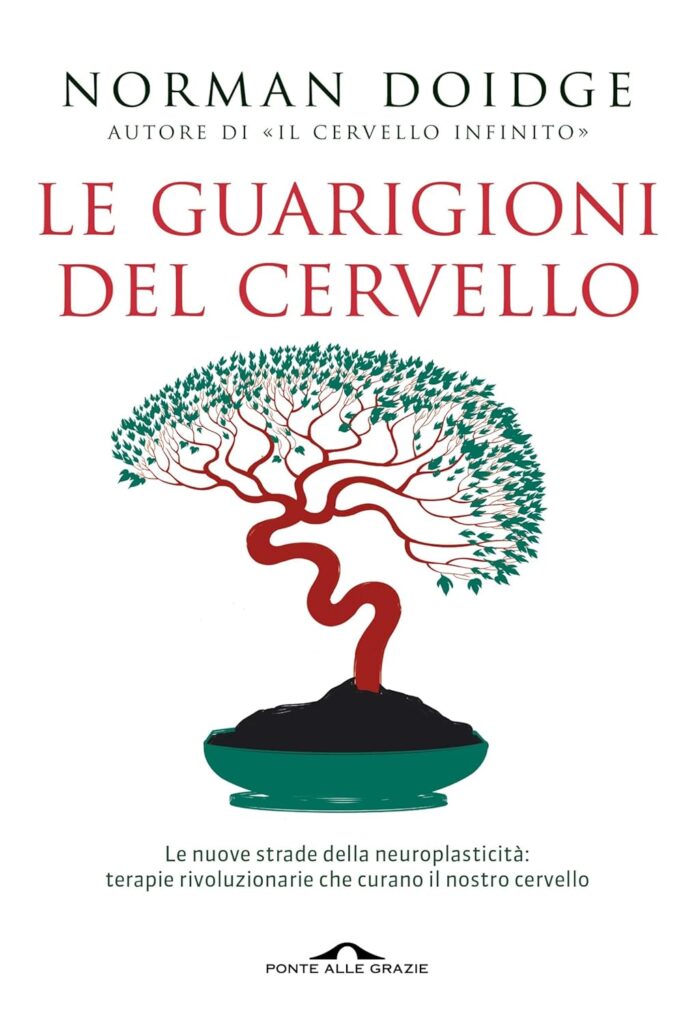
SINTESI DEL LIBRO:
Il 26 giugno 1999, quando aveva quarantanove anni, Moskowitz e un
amico si introdussero nella discarica locale di San Rafael poiché
erano venuti a sapere che vi venivano tenuti i carri armati e altri
veicoli bellici per la parata del 4 luglio. Moskowitz non resistette alla
tentazione di arrampicarsi sulla torretta di un carro armato. Quando
saltò giù, un rebbio di metallo a cui erano fissate le taniche di
benzina sulla fiancata del mezzo gli agganciò i pantaloni di velluto a
coste. Cadendo, la gamba rimase bloccata, e Moskowitz udì tre
«crepitazioni»: il femore, l’osso più lungo del corpo, si era fratturato.
Quando guardò la gamba, vide che era piegata a sinistra di un
angolo di novanta gradi. «Ero un po’ troppo vecchio per stare su
jeep e carri armati. Quando in seguito ne parlai con un amico, un
avvocato specializzato in casi di lesioni personali, mi disse: ‘Sarebbe
stato un bel caso, se avessi avuto sette anni’».
Come specialista in medicina del dolore, Moskowitz ne approfittò
per studiare un fenomeno che aveva insegnato ai suoi studenti ma di
cui non aveva mai avuto esperienza, e che avrebbe svolto un ruolo
centrale nella sua ricerca nel campo della neuroplasticità. Subito
dopo la caduta, il dolore era pari a 10/10, secondo la scala di
valutazione utilizzata dai medici. Il dolore viene classificato da 0/10 a
10/10 (10 equivale a immergersi nell’olio bollente). Moskowitz non
sapeva se sarebbe mai riuscito a sopportare un 10/10. Adesso lo
sapeva.
«La prima cosa che pensai fu: come farò ad andare al lavoro
lunedì?» mi disse. «La seconda cosa di cui mi resi conto, mentre ero
sdraiato immobile a terra in attesa dell’ambulanza, era che, dopo
aver smesso di muovermi, non sentivo più alcun dolore. Pensai: ‘Ehi,
funziona!’ La mia mente aveva semplicemente spento il dolore
qualcosa che insegnavo ai miei studenti da anni. Avevo
sperimentato in prima persona che il cervello, da solo, può
‘spegnere’ il dolore, proprio come io, uno specialista del dolore,
cercavo di fare con i pazienti ricorrendo a farmaci, iniezioni e
stimolazioni elettriche. Se rimanevo immobile, nel giro di un minuto il
dolore scompariva.
«Quando arrivò l’ambulanza, mi diedero sei milligrammi di morfina
per endovena. Dissi: ‘Datemene altri otto’. Loro ribatterono: ‘Non
possiamo’, e io risposi: ‘Sono un medico del dolore’, allora lo fecero,
ma quando mi spostarono il dolore tornò a 10/10».
Il cervello può annullare il dolore perché la funzione del dolore
acuto non è quella di tormentarci, ma di metterci in guardia da un
pericolo. Anche se «pena» viene dal greco poine, «punizione»,
attraverso il latino poena, da cui deriva anche il termine inglese pain,
dal punto di vista biologico il dolore non è una punizione fine a se
stessa. Il sistema del dolore è una forma di difesa del corpo, un
sistema di segnalazione che ci «premia» e ci «punisce»: ci punisce
quando stiamo per fare qualcosa che potrebbe danneggiare
ulteriormente il corpo, e ci premia alleviando il dolore quando ci
fermiamo.
Se Moskowitz fosse rimasto immobile, non avrebbe corso alcun
pericolo. Il medico sapeva anche che il «dolore» non era situato
nella gamba. «Tutto ciò che faceva la mia gamba era inviare segnali
al cervello. Quando ci sottoponiamo a un’anestesia generale, che
addormenta certe regioni cerebrali, il cervello non elabora questi
segnali, e non sentiamo alcun dolore». Ma perché l’anestesia
generale sia efficace è necessario perdere conoscenza; invece
Moskowitz era sdraiato a terra agonizzante e all’improvviso il suo
cervello perfettamente conscio aveva «spento» il dolore. Se solo
fosse riuscito a capire come usare quell’interruttore coi suoi pazienti!
Ma non solo il movimento avrebbe potuto mettere in pericolo
Moskowitz. Mentre aspettava l’ambulanza, rischiò di morire, perché
circa metà del suo volume sanguigno era affluito nella gamba, che si
era gonfiata più del doppio rispetto al normale: «La mia gamba era
grossa come il mio petto». Con tutto quel sangue che ristagnava
nella gamba da ore, fu un miracolo che Moskowitz non morì per la
carenza di afflusso sanguigno agli organi vitali. Ma riuscì ad arrivare
in ospedale, dove «il chirurgo mi inserì nella gamba la placca più
grande, dicendo che, se fosse stato necessario applicare anche solo
un’altra vite, avrebbero optato per l’amputazione».
e
Durante l’intervento chirurgico Moskowitz rischiò di morire altre
due volte, prima per un embolo – un grumo di sangue – che avrebbe
potuto bloccarsi nei polmoni o nel cervello; poi il catetere per il
drenaggio dell’urina gli perforò la prostata. La temperatura corporea
salì
Moskowitz fu colpito da choc settico, un’infezione
potenzialmente fatale che coinvolge tutto il corpo. La pressione
sanguigna precipitò a 80/40.
Ma sopravvisse, e imparò un’altra lezione sul dolore: la
somministrazione di una dose più alta di morfina nella fase di dolore
acuto aveva impedito ai suoi nervi di subire una stimolazione
cronica, evitando l’insorgenza di una sindrome da dolore cronico.
(Questa era la ragione per cui aveva chiesto altra morfina per sedare
il dolore acuto.) Nonostante la gravità dell’incidente, nel corso degli
anni Moskowitz ha sofferto pochissimo alla gamba, e può
camminare anche per un paio di chilometri, come abbiamo fatto
lungo la spiaggia alle Hawaii, senza sentire dolore.
Il
fatto che il cervello sia in grado di spegnere il dolore così
all’improvviso va contro il «senso comune» secondo cui il dolore
viene dal corpo. La visione scientifica tradizionale, formulata dal
filosofo francese Cartesio quattro secoli fa, sostiene che, quando ci
procuriamo una ferita, i nervi inviano un segnale a senso unico al
cervello, e che l’intensità del dolore è proporzionale alla gravità della
ferita. In altre parole, il dolore redige un rapporto accurato sull’entità
della lesione, e il cervello si limita ad accettare quel rapporto.
Ma questa visione venne ribaltata nel 1965, quando i
neuroscienziati Ronald Melzack (un canadese che studiava il dolore
e gli arti fantasma) e Patrick Wall (un inglese che studiava il dolore e
la plasticità) pubblicarono l’articolo più importante nella storia del
dolore, «Pain Mechanisms: A New Theory» («Meccanismi del
dolore: una nuova teoria»).
4Secondo Wall e Melzack, il sistema di
percezione del dolore è diffuso nel cervello e nel midollo spinale; il
cervello non si limita affatto a ricevere le informazioni dal corpo, ma
controlla la quantità di dolore che percepiamo. La «teoria del
cancello» (gate control theory of pain) di Melzack e Wall proponeva
che, quando i messaggi dolorosi vengono inviati dal tessuto
danneggiato attraverso il sistema nervoso, devono passare diversi
controlli, o «cancelli», a cominciare dal midollo spinale, prima di
raggiungere il cervello. Questi messaggi vengono trasmessi solo se
il cervello concede loro il «permesso» di farlo, dopo aver stabilito se
sono abbastanza importanti. (Quando nel 1981 il presidente Reagan
venne raggiunto al petto da un colpo di pistola, inizialmente rimase
in piedi, e né lui né gli uomini dei servizi segreti si resero conto di
quanto era accaduto. In seguito Reagan scherzò: «Non mi avevano
mai sparato prima, tranne che nei film. Allora ti comporti sempre
come se faccia male. Adesso so che non è sempre così».) Se «il
permesso viene accordato» e il segnale può raggiungere il cervello,
si aprirà un cancello e la sensazione di dolore aumenterà facendo sì
che certi neuroni si attivino e trasmettano l’informazione. Ma il
cervello può anche chiudere un cancello e bloccare il segnale
doloroso tramite il rilascio di endorfine, gli analgesici prodotti dal
nostro corpo per sedare il dolore.
Prima dell’incidente, Moskowitz insegnava ai suoi allievi gli sviluppi
più recenti della teoria del cancello, e che ci sono degli interruttori a
controllare i cancelli. Ma sapere che questi interruttori esistono è un
conto; ben altra cosa è sapere come spegnerli quando siamo in
preda al dolore.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo