Uomini e città della Resistenza: Discorsi, scritti ed epigrafi – Piero Calamandrei

SINTESI DEL LIBRO:
[Discorso tenuto il 28 febbraio 1954 al Teatro Lirico di Milano alla presenza di
Ferruccio Parri.]
A dieci anni di distanza da quel periodo, dall’8 settembre del ’43 al 25
aprile del ’45, al quale nel linguaggio comune si dà più propriamente il
nome di periodo della Resistenza, comincia ad essere possibile, volgendosi
indietro, cercar di intenderne, a distanza di un decennio, il significato
storico.
Possibile, ma non facile. Perché dieci anni sono ancora pochi per poter
riconsiderare quegli eventi con la distaccata serenità dello storico. Quei
fatti sono ancora, per chi li ha vissuti, passione e dolore: le cicatrici dentro
di noi dolgono ancora; certe ferite sono ancora aperte; e a rivederci innanzi
certe facce, e risentir certi nomi, ci si accorge che il lutto e lo sdegno è
ancora immutato.
E poi è risaputo che ogni giudizio storico, anche di eventi che paion
lontani nel tempo, è sempre un giudizio sul presente e, insieme, una
interrogazione indirizzata all’avvenire. Cercare che cosa fu la Resistenza,
vuol dire indagare dentro di noi che cosa è rimasto di vivo della Resistenza
nelle nostre coscienze; che cosa si è tramandato in noi di durevole e
quotidiano da quel tempo che già par leggendario, e che cosa ci sentiamo
ancora capaci di tramandare di quel tempo a coloro che verranno dopo di
noi: se veramente, da quel che di nuovo accadde allora nel mondo,
qualcosa si è rinnovato dentro di noi e intorno a noi, oppure se, chiuso
quel periodo d’altri tempi, tutto è ritornato e ritornerà come prima, e
rimarrà soltanto l’inutile rimpianto e il rammarico avvilente di non essere
stati degni di quel monito, trasvolato via, occasione per sempre perduta, in
quei cieli eroici.
Mai come questa volta è vero che fare la celebrazione del passato vuol dire
guardar dentro di noi e fare il nostro esame di coscienza.
In queste celebrazioni, che noi facciamo nel decennale della Resistenza,
di fatti e di figure di quel tempo, noi ci illudiamo di esser qui, vivi, che
celebriamo i morti. E non ci accorgiamo che sono loro, i morti, che ci
convocano qui, come dinanzi a un tribunale invisibile, a render conto di
quello che in questi dieci anni possiamo aver fatto per non essere indegni
di loro, noi vivi. In tutte le celebrazioni torna, ripetuta in cento variazioni
oratorie, una verità elementare che nelle lettere dei condannati a morte è
espressa come una naturale e semplice certezza: che i morti non hanno
considerato la loro fine come una conclusione e come un punto d’arrivo,
ma piuttosto come un punto di partenza, come una premessa, che doveva
segnare ai superstiti il cammino verso l’avvenire. Questa non è una frase
retorica, non è un artificio pietoso destinato a consolare le madri di averli
perduti: è che veramente noi sentiamo, quasi con la immediatezza di una
percezione fisica, che quei morti sono entrati a far parte della nostra vita,
come se morendo avessero arricchito il nostro spirito di una presenza
silenziosa e vigile, con la quale ad ogni istante, nel segreto della nostra
coscienza, dobbiamo tornare a fare i conti. Quando pensiamo a loro per
giudicarli, ci accorgiamo che son loro che giudicano noi: è la nostra vita,
che può dare un significato e una ragione rasserenatrice e consolante alla
loro morte; e dipende da noi farli vivere o farli morire per sempre.
Dieci anni. Ricordate, amici, in che condizione era l’Italia dieci anni fa,
nel febbraio del 1944? Non importa andare a leggerlo sui libri; ciascuno di
noi può leggere dentro di sé, nei suoi ricordi personali, dov’era, che cosa
faceva; quel che soffriva, quel che temeva, quel che sperava; quali erano le
angosce di quelle notti senza sonno: il silenzio di quelle strade notturne e
l’avvicinarsi di quel passo ferrato. Il paese era diviso in due tronconi
sanguinanti: fuoco in cielo, rovine e tortura in terra. L’Italia era diventata
uno dei campi di battaglia della guerra mondiale. Il mese di febbraio fu un
mese particolarmente duro: rastrellamenti, rappresaglie, incendi di paesi
innocenti; il fronte, dopo la distruzione di Cassino, stagnava sul Volturno;
lo sbarco ad Anzio, che aveva dato tante speranze di pronta liberazione,
pareva fallito: i giornali fascisti davano la notizia che ad Anzio si preparava
una nuova Dunkerque. Churchill alla Camera dei Comuni dichiarava, il
24 febbraio, che «le operazioni in Italia proseguiranno lente e difficili».
Un’agonia.
Forse non ripensiamo abbastanza a quella agonia: forse non apprezziamo
abbastanza quello che si è fatto, quello che ha fatto il popolo italiano in
questi dieci anni, da allora ad oggi: tutto quello che nel campo morale e in
quello materiale allora non avevamo più e che oggi abbiamo. Quando si
ripensa a quelle rovine, a quel sangue, a quei fumi di incendi, alle fughe,
alle torture; ai campi di concentramento, alle camere a gas; alla fame, allo
squallore, alle donne che facevano la fila sotto le cannonate per riuscire a
riempire un fiasco d’acqua, e paragoniamo tutti quegli orrori con quest’aria
di apparente ordinato benessere, perfino di gaudente euforia, che si respira
oggi in certe grandi città italiane, quasi vien fatto, misurando tutto quello
che si è potuto recuperare in dieci anni, di gridare al miracolo.
Eppure non è tutto qui. Non è questo, non è soltanto questo. Ci si
guarda intorno e si sente intorno a noi, dopo dieci anni, un che di vuoto,
un che di amaro. Quando ripensiamo a quegli orrori e al giorno in cui
finalmente finirono, e gli uomini si ritrovarono liberi, con la barba
cresciuta e il viso emaciato, ma finalmente liberi, e si abbracciavano come
fratelli per le strade, quando ripensiamo a quei giorni della liberazione e
guardiamo quelli d’oggi, ci prende alla gola un senso di delusione, di
rimpianto, quasi di nostalgia... Sono tornate oggi tante cose piacevoli e
comode che allora avevamo perdute: ma quello che di vivo, di nuovo, di
giovanile, di fresco, di umano c’era allora nei cuori e nell’aria, quello che
allora c’era, oggi non c’è più...
Questo senso di rinnovamento che allora si respirava d’intorno, da
nessuno l’ho sentito rievocare con più ingenua immediatezza che in un
diario di guerra, purtroppo non conosciuto in Italia come meriterebbe,
scritto da una donna in inglese. Questa donna aveva raccolto in una sua
villa solitaria sperduta nel Senese, in mezzo ai boschi e alle crete della Val
d’Orcia, una cinquantina di bambini scampati ai bombardamenti delle
città: credeva di averli raccolti in un luogo sicuro, dove la guerra non li
avrebbe raggiunti; e invece la guerra, salendo su su per l’Italia come una
lingua d’incendio, arrivò, nel giugno del 1944, anche lì. Ecco che alla villa
trasformata in asilo arrivano i tedeschi in ritirata: il bombardamento degli
alleati che avanzano bersaglia tutt’intorno le campagne. Ma i tedeschi
ordinano ai bambini di sloggiare subito, nonostante il bombardamento; e
in questo diario c’è la descrizione, che tien sospeso il respiro del lettore, di
questa fuga spietatamente imposta a cinquanta bambini attraverso i campi
di grano battuti dall’artiglieria, sotto la guida di questa donna sola, a sbalzi,
tra una granata e l’altra, per venti chilometri: sotto il sole, fino ad arrivare al
paese più prossimo, dove dalle mura la popolazione li attende sventolando i
fazzoletti per incoraggiarli. Alla fine sono tutti in salvo: e poi, poco dopo,
arrivano gli inglesi; e poi la guerra è passata: e i bambini con lei alla testa
tornano alla villa, cantando questa volta a voce spiegata. Ma la villa è
crollata: e tra le macerie ci sono i cadaveri di due partigiani: e tutto è da
ricominciare, tutto è da ricostruire.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
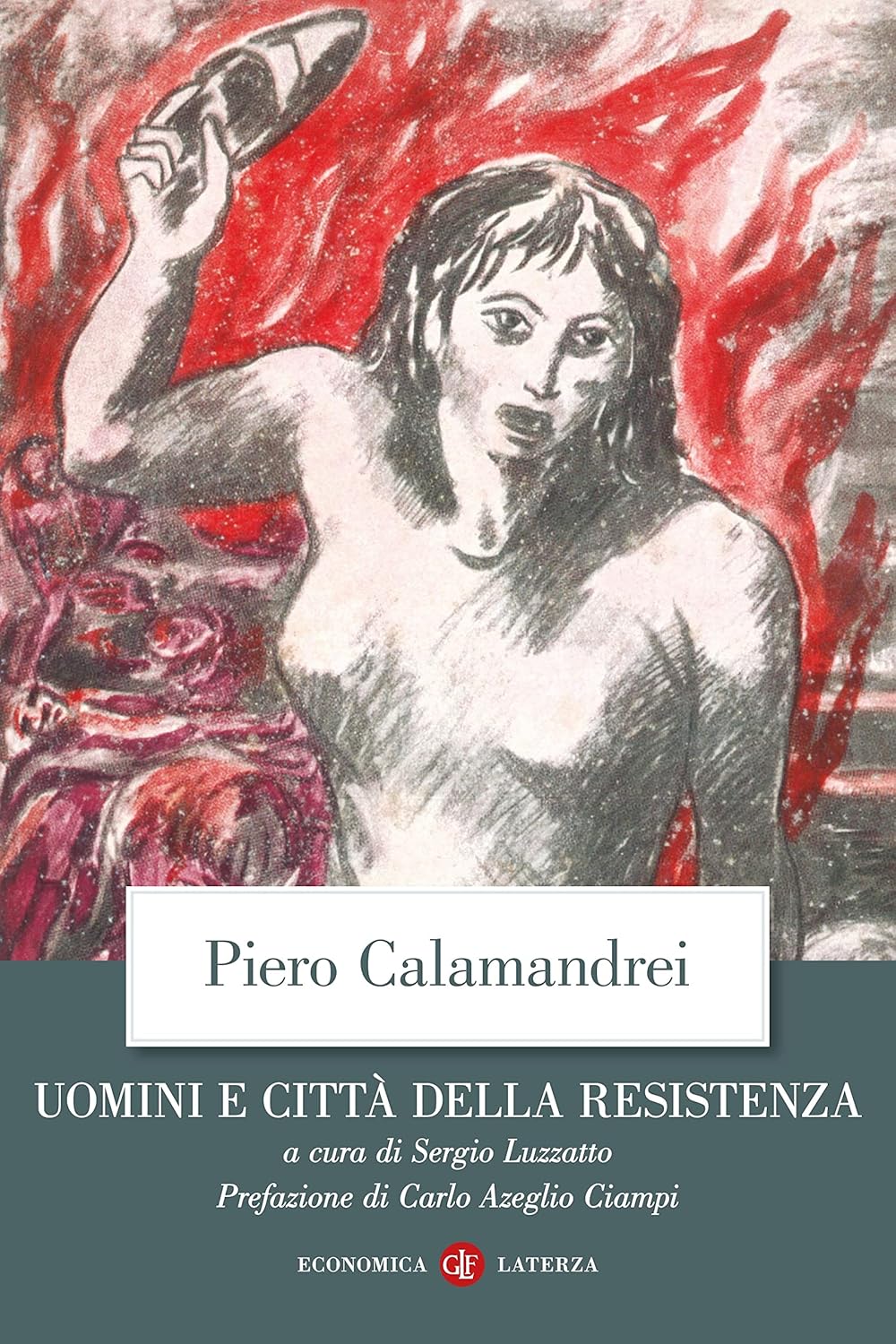






Commento all'articolo