Vivere la democrazia – Stefano Rodotà

SINTESI DEL LIBRO:
L’identità – la sostanza di ciò che siamo e del modo in cui siamo in
relazione con gli altri – si trova nel mezzo di un’epoca di straordinario
tumulto»
1
. Così, qualche tempo fa, veniva descritta la situazione
determinata dal vivere sempre più intenso della persona in Rete, dalla sua
proiezione nel cyberspazio. Quel tumultuoso vivere ha generato una
identità descritta come interamente nuova, una identità appunto «digitale»,
che si distacca, o almeno si allontana, da quella fisica. Le costruzioni più
intense, o estreme, di questo divaricarsi dell’identità ci portano tuttavia
sulle soglie di un «io diviso», ponendo immediatamente il problema di
come sfuggire a ricostruzioni che, consapevoli o no, offrono spazi aperti
alla penetrazione di logiche schizofreniche.
Al tempo stesso, però, bisogna prendere atto che le proposte di
«ricomposizione» dell’identità non possono tradursi in tentativi più o meno
forzati di riunificazione, ma esigono la presa d’atto della moltiplicazione
dei piani identitari, che non devono essere considerati come elementi di
un conflitto bensì di un continuo, difficile confronto.
Un benefico «tumulto», insomma, che ci dà il senso di una dinamica da
seguire e comprendere. Una dinamica, peraltro, che oggi appare con tratti
più marcati, poiché l’insieme delle tecnologie entra sempre più
direttamente nel corpo, lo scompone e lo ricostruisce, lo presenta con
aspetti che non eravamo abituati a prendere in considerazione.
Ma il tumulto è davvero tutto nuovo, l’identità è giunta al tempo digitale
con una compattezza che faceva della fisicità il suo più rilevante connotato?
La data della comparsa dell’identità personale e, con essa, di una storia fatta
dagli uomini, «può essere fissata con esattezza al 1694, quando John Locke
affronta il problema della personal identity nella seconda edizione del Saggio
sull’intelletto umano, coniando l’espressione stessa. Da allora, per oltre tre
secoli, la questione della consapevole permanenza nel tempo del proprio io
durante l’arco di un’unica vita [...] ha ossessionato la filosofia
dell’Occidente, incidendo sull’immagine che innumerevoli individui
hanno di se stessi. L’identità personale si rivela erede e surrogato
dell’anima, risulta dalla segreta elaborazione del lutto per lo scadere della
garanzia cristiana che assicurava all’individuo una durata senza fine»
2
.
Si può aggiungere che il sempre maggior diffondersi di un narcisismo
immediato e di una manipolazione ideologica del consumo plasmano
l’individuo con facili promesse di successo personale. «In questo modo si
realizza uno sterile appiattimento delle coscienze e un arido svuotamento
dell’individuo, che produce l’eclissarsi dell’idea stessa di persona, sempre
più ridotta a frammenti decontestualizzati, anche e proprio in ragione di
un autobiografismo diffuso e sempre più onnipresente, reso possibile dalla
tecnologia digitale e dalla creazione di spazi ‘autobiografici’ per
internauti»
3
.
Già queste due indicazioni, insieme alle tantissime altre che potrebbero
aggiungersi, mettono in guardia contro la tentazione di trasferire la
dialettica tra mondo reale e mondo virtuale in quella tra identità reale e
identità virtuale, quasi che qui si fosse determinata una inedita
discontinuità. Quando si dice che «noi siamo le nostre informazioni», si
descrive una situazione effettiva, dalla quale, tuttavia, non può essere tratta
la conclusione che vi è una separazione tra due identità, che convivono
l’una accanto all’altra. Siamo, invece, di fronte ad un modo nuovo di
costruire l’identità nel suo complesso o, meglio, ci troviamo a guardare con
occhio diverso alle sue diverse componenti e ai loro rapporti. Certo, vi
sono ancora molti casi in cui la fisicità si prende la sua rivincita. Ma troppe
volte si tratta di una fisicità frammentata nelle sue componenti biometriche
(il fondo dell’occhio, l’impronta digitale), che la degradano a password
necessaria per l’accesso al mondo digitale.
Ma il corpo fisico conosce il medesimo destino nel momento in cui si
presenta come oggetto perennemente connesso
4 a causa delle informazioni
che continuamente produce e trasmette. Anch’esso entra a far parte della
dimensione digitale, con effetti che possono determinare non solo una
diversa percezione della stessa fisicità, ma violazioni gravi della libertà e
della dignità della persona. Proprio nel momento in cui prendiamo atto del
nostro identificarci con le informazioni che ci riguardano, dobbiamo
renderci conto che la questione fondamentale diventa quella del loro
possesso e delle modalità delle loro utilizzazioni.
Mettendo al centro della sua analisi proprio i dati personali, Jason Lanier
si chiede a chi appartenga il nostro futuro
5
, e si interroga sulla possibilità
che la libera costruzione della personalità – alla quale si riferiscono
esplicitamente il paragrafo 2 del Grundgesetz e l’articolo 2 della
Costituzione italiana – sia ormai sottratta al potere individuale, mettendo
così in discussione gli stessi principi fondativi dell’ordine costituzionale, in
primo luogo quello di dignità.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
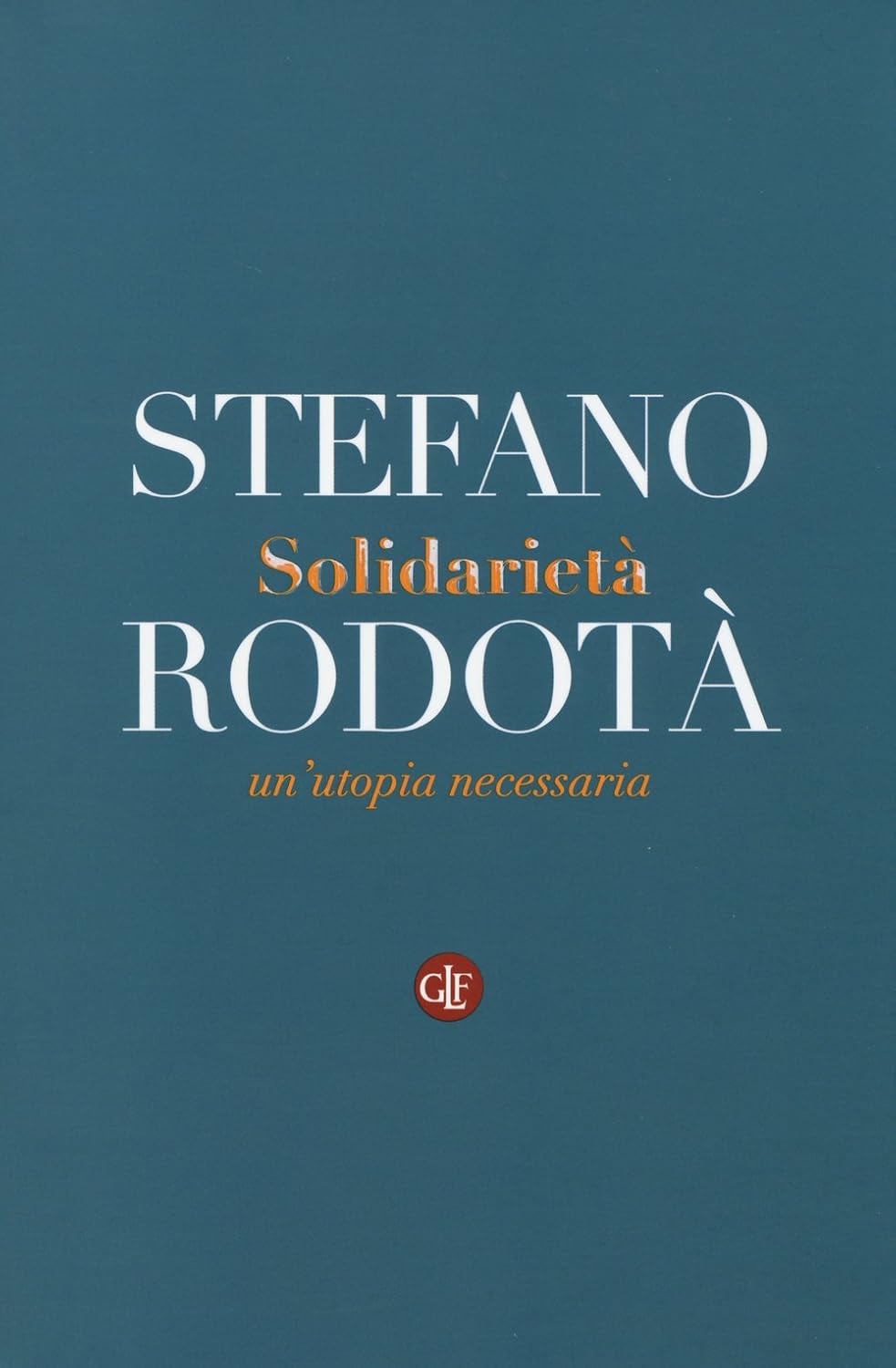






Commento all'articolo