La settima funzione del linguaggi – Laurent Binet
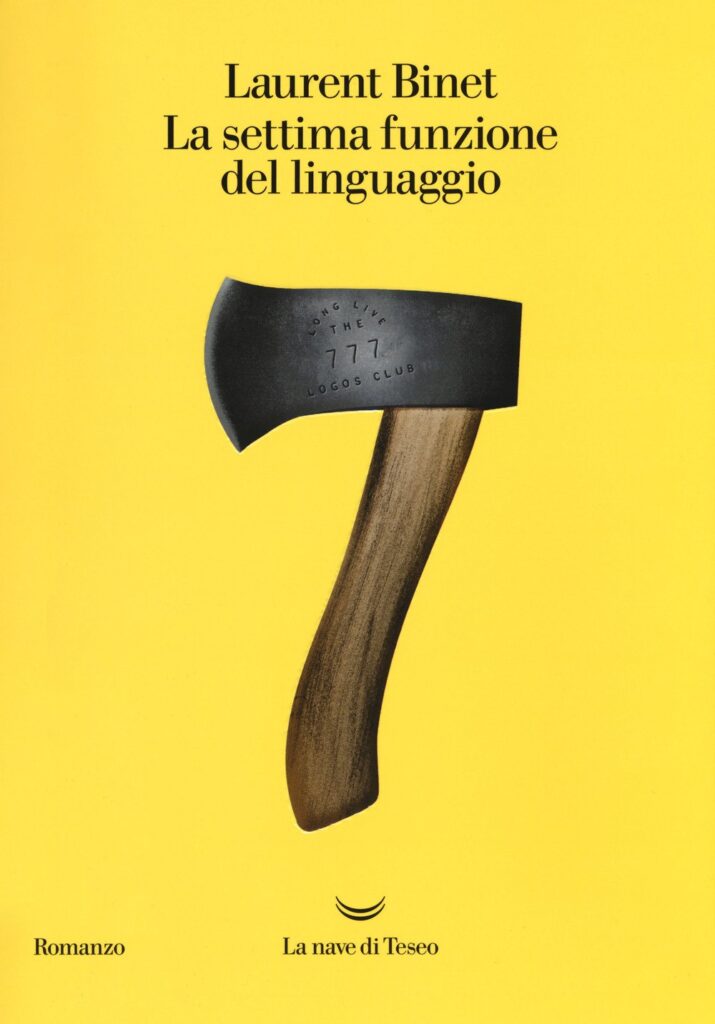
SINTESI DEL LIBRO:
La vita non è un romanzo. O almeno vorreste credere che sia così. Roland
Barthes risale Rue de Bièvre. Il più grande critico leerario del XX secolo
ha tue le ragioni per essere angosciato al massimo livello. Sua madre, con
cui aveva un rapporto molto proustiano, è morta. E il suo corso al Collège
de France, intitolato “La preparazione del romanzo”, si è risolto in uno
smacco che difficilmente può nascondersi: per tuo l’anno ha parlato ai
suoi studenti di haiku giapponesi, di fotografia, di significanti e significati,
di divertissements pascaliani, di camerieri del bar, di vestaglie o di posti in
aula magna – di tuo, tranne che del romanzo. E la cosa va avanti allo
stesso modo da quasi tre anni. Si rende perfeamente conto che il corso
stesso non è che una manovra dilatoria per rimandare l’inizio di un’opera
davvero leeraria, che renda cioè giustizia allo scriore ipersensibile che
sonnecchia in lui, e che, a parere di tui, ha iniziato a germogliare nei suoi
Frammenti di un discorso amoroso, che è già la bibbia di chi ha meno di
venticinque anni. Dopo Sainte-Beuve e Proust, è tempo di cambiare e di
prendere il posto che gli compete nel pantheon degli scriori. La mamma
è morta: dopo Il grado zero della scriura, il cerchio è chiuso. È giunta
l’ora.
La politica, sì sì, poi si vedrà. Non è che si possa dire che lui sia così
maoista, dopo il suo viaggio in Cina. E comunque, la politica non sta
aspeando lui.
Chateaubriand, La Rochefoucauld, Brecht, Racine, Robbe-Grillet,
Michelet, Mamma. L’amore di un ragazzo.
Mi chiedo se il quartiere era già pieno di negozi Vieux campeur.
Tra un quarto d’ora sarà morto.
Sono sicuro che il pranzo è stato buono, in Rue de Blancs-Manteaux.
Immagino che si mangi bene lì. In Miti d’oggi Roland Barthes decodifica i
miti contemporanei erei dalla borghesia a sua propria gloria ed è con
questo libro che è diventato davvero famoso; insomma, alla fine è stata la
borghesia a fare la sua fortuna. Ma la piccola borghesia. Il grande
borghese che si mee al servizio del popolo è un caso molto particolare
che merita un’analisi; bisognerebbe scriverci un articolo. Stasera? Perché
non subito? Ma no, deve anzituo scegliere le sue diapositive.
Roland Barthes affrea il passo senza notare nulla di ciò che gli sta
intorno, lui che pure è un osservatore nato, lui il cui mestiere consiste
nell’osservare e nell’analizzare, lui che ha passato la vita intera a cogliere
segni. Non vede leeralmente né gli alberi né i marciapiedi né le vetrine
né le macchine di Boulevard Saint-Germain, che conosce a memoria. Non
è più in Giappone. Non sente il morso del freddo. Sente appena il brusio
della strada. È un po’ come l’allegoria della caverna, ma al contrario: il
mondo delle idee in cui si è chiuso oscura la sua percezione del mondo
sensibile. Intorno a lui, vede soltanto ombre.
Le ragioni che ho appena richiamato per spiegare l’aeggiamento
sovrappensiero di Roland Barthes sono tue aestate dalla Storia, ma
voglio raccontarvi ciò che è davvero successo. el giorno, se Barthes ha
la testa altrove, non è solo a causa della morte di sua madre né è dovuto
alla sua incapacità di scrivere un romanzo o alla disaffezione crescente e,
dice lui, irrimediabile, dei suoi studenti. Non dico che non ci pensi, non ho
dubbi sulla natura delle sue nevrosi ossessive. Ma quel giorno c’è
dell’altro. In quello sguardo assente dell’uomo immerso nei suoi pensieri il
passante aento saprebbe riconoscere uno stato che Barthes credeva di
non saper provare più: l’eccitazione. Nella sua testa non ci sono solo sua
madre o i ragazzi o il suo romanzo fantasma. C’è la libido sciendi, la sete di
sapere, e con essa, riaivata, l’orgogliosa prospeiva di rivoluzionare la
conoscenza umana e forse di cambiare il mondo. Barthes si sente quindi
come Einstein, mentre pensa alla sua teoria nel momento in cui araversa
Rue des Écoles? Di sicuro non è molto aento a quel che ha intorno. Gli
restano poche decine di metri per arrivare al suo ufficio quando si fa
investire da un furgoncino. Il suo corpo produce quel suono opaco,
caraeristico, orribile, della carne che urta la lamiera, e rotola sulla strada
come una bambola di pezza. I passanti hanno un soprassalto. In quel
pomeriggio del 25 febbraio 1980 non possono sapere quello che è appena
avvenuto davanti a loro, e del resto ancora oggi il mondo lo ignora.
2.
La semiologia, o semiotica, è una cosa molto strana. È stato Ferdinand de
Saussure, il fondatore della linguistica, a intuirlo per primo. Nel suo Corso
di linguistica generale propone “una scienza che studi la vita dei segni nel
quadro della vita sociale”. Nient’altro. Aggiunge, come suggerimento per
coloro che vorranno dedicarsi all’impresa: “essa potrebbe formare una
parte della psicologia sociale e, di conseguenza, della psicologia generale;
noi la chiameremo semiologia (dal greco semeion, segno). Essa potrebbe
dirci in cosa consistono i segni, quali leggi li regolano. Poiché essa non
esiste ancora, non possiamo dire che cosa sarà; essa ha tuavia dirio a
esistere; le leggi scoperte dalla semiologia saranno applicabili alla
linguistica e questa si troverà collegata a un dominio ben definito
nell’insieme dei fai umani.” Mi piacerebbe se fosse Fabrice Luchini a
leggere questo passo, appoggiandosi sulle parole come sa fare lui, così che
il mondo intero possa percepirne, se non il senso, almeno tua la bellezza.
esta intuizione geniale, quasi incomprensibile per i suoi contemporanei
(il corso si svolge nel 1906), non ha perso nulla, un secolo dopo, né della
sua forza né della sua oscurità. Molti semiologi hanno in seguito cercato di
fornire delle definizioni sia più chiare sia più deagliate, ma si sono
contraddei gli uni con gli altri (talvolta senza rendersene neanche conto),
hanno confuso tuo e alla fine sono riusciti solo ad allungare (e comunque
a fatica) la lista dei sistemi di segni diversi dalla lingua: il codice della
strada, il codice mariimo internazionale, i numeri degli autobus, i numeri
delle camere d’hotel, e poi i gradi militari, l’alfabeto dei sordomuti… tuo
qui.
Un po’ poco rispeo all’ambizione iniziale.
Vista così, la semiotica, lungi dall’essere un’estensione del campo della
linguistica, sembra ridursi allo studio di protolinguaggi grossolani, molto
meno complessi e dunque molto più limitati di qualsiasi altra lingua.
Ma non è così.
Non è un caso che Umberto Eco, il grande professore di Bologna, uno
degli ultimi grandi semiotici, faccia così spesso riferimento alle grandi
invenzione decisive della storia dell’umanità: la ruota, il cucchiaio, il
libro… strumenti perfei, secondo lui, la cui efficacia è insuperabile. Tuo
lascia supporre che in effei la semiotica sia una delle invenzioni capitali
della storia dell’umanità e uno dei più potenti strumenti mai forgiati
dall’uomo, ma come con il fuoco o con l’atomo: all’inizio, non si sa bene a
cosa serva, come utilizzarla.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :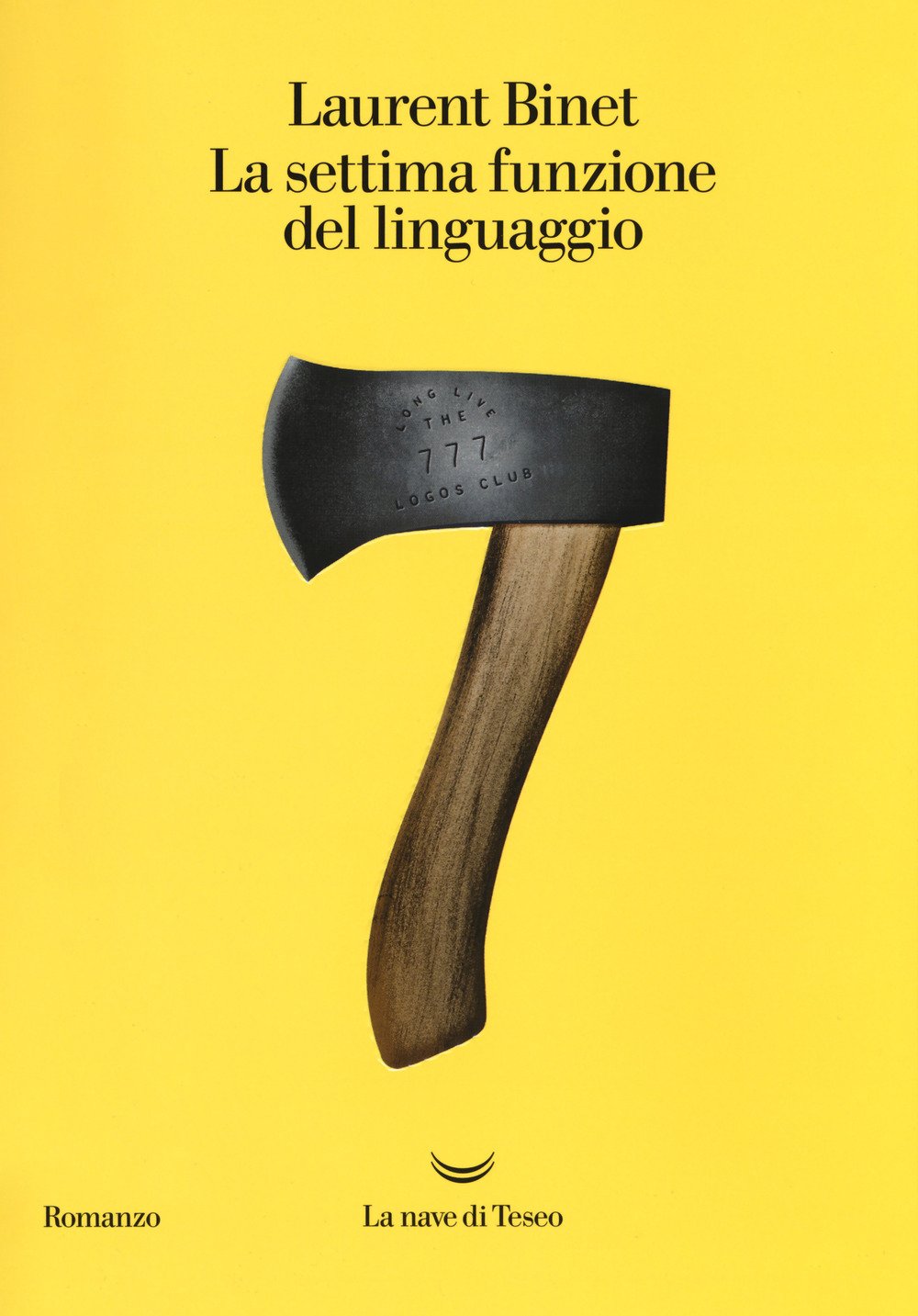






Commento all'articolo