La paura ci può salvare – Rosario Sorrentino
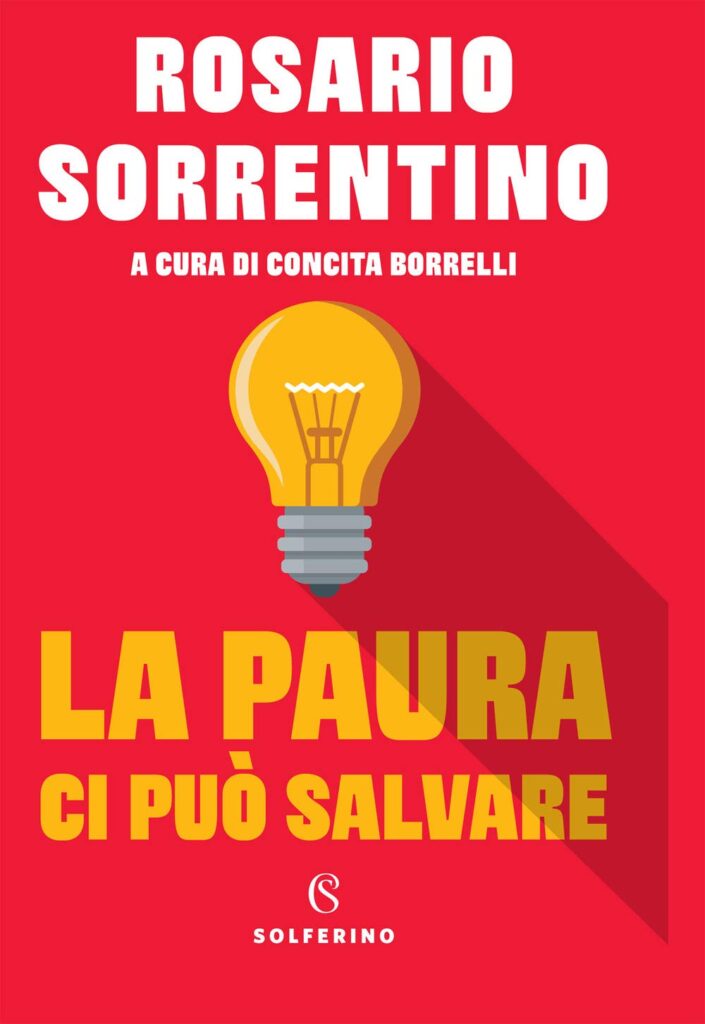
SINTESI DEL LIBRO:
Come posso convincere mia moglie che, mentre guardo fuori dalla
finestra, sto lavorando?» si chiedeva Joseph Conrad al principio del
secolo scorso. Noi, invece, quando guardiamo fuori dalla finestra,
come possiamo dire a noi stessi, senza soffrire, che stiamo
assistendo alla fine di un’epoca?
Quella in cui sono nati i nostri figli e nipoti, ma che loro non
conosceranno. L’epoca del più lungo e vacanziero periodo di pace e
prosperità nella storia dell’umanità. Il lutto è stato individuale e
collettivo. Abbiamo perso tanti cari, ma abbiamo perso anche il
nostro modo di stare nel nostro mondo. Esiste, eccome, il senso del
possesso e del legame nei confronti di un certo mood, di una certa
aria, di assetti lavorativi, di certe parole, di colonne sonore, di miti
dell’epoca, di abiti, di prossemica, di argomenti di discussione, di
architetture, di insofferenze, di passioni. Via. Spazzato via.
Dobbiamo rifare quasi tutto.
Siamo stati proiettati, con la potenza e l’accelerazione di una
palla di cannone, verso il futuro. E ora ci ritroviamo a fare i conti,
nostro malgrado, con la riorganizzazione del lavoro, della vita e dei
rapporti interpersonali. Ma non era il futuro di una volta, questo? Non
erano i nostri film di fantascienza?
Vi ricordate L’esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam? In quel
film del 1995 un virus viene liberato per punire la razza umana. E
qualcuno in questi mesi l’ha detto. Padre Benedict Mayaki, un
gesuita che ha imbarazzato il Vaticano, ha scritto: «I cambiamenti
nel comportamento umano dovuti alla pandemia del virus Covid-19
stanno portando benefici non intenzionali al pianeta». Come se la
riduzione dell’attività umana fosse da considerare sotto un aspetto
più che utile poiché sta avendo un beneficio non intenzionale. «La
Terra sta guarendo se stessa» ha scritto il sacerdote. Come se la
natura si fosse presa una sorta di rivincita. Abbiamo visto il ritorno
dei delfini e dei pesci nelle acque più limpide dentro e intorno
Venezia o il miglioramento della qualità dell’aria a Hong Kong o in
Cina, così come le riduzioni generali delle emissioni di carbonio. E
queste immagini e grafici li abbiamo esaminati constatando il
paradosso dei nostri morti. Potrà essere uno spunto di riflessione al
quale noi non possiamo sottrarci, ma, vi prego, non ora in preda a
tanta angoscia.
Nel 2002 uscì 28 giorni dopo di Danny Boyle. Un virus simile
alla rabbia iniettato a un gruppo di scimpanzé dà inizio al contagio. Il
protagonista si risveglia in una Londra spettrale e si trova a essere
uno dei pochi sopravvissuti: tutte le altre persone contagiate dal
virus attraverso il sangue o la saliva sono diventati zombie rabbiosi.
E poi ancora Contagion di Steven Soderbergh del 2011:
un’americana torna da Hong Kong con i sintomi dell’influenza
aggravata da polmonite e danni sul sistema nervoso. Sembra che
anche questo Covid-19 provochi danni cardiaci e al sistema nervoso
centrale oltre che a quello respiratorio. Gli studi fatti su pazienti
risultati positivi paiono suggerire queste complicazioni, ma è ancora
troppo presto dirlo con certezza perché un virus nuovo sfugge anche
alla scienza.
Infine, più introspettivo e disperante, ma varrebbe la pena
rivederlo, è stato The Road di John Hillcoat, un film del 2009 tratto
dal romanzo di Cormac McCarthy. Il viaggio di un padre e di un figlio
per gli Stati Uniti alla ricerca di un posto più pacifico. Una strana
epidemia, anche se non viene mai spiegato nel dettaglio
quest’aspetto mantenendo così un fascino particolare, ha dimezzato
la
popolazione mondiale. I pochi sopravvissuti sono diventati
cannibali.
Ecco, questo era il futuro di una volta. Il buio in sala, la liturgia
della domenica pomeriggio al cinema, provando l’ebbrezza
dell’ignoto. Abbiamo confuso la fantascienza con il futuro e lo
abbiamo spostato in tempi irreali e spazi dilatati. Non abbiamo fatto
neanche per un attimo attenzione alla velocità dei contatti, al gap tra
la tecnologia e la povertà che un pangolino infettato da un pipistrello
e venduto in un mercato ha colmato ferendo a morte il mondo.
E ora ci vediamo costretti a organizzare velocemente un futuro,
evitando la rabbia e il cannibalismo, che non significa mangiare le
carni del nostro simile, ma chiudere gli occhi davanti all’emergenza
sanitaria ed economica che tante popolazioni continueranno a patire.
Alcuni saranno pronti ad accettare questa sfida per certi versi
affascinante; altri invece, per contesto sociale e condizione
economica, rischieranno di soccombere se non affiancati da chi,
almeno all’inizio, dovrà spiegare loro il cambiamento che li attende.
Il bancone affollato del bar e la tazzina di caffè espresso ci sono stati
negati. E quello era indiscutibilmente il più seducente, caldo, certo,
Altro da noi.
Dalle nostre case, dalla tavola della cena. Dalle svogliatezze dei
nostri figli, dalle stanchezze delle nostre mogli, dai nostri silenzi a
volte densi di indifferenza. Dalla caldaia rotta. Dalla tv con il volume
troppo alto. Dalla musica a palla nella stanza dei ragazzi. Dai
cellulari che squillano tutti insieme. Dal cosa bisogna prendere al
supermercato e cosa in farmacia. E, sul lavoro, dal vociare dei
colleghi, dallo stress da desk, dalle umiliazioni subìte dai capi, dai
pettegolezzi velenosi, dai clienti alla cassa che neanche ti dicono
buongiorno. Quel caffè al bar era l’Altro da noi e dentro ci
perdevamo davvero tutti. Fuori da tutto. Centinaia di persone in
questi mesi hanno detto: «Mi manca il caffè al bar».
Da sempre le liturgie sono servite a questo. Entrare in un luogo
sacro, che ha tempi, gesti, colori, suoni propri in mezzo a
sconosciuti, con sconosciuti, per consumare la nostra solitudine
come la nostra libertà, le allegrie come le incazzature in un coro
universale.
Adesso, però, quale liturgia potrà salvarci se l’espresso al bar
spingendoci l’uno con l’altro è e sarà severamente proibito? Solo un
amaro ricordo! Si entra in un quadrato disegnato a terra, si consuma
e si esce dal quadrato.
Quale liturgia se ci scontriamo con i nostri abiti nel guardaroba e
ci sembrano estranei? Abbiamo preso a indossare le tute, non tutti,
ma i più. Per dirla con il grande stilista Karl Lagerfeld: «I pantaloni
della tuta sono un segno di sconfitta: quando perdi il controllo della
tua vita, te ne compri un paio». E qui, adesso, le tute abbondano. E
se alcuni di noi hanno avuto un terrazzo al quale accedere, altri si
sono contesi un divano a tre posti. Altri, anche peggio, hanno avuto il
divano occupato solo da loro stessi. In totale solitudine. Davanti al
televisore per otto, dieci ore al giorno. Irretiti da bollettini di guerra o
attaccati alle repliche di quiz sino a che non si sono esaurite e a
concerti di artisti nostrani con la folla accalcata sotto il palco, roba
preistorica. E tanto, tanto Netflix. La casa di carta, perché essere
ostaggi un po’ ci appartiene.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :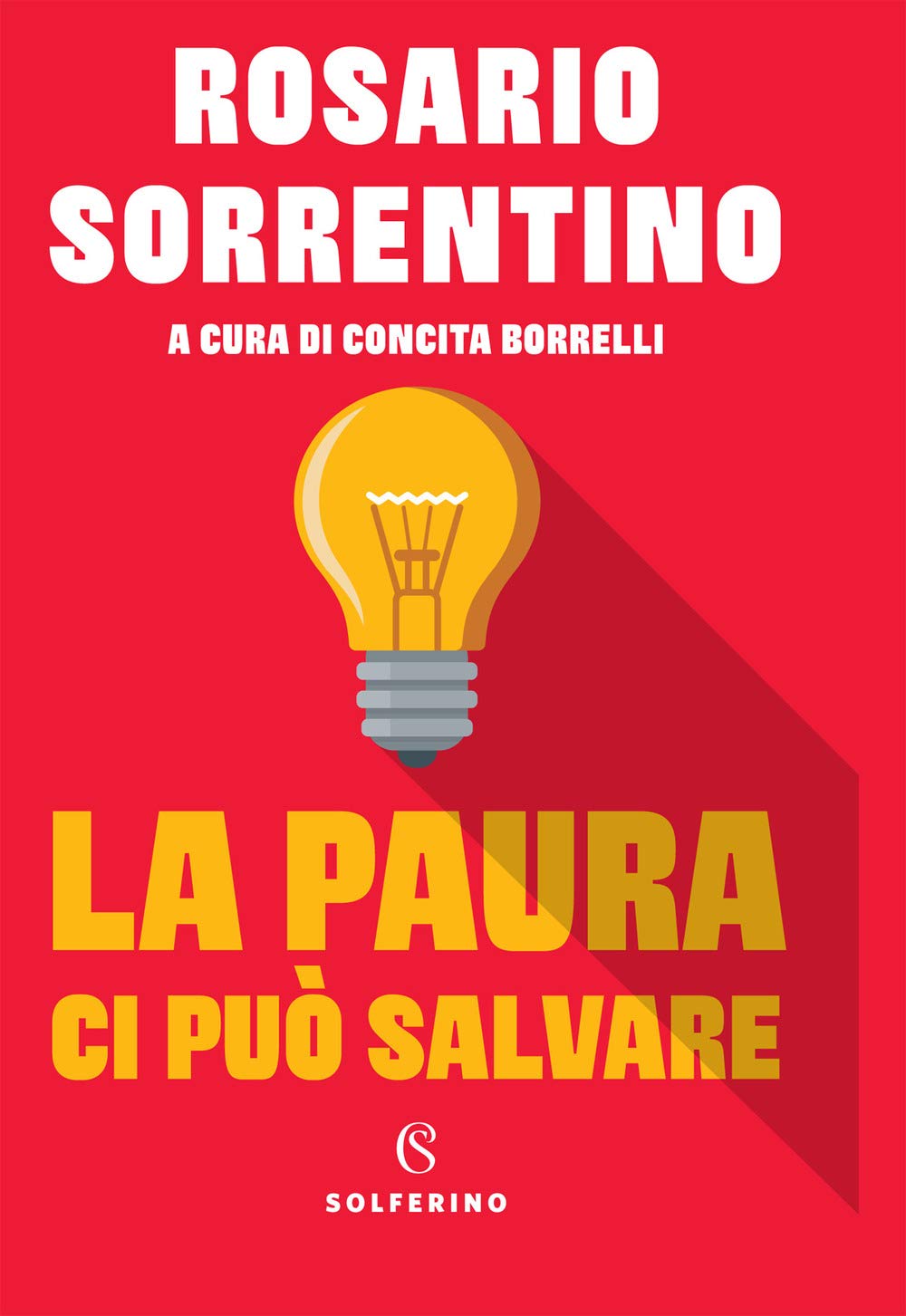






Commento all'articolo