La polvere del mondo – Nicolas Bouvier
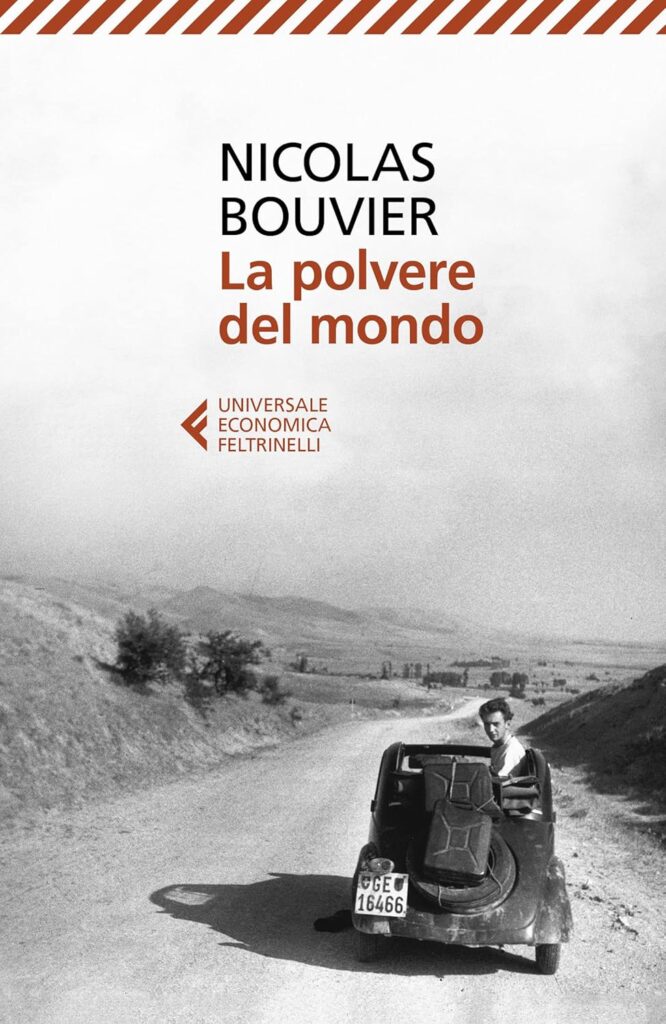
SINTESI DEL LIBRO:
Suonava la mezzanotte quando fermai la macchina davanti al
caffè Majestic. Un gradevole silenzio regnava sulla strada ancora
calda. Attraverso le tende a filet vidi Thierry seduto nel locale. Aveva
disegnato sulla tovaglia una zucca a grandezza naturale che
riempiva, per ammazzare il tempo, di minuscoli semi. Sembrava che
il
parrucchiere di Travnik non lo avesse visto spesso. Con le sue
alette di capelli sulle orecchie e i piccoli occhi azzurri, aveva l’aria di
un giovane squalo vivace e sfinito.
Restai a lungo col naso contro il vetro prima di raggiungerlo al
tavolo. Brindammo. Io ero felice di vedere il vecchio progetto
prendere forma, e lui di essere stato raggiunto. Era venuto via a
fatica. Aveva fatto, senza allenamento, camminate troppo lunghe e
la stanchezza l’intristiva. Traversando tutto sudato e con i piedi feriti
quelle campagne piene di contadini incomprensibili, rimetteva tutto in
discussione. L’impresa gli pareva assurda. Di un romanticismo
idiota. In Slovenia, un locandiere, accortosi della sua aria sfatta e del
sacco da viaggio troppo pesante, non l’aveva certo aiutato
dicendogli gentilmente: “Ich bin nicht verrückt, Meister, Ich bleibe zu
Hause”.
L’aveva rimesso in sesto il mese passato poi in Bosnia a
disegnare. Quando era sbucato a Belgrado con i suoi disegni
sottobraccio, i pittori dell’ULUS
1 l’avevano accolto come un fratello e
gli avevano scovato in periferia un atelier vuoto dove avremmo
potuto abitare insieme.
Riprendemmo la macchina; era proprio fuori città. Passato il ponte
sulla Sava, bisognava seguire le due carreggiate che costeggiavano
gli argini fino a un campicello invaso dai cardi, dove si ergevano dei
padiglioni scrostati. Thierry mi fece fermare davanti al più grande. In
silenzio trasportammo il bagaglio su una scala buia. Un odore di
trementina e di polvere prendeva alla gola. Il caldo era soffocante.
Dalle porte aperte usciva un forte russare, che risuonava sul
pianerottolo. In mezzo a una stanza immensa e nuda, Thierry, da
metodico vagabondo, si era sistemato in una zona scopata del
pavimento, a buona distanza dalle finestre rotte. Una rete
arrugginita, il suo materiale per dipingere, la lampada a petrolio e,
accanto alla branda su una foglia d’acero, un’anguria e un formaggio
di capra. Il bucato del giorno asciugava sulla corda tesa. Era tutto
frugale, ma così naturale da darmi l’impressione che Thierry mi
aspettasse là da anni.
Distesi il sacco a pelo sul pavimento e mi coricai vestito. La cicuta
e l’ombrella salivano fino alle finestre aperte nel cielo estivo. Le
stelle erano luminosissime.
Far niente in un mondo nuovo è la più impegnativa delle
occupazioni.
Tra la grande arcata del ponte sulla Sava e la confluenza del
Danubio, la periferia brillava nella polvere sotto le luci d’estate. Essa
doveva il suo nome, Saïmichte (la fiera), ai resti di un mercato
agricolo trasformato dai nazisti in campo di concentramento. Per
quattro anni ebrei, partigiani e zingari vi erano morti a centinaia.
Ritornata la pace, il municipio aveva sommariamente reimbiancato
quei lugubri “padiglioni” per gli artisti vincitori di una borsa dello
Stato.
Il
nostro – porte scricchiolanti, finestre sfondate, sciacquone
riluttante – contava cinque atelier, che andavano dalla miseria
assoluta a una confortevole bohème. I più poveri tra gli inquilini,
quelli del primo piano, si ritrovavano ogni mattina, col pennello da
barba in mano, davanti al lavabo del pianerottolo, in compagnia del
custode – un mutilato di guerra, berretto avvitato al cranio – a cui
bisognava tener tesa la pelle del mento mentre lui, con la sua unica
mano, vi passava prudentemente il rasoio. Era un uomo malaticcio,
più sospettoso di una lontra, senza altro da fare che sorvegliare una
figlia in età di peccato, e raccattare nei bagni – latrine alla turca
dove, prima di accovacciarsi, si svuotano le tasche – quelle
bagatelle: fazzoletti, accendini, penne, che gli utenti distratti avevano
potuto dimenticare. Il critico letterario Milovan, Anastasio il ceramista
e Vlada, un pittore contadino, occupavano gli atelier del piano terra.
Sempre pronti ad aiutarci, a servirci da interpreti, a prestarci una
macchina da scrivere, una scheggia di specchio, un pugno di sale
grosso; o a invitare il caseggiato intero, in occasione della vendita di
un acquerello o di un articolo, a un vociante banchetto – vino bianco,
peperoni, formaggio – seguito da una siesta collettiva sul pavimento
soleggiato e nudo. Eppure Dio sa in quali ristrettezze vivevano, ma
gli anni neri dell’occupazione e della guerra civile avevano insegnato
loro il prezzo dell’armonia, e Saïmichte, in mancanza di comodità,
possedeva una gradevolezza tutta sua. Era una giungla di papaveri,
di fiordalisi, di erbe selvatiche che si levava all’assalto di quei
casamenti in rovina, e annegava nel suo verde silenzio le cambuse e
gli accampamenti di fortuna sorti tutto intorno. Uno scultore abitava
nel padiglione vicino al nostro. Col mento sporco di barba e i martelli
alla cintola come colt, dormiva sopra un pagliericcio ai piedi della
statua che stava finendo: un partigiano a torso nudo, col pugno
stretto su una mitraglietta. Era l’uomo più ricco della zona. Il periodo
gli era propizio: tra monumenti ai morti, stelle di granito rosso ed
effigi di partigiani alle prese con un vento a duecento chilometri
all’ora, aveva ordinazioni per almeno quattro anni. Naturale; dopo
essere state l’affare di comitati segreti, le rivoluzioni si insediano, si
pietrificano e diventano rapidamente quelle degli scultori. In un
paese come la Serbia poi, che non aveva mai cessato di sollevarsi e
di battersi, essi dispongono già di un ampio repertorio eroico
cavalli impennati, sciabole sguainate, Comitadjis – al quale basta
attingere. Ma questa volta era più difficile. I liberatori avevano
cambiato stile; erano a piedi, ben tosati, pensierosi, severi, cosicché
il
cucchiaio di marmellata che lo scultore ci offriva, secondo l’uso
serbo, quando gli rendevamo visita, suggeriva un universo meno
marziale e più dolce.
Dall’altra parte della spianata una ghiacciaia affiancata da uno
spaccio di alcol serviva da cassetta postale e come luogo
d’appuntamento per coloro che vivevano qui, tra cielo e cespugli,
con le loro galline e i loro pentoloni. Vi si prendevano dei pesanti
blocchi terrosi di ghiaccio a grana grossa e dei sorbetti al latte di
capra il cui gusto acidulo restava in bocca fino a sera. Il bistrot aveva
solo due tavoli, attorno ai quali gli straccivendoli della zona – vecchi
dagli occhi rossi e mobili che a forza di annusare sporcizia insieme
avevano assunto l’aria di furetti cresciuti nello stesso sacco – si
piazzavano nelle ore calde per dormire o selezionare il loro bottino.
Dietro la ghiacciaia si stendeva il regno di un rigattiere ucraino che
abitava in una nicchia pulitissima in mezzo ai suoi tesori; uomo di
peso, con in testa un berretto col paraorecchie, che possedeva una
montagnola di scarpe fuori uso, un’altra di lampadine fuse o
bruciate, e che faceva i suoi begli affari. Un mucchio di bidoni bucati
e di camere d’aria cotte dall’uso completava il suo magazzino. La
cosa strana era il numero dei clienti che lasciavano il suo deposito
con i loro “acquisti” sottobraccio. Al di sotto di un certo livello di
povertà non c’è nulla che non si possa negoziare. A Saïmichte, una
scarpa – anche bucata – poteva rivelarsi un affare, e la montagnola
dell’ucraino era spesso scalata da gente scalza, esplorata da
sguardi luccicanti.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :




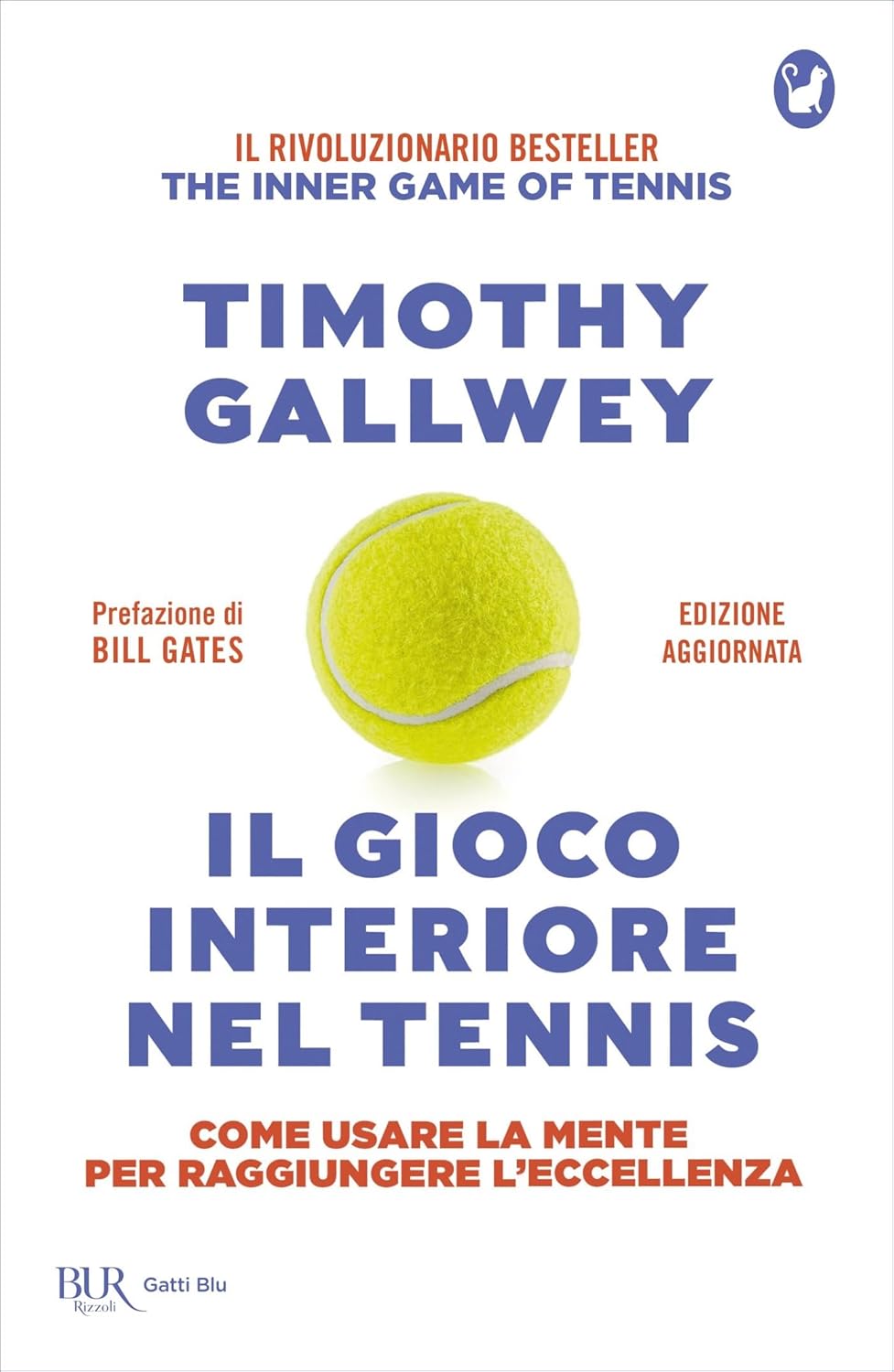

Commento all'articolo