La guerra per il Mezzogiorno – Italiani, borbonici e briganti 1860-1870 – Carmine Pinto
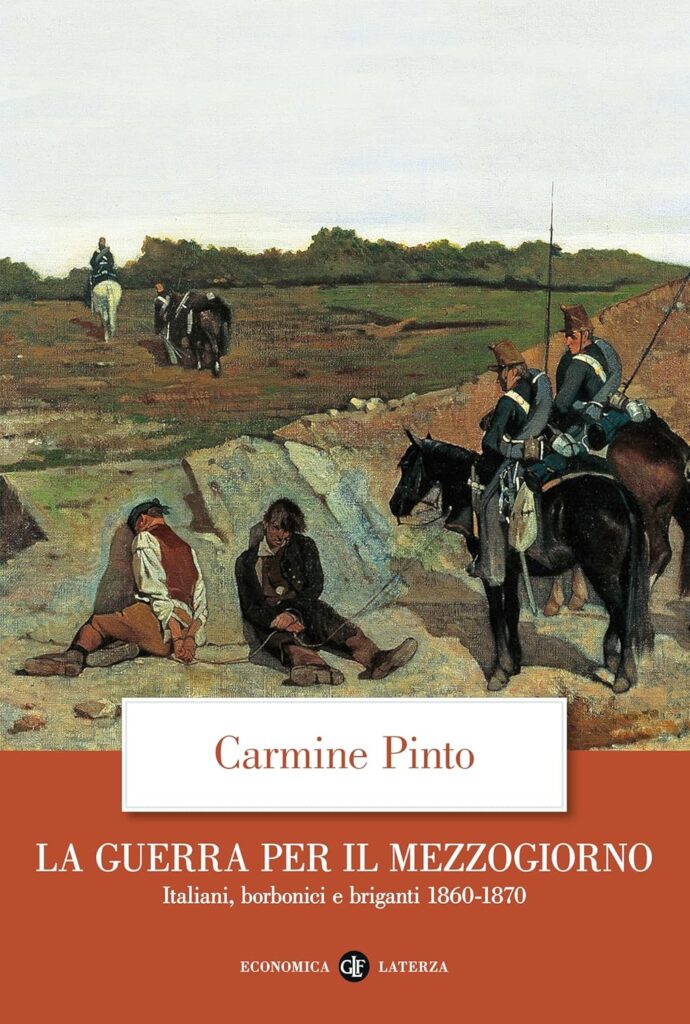
SINTESI DEL LIBRO:
Nell’estate del 1857 un gruppo di sconosciuti si impadronì di un piroscafo
di linea piemontese, il Cagliari. I dirottatori costrinsero il capitano a
dirigersi a Ponza, un’isola napoletana, luogo di carcerazioni penali e
politiche. Si scoprì poi che il loro capo era un ex ufficiale borbonico,
Carlo Pisacane. Aveva disertato più di dieci anni prima, fuggendo da
Napoli insieme alla sua amante Enrichetta Di Lorenzo, causando
scandalo, per poi andare nella Legione straniera francese. Nel 1849 fu tra i
protagonisti della breve stagione della Repubblica romana. In esilio si fece
conoscere come intellettuale, scrisse libri politici, si dichiarò socialista,
litigò e si riavvicinò a Giuseppe Mazzini. Insieme, progettarono l’impresa
che prese il nome di spedizione di Sapri. Si basava sulla convinzione che,
dopo decenni di rivolte e lotte civili, sarebbe bastata una scintilla per far
esplodere il Mezzogiorno, scatenare il popolo e prendere la guida della
nuova rivoluzione italiana.
A Ponza, accompagnato da una ventina di uomini, si impadronì delle
caserme e liberò più di trecento relegati, che lo seguirono. Poi si diresse
verso il continente. Il successo era apparente. I pochi prigionieri politici
presenti, consapevoli dell’assurdità dell’impresa – sfidare un intero regno
che non era in stato di rivolta –, lo avevano trattato come un folle. Una
convinzione comune allo stato maggiore della Sinistra come ai moderati
napoletani. A Genova e a Livorno, dove si tentò una mobilitazione
parallela, tutto si risolse in farsa.
Nel Mezzogiorno finì in una sanguinosa tragedia. Il governo borbonico
era pronto a riceverli. L’organizzazione rivoluzionaria era stata infiltrata, i
dirigenti nell’area dello sbarco scoperti e arrestati. L’aspetto più
inquietante era che Pisacane sapeva tutto, forse era consapevole che era
un’impresa suicida, almeno a leggere le ultime parole del suo Testamento
politico. Sbarcati a Sapri, nel Salernitano, si diressero verso Napoli. La
reazione borbonica fu rapida. L’intendente di Salerno, Luigi Ajossa, fece
convergere regolari, gendarmi, paramilitari. Il 1° luglio la colonna fu
sbaragliata a Padula. Pisacane fuggì con un centinaio di uomini, ma il
giorno dopo vennero assaliti a Sanza dalle guardie urbane e dai popolani.
Pisacane fu ucciso, o si suicidò, gli altri massacrati o catturati.
I superstiti furono processati a Salerno. Per quanto Sergio Pacifico,
procuratore generale del re di Napoli, cercasse di denunciare le
«spedizioni dello straniero di gente armata, nello scopo di promuovere la
ribellione»1, i circa trecento imputati, oltre al centinaio uccisi, erano quasi
tutti delle province napoletane (a parte pochi siciliani e settentrionali),
così come i loro nemici. Le stesse azioni dei rivoluzionari locali, come la
reazione dei paramilitari borbonici e dei popolani, sembrarono rinnovare
la stagione delle rivoluzioni, del brigantaggio politico e della Santa Fede.
Da questo punto di vista, la spedizione era solo l’ennesima tappa di un
lungo conflitto civile che aveva diviso e frammentato il regno, ma il
sottofondo strategico, i suoi obiettivi e ispiratori, erano la prova che la
questione nazionale italiana aveva definitivamente inglobato il problema
meridionale.
Il re Ferdinando II trasse comunque sollievo dal fallimento di Pisacane.
Anche se solo pochi mesi prima un suo soldato, Agesilao Milano, aveva
cercato di assassinarlo durante una parata. Poteva continuare a reggere
con mano di ferro il regime. Le conseguenze di Sapri andarono invece
ben oltre il massacro del luglio 1857. Agli occhi di una parte importante
del movimento unitario la fondazione dello Stato nazionale italiano
sarebbe stata impossibile senza il Mezzogiorno. Per dimensioni e peso
demografico era un regno affollato, abitato da circa nove milioni di
persone, su una superficie di poco più di 111.000 km2, aveva una grande
capitale di quasi mezzo milione di abitanti e oltre duemila comuni.
Eppure, come aveva mostrato la spedizione di Sapri, il risultato del
progetto risorgimentale non era scontato né predeterminato, e doveva
misurarsi con un conflitto antico e radicato.
Le sue radici risalivano alla fine del XVIII secolo, quando il Regno di
Napoli e il Regno di Sicilia, ancora separati, registrarono la prima scossa.
Le rivoluzioni e la guerra, in Europa e nell’Atlantico, moltiplicarono la
circolazione di idee, progetti, uomini, smuovendo gli antichi Stati europei
o stimolandone di nuovi nelle antiche colonie. I paesi subito coinvolti
erano quelli che avevano vissuto con intensità le epoche delle riforme e
dell’illuminismo. Così, quando nel dicembre del 1792 la flotta da guerra
francese arrivò nel golfo di Napoli, anche qui si aprirono ambiziose
speranze tra intellettuali e notabili. Meno di due anni dopo, il governo
borbonico fece il primo rastrellamento contro veri e presunti
repubblicani, e inviò un corpo di spedizione a Tolone con gli inglesi.
Il regno entrò nel conflitto europeo, diventando per quasi trent’anni un
terreno di sperimentazione privilegiato dell’intreccio tra guerra e
rivoluzione, una dialettica che condizionò lo sviluppo dello Stato, i
caratteri del conflitto politico, l’assetto socioeconomico. La guerra
assegnò al fattore esterno, alla connessione con le potenze e i dibattiti
ideologici europei, un ruolo decisivo che, pur in forme diverse, sarebbe
durato fino all’unificazione. Dal 1792 al 1828 il Mezzogiorno conobbe la
breve stagione della Repubblica e la prima restaurazione, lo scontro tra le
coalizioni europee e l’impero napoleonico, la sfida tra liberalismo e
assolutismo. Si combatterono guerre internazionali, si registrarono
occupazioni e invasioni francesi, inglesi, austriache, contemporaneamente
le
rivoluzioni repubblicana e liberale-costituzionale, e reazioni
controrivoluzionarie, la sanfedista e il brigantaggio politico.
I Borbone furono accesi nemici della Francia rivoluzionaria, come
successivamente del liberalismo, ma buona parte della classe dirigente si
schierò con decisione dalla parte opposta. Il conflitto tra rivoluzionari e
controrivoluzionari, poi tra murattiani e infine liberali contro legittimisti
borbonici, diventò il motore di un processo di politicizzazione mai visto
prima, consentendo la diffusione della violenza politica e
dell’elaborazione ideologica. I caratteri di scontro fratricida si estesero ai
non combattenti. Napoli fu presa due volte d’assalto nel 1799. Spesso
furono uccisi o attaccati i civili, compresi le donne e i bambini, toccando
livelli di crudeltà che segnarono la memoria. In alcuni momenti si accese
una vera e propria guerra civile, ma si trattò soprattutto di un fenomeno
endemico, una forma di mobilitazione e politicizzazione permanente,
con una significativa incidenza della violenza selettiva, che sviluppò e
interpretò lo spirito di partito e di fazione.
Il conflitto scisse la società e i suoi gangli locali più profondi, estendendo
agli interessi e alle ambizioni dei contendenti i progetti politici che si
confrontavano nel regno. Determinò la fuoriuscita dall’antico regime,
trasformando le tensioni nelle campagne e tra i ceti urbani. Tutti,
proprietari e contadini, dipendevano dalla terra, con il suo mosaico di
interessi territoriali e strutture sociali: commercio e agricoltura erano il
motore della ricchezza. La fine del feudalesimo, avviata dai francesi
nell’estate del 1806, trasformò istituzioni secolari, rivoluzionando il
quadro giuridico ed economico. Permanevano rilevanti eredità, mentalità
e immaginari dell’antico regime, senza dimenticare l’intensità del
rapporto con la Chiesa (in Sicilia la scossa arrivò anni dopo), ma la
crescente liberalizzazione di terra e lavoro avviò il definitivo superamento
di vincoli e modelli tradizionali.
L’affermazione di una importante borghesia agraria mise in campo la
maggioranza dei quadri negli apparati dello Stato e negli ambienti politici,
selezionando una parte decisiva della classe dirigente per tutto il secolo.
Gli attori politici integrarono le tensioni sociali nella guerra tra
rivoluzione e controrivoluzione. Se la prima fu l’arma del patriottismo di
opposizione o del cambiamento istituzionale, la seconda non fu un
semplice ritorno all’antico regime, ma un progetto politico rinnovato. Si
misurarono in uno scontro di sovranità di carattere politico-ideologico,
che coinvolse uomini provenienti da estrazioni sociali diverse.
Con la restaurazione e il congresso di Vienna la dinastia tentò una
pacificazione, accettando di riconoscere i quadri politici e militari
cresciuti con Gioacchino Murat, mentre Palermo e Napoli venivano
unificate nel Regno delle Due Sicilie. Il costituzionalismo diventò invece
la principale linea di divisione tra l’opposizione e il regime borbonico.
Nel 1820 la rivoluzione mobilitò componenti e sensibilità diverse, dagli
apparati murattiani al liberalismo provinciale, ottenendo la costituzione e
l’insediamento del parlamento2. Non riuscì però a superare i limiti di
leadership e progettualità politiche, oltre che di estremo settarismo. In
Sicilia invece, con il ritiro della Costituzione del 1812, iniziò una
resistenza che nel 1820 diventò guerra civile regionale (e contribuì a
disgregare il fronte liberale)3.
Nel 1821 Ferdinando di Borbone, che aveva promesso di difendere la
Costituzione, si recò al congresso della Santa Alleanza a Lubiana, dove fu
deciso l’intervento austriaco contro il suo stesso parlamento. Il re tracciò
una linea d’azione a cui si sarebbero attenuti i suoi discendenti fino alla
f
ine del regno, considerando le richieste di rappresentanza costituzionale
invadenti sul piano morale, inaccettabili sul piano politico, intollerabili su
quello ideologico. Questa posizione restò immutata, anche quando il
conflitto europeo si trasformò in una competizione tra visioni opposte
dell’Italia. Quando il nipote Ferdinando II salì al trono, nel 1830, varò un
tentativo di modernizzazione delle istituzioni politiche ed economiche,
valorizzando il centralismo amministrativo e proponendo una immagine
rinnovata e dinamica del re. Pur attenuando le strette repressive, non volle
però derogare dalla linea dei Borbone: evitare qualsiasi concessione al
liberalismo. Una parte del regno continuò a identificarsi con questo,
mentre in Sicilia, anche senza un progetto concreto, cresceva un blocco di
opposizione compatto4.
Finite le guerre europee, la questione costituzionale fu assorbita
dall’entusiasmo per il romanticismo nazionalista, avviando la seconda fase
di un conflitto che diventò parte della guerra per la nuova Italia. Nel 1848
la rivoluzione iniziò in Sicilia e poi diventò inarrestabile, tanto che
Ferdinando II fu costretto a deviare dalla linea della dinastia. L’11 febbraio
concesse lo Statuto. A Napoli la maggioranza parlamentare liberale si
illuse di ottenere una mediazione costituzionale e filo-italiana, mentre i
siciliani scelsero decisamente la via dell’indipendenza, formando un
proprio parlamento e dichiarando decaduta la dinastia borbonica5. Divisi
nelle logiche e negli obiettivi, persero l’iniziativa e furono sconfitti dalla
decisa reazione di Ferdinando II. La restaurazione fu possibile anche per il
desiderio di tranquillità del notabilato agrario. Sommosse e agitazioni
legate alla questione dei beni demaniali si moltiplicarono ma i contadini,
coinvolti nelle lotte tra fazioni, non avevano obiettivi propri, finendo per
stimolare una reazione improntata al recupero dell’ordine.
Nel marzo del 1849 Ferdinando II sciolse il parlamento, confermando la
scelta anticostituzionale come elemento definitivo di discriminazione tra i
suoi sostenitori e chi era potenzialmente avversario del trono: non c’era
spazio neppure per un moderato partito liberale. L’accordo con l’alto
clero, consolidato con il Concordato del 1818, aveva rafforzato la portata
conservatrice del regime, valorizzando le gerarchie ecclesiastiche,
orgogliose del proprio ruolo nella società e nella storia del regno.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :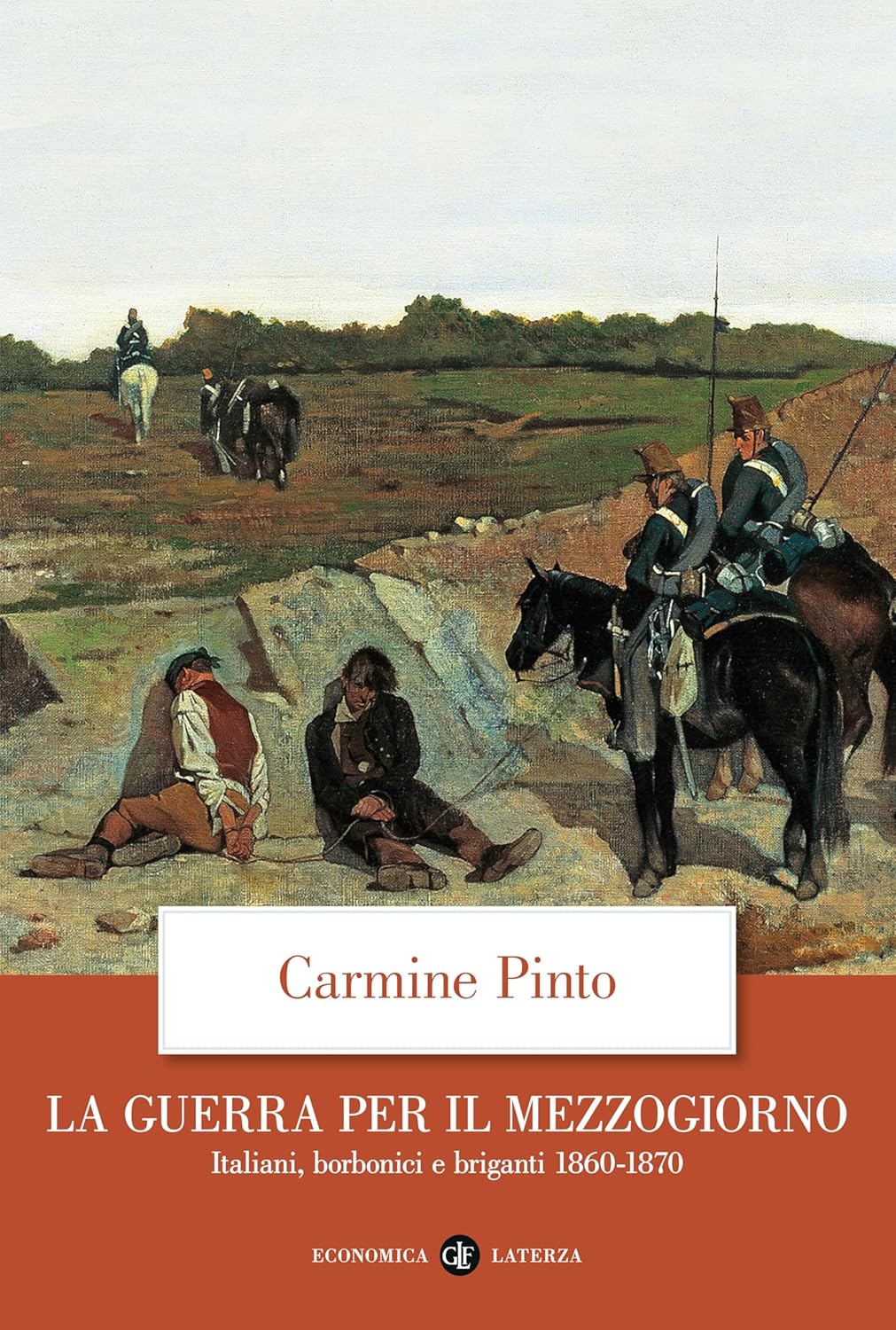






Commento all'articolo