La letteratura in pericolo – Tzvetan Todorov
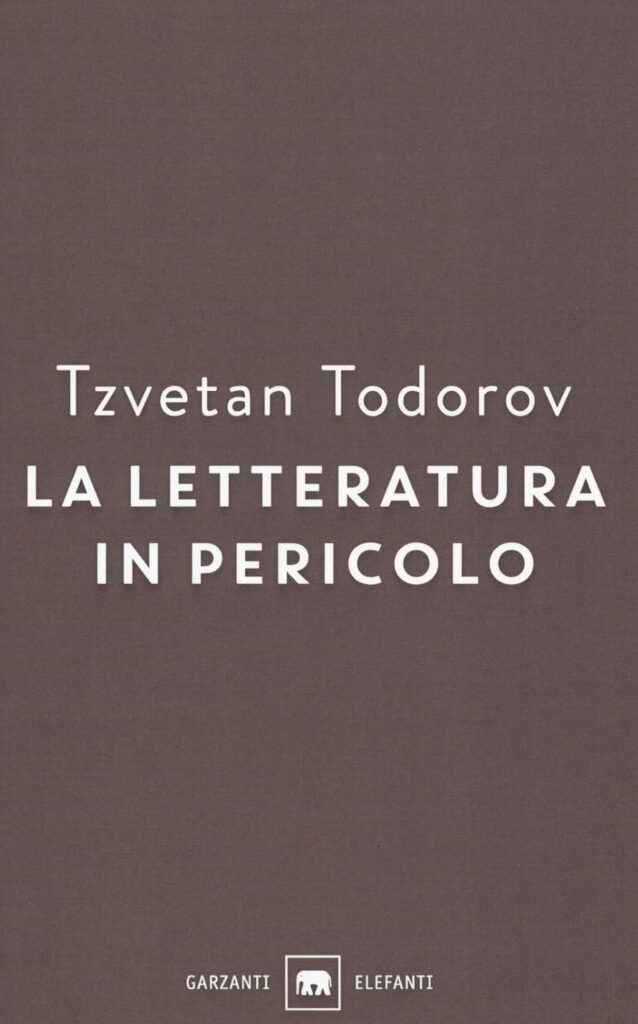
SINTESI DEL LIBRO:
Nei miei ricordi più remoti mi vedo circondato dai libri. I miei genitori erano
bibliotecari e, dato che in casa i libri erano sempre troppi, erano costretti a
escogitare continuamente nuove soluzioni per altre scaffalature destinate ad
accoglierli. I libri, nel frattempo, si accumulavano nelle camere e nei corridoi,
formando pile precarie tra le quali ero costretto ad avanzare con cautela.
Imparai a leggere fin da piccolo e cominciai a divorare i classici nelle
edizioni per ragazzi, Le mille e una notte, le fiabe dei fratelli Grimm e di
Andersen, Tom Sawyer, Oliver Twist e / miserabili. Un giorno, avevo allora
otto anni, lessi un romanzo dalla prima all'ultima pagina; dovevo esserne
molto fiero, perché nel mio diario scrissi: «Oggi ho letto Sur les genoux de
grandpére, un libro di 223 pagine, in un'ora e mezzo!».
Negli anni della scuola la lettura era una delle mie occupazioni preferite.
Entrare nell'universo degli scrittori, classici o contemporanei, bulgari o
stranieri, di cui ormai leggevo i testi in edizione integrale, provocava in me
sempre un fremito di piacere: potevo soddisfare la mia curiosità, vivere delle
avventure, gustare momenti di gioia e di paura, senza subire le frustrazioni
incombenti sulle relazioni che intrattenevo con i miei coetanei. Non sapevo
che cosa avrei fatto nella vita, ma ero certo che avrebbe avuto a che vedere
con la letteratura. Anch'io scrittore? Mi cimentai e composi poemi scadenti,
un'opera in tre atti dedicata alla vita dei nani e dei giganti; cominciai perfino
a scrivere un romanzo, ma senza andare oltre la prima pagina. In poco tempo
capii che non era quella la mia strada. Sempre incerto sul mio futuro, non
ebbi comunque dubbi, alla fine del liceo, sulla scelta del mio indirizzo
universitario: mi sarei dedicato agli studi letterari. Nel 1956 entrai
all'università di Sofia; parlare di libri sarebbe diventata la mia professione. La
Bulgaria a quei tempi faceva parte del blocco comunista e gli studi umanistici
erano sotto il controllo dell'ideologia ufficiale. I corsi di letteratura erano per
metà di erudizione e per metà di propaganda: le opere del passato o
contemporanee erano valutate in ragione della loro conformità al dogma
marxistaleninista.
Si trattava di dimostrare in che cosa questi scritti illustrassero l'ideologia
giusta - o in che cosa non riuscissero a farlo. Non condividendo la fede
comunista, e senza peraltro essere nemmeno animato da uno spirito di rivolta,
mi rifugiavo in un atteggiamento adottato da molti miei compatrioti: in
pubblico, consenso silenzioso o appena accennato agli slogan ufficiali; in
privato, una vita ricca di incontri e di letture, orientate principalmente verso
autori che non si poteva sospettare fossero portavoce della dottrina
comunista: o perché avevano avuto la fortuna di vivere prima dell'avvento del
marxismoleninismo, o perché erano vissuti in paesi in cui erano liberi di
scrivere i libri che volevano. Per completare gli studi universitari bisognava
comunque discutere, alla fine del quinto anno, una tesi di laurea. Come
parlare di letteratura senza doversi piegare alle esigenze dell'ideologia
dominante? Scelsi una delle poche vie che permettevano di sfuggire al
reclutamento ufficiale. Si trattava di occuparsi di argomenti che non avessero
nulla a che vedere con l'ideologia; perciò, di tutto quello che nelle opere
letterarie riguardasse il testo in quanto tale e le sue forme linguistiche. Non
ero il solo a tentare questa soluzione: già negli anni Venti del secolo scorso i
formalisti russi avevano aperto la via, seguita poi da altri. All'università il
nostro docente più interessante era, naturalmente, un esperto di
versificazione. Così decisi di scrivere la mia tesi confrontando due versioni di
un lungo racconto di un autore bulgaro, scritto all'inizio del XX secolo, e mi
limitai all'analisi grammaticale delle modifiche che aveva apportato da una
versione all'altra: i verbi transitivi sostituivano gli intransitivi, il perfettivo
diventava più frequente dell'imperfettivo... In tal modo le mie osservazioni
sfuggivano a ogni forma di censura!
Procedendo così, non correvo il rischio di trasgredire i tabù ideologici del
partito. Non potrò mai sapere come sarebbe andato a finire questo gioco del
gatto e del topo, non necessariamente a mio vantaggio. Mi si presentò
l'occasione di andare per un anno «in Europa», come dicevamo allora, vale a
dire al di là della «cortina di ferro» (un'immagine che non ritenevamo affatto
eccessiva, perché attraversare quella frontiera era quasi impossibile). Scelsi
Parigi, affascinato dalla sua fama di città di artisti e letterati. Finalmente un
luogo in cui il mio amore per la letteratura non avrebbe conosciuto limiti,
dove poter unire in piena libertà convinzioni profonde e comportamenti
pubblici, evitando così la schizofrenia collettiva imposta dal regime totalitario
bulgaro.
Le cose si rivelarono un po'più complicate di quanto non credessi. Durante i
miei studi universitari avevo preso l'abitudine di andare alla ricerca degli
elementi delle opere letterarie che sfuggivano all'ideologia: stile,
composizione, forme
narrative,
quello
che
possiamo
definire
complessivamente tecnica letteraria. Convinto in un primo momento che sarei
rimasto in Francia solo per un anno (era questa la durata del passaporto che
mi era stato rilasciato), volevo approfittarne per apprendere il più possibile su
questi argomenti: trascurati, messi al bando in Bulgaria, dove avevano il
difetto di non servire la causa comunista nel modo giusto, dovevano certo
essere studiati in maniera approfondità in un paese in cui regnava la libertà!
Ebbene, faticavo a trovare un insegnamento di questo genere nelle facoltà di
Parigi. I corsi di letteratura erano suddivisi per paesi e per secoli, e non
sapevo come trovare docenti che dessero spazio alle questioni che
m'interessavano. Non bisogna dimenticare, poi, che non era facile, per uno
studente straniero come me, addentrarsi nel dedalo delle istituzioni
scolastiche e dei loro programmi. Avevo una lettera di presentazione del
preside della Facoltà di Lettere di Sofia indirizzata al suo omologo francese.
Un giorno del maggio 1963 bussai alla porta di un ufficio della Sorbona (a
quei tempi l'unica università di Parigi), quello del preside della Facoltà di
Lettere, lo storico André Aymard. Dopo aver letto la lettera, mi chiese che
cosa cercassi. Gli risposi che era mio desiderio intraprendere studi sullo stile,
il linguaggio e le teorie letterarie in generale. «Ma non è possibile studiare
queste materie in generale! In quale letteratura intende specializzarsi?»
Sentendomi mancare il terreno sotto i piedi, farfugliai un po'"confusamente
che la letteratura francese avrebbe fatto al caso mio. Intanto mi rendevo conto
che mi stavo imbrogliando nel mio francese a quei tempi ancora incerto. Il
preside mi guardò con un'aria di condiscendenza e mi suggerì di studiare
piuttosto la letteratura bulgara con uno dei suoi esperti, che in Francia certo
non mancavano. Ero un po'"scoraggiato, ma proseguii le mie ricerche,
interrogando quei pochi che conoscevo. E fu così che un giorno un professore
di psicologia, amico di un amico, dopo avermi ascoltato mentre gli esponevo
le mie difficoltà, mi disse: «Conosco un'altra persona che si interessa di
questioni un po'"particolari come queste, è assistente alla Sorbona e si chiama
Gerard Genette». Il nostro primo incontro avvenne in un buio corridoio di rue
Serpente, dove si trovavano alcune aule; tra di noi nacque subito una grande
amicizia. Tra l'altro, egli mi spiegò che un professore teneva un seminario
presso l'Ecole des hautes études, (*) dove sarebbe stato facile incontrarsi; il
suo nome, che non avevo mai sentito prima, era Roland Barthes. I primi passi
della mia carriera in Francia furono legati a questi incontri. Ben presto decisi
che un solo anno di soggiorno non mi sarebbe bastato e che dovevo
trattenermi più a lungo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :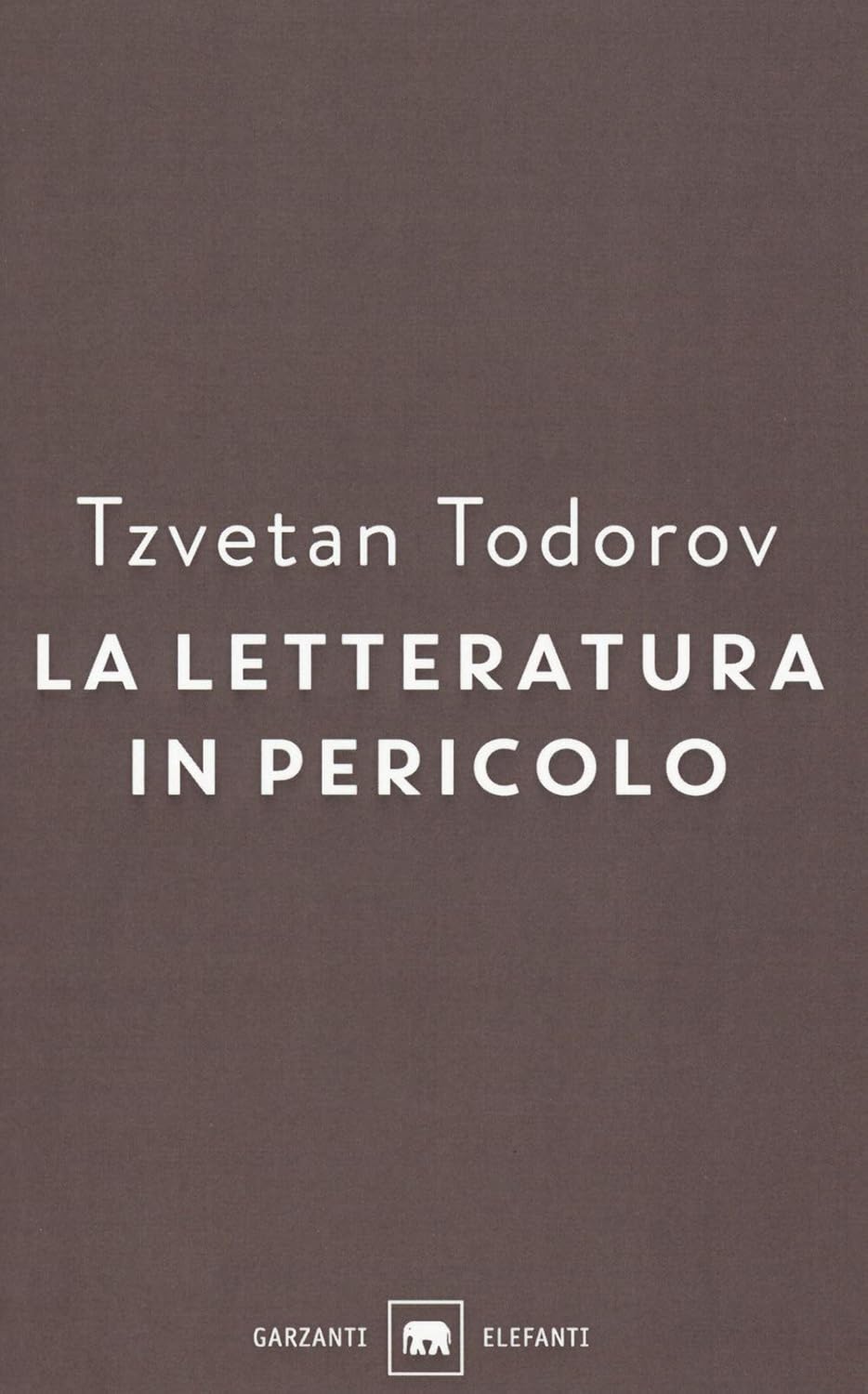






Commento all'articolo