La cura del freddo- Come uno spietato killer naturale può diventare una risorsa per il futuro – Matteo Cerri
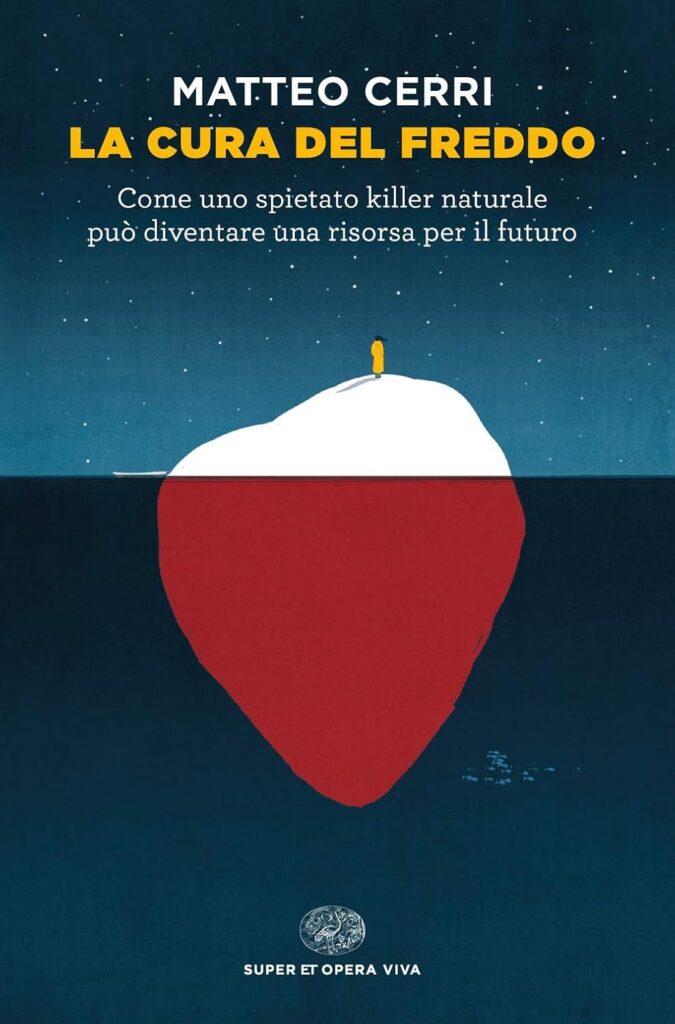
SINTESI DEL LIBRO:
Le imprese alpinistiche sono conquiste grazie alle quali l’uomo
supera i propri limiti sfidando un elemento che definisce «il grande»
per antonomasia: la montagna. Le montagne piú alte e imponenti del
pianeta sono quelle della catena dell’Himalaya. Si tratta di un
ambiente estremo, che esercita un’attrazione magnetica sull’uomo e
sul suo bisogno di mettersi alla prova. Chi per primo è riuscito a
conquistarle è entrato nella storia. Sulla vetta dell’Everest, la
fisiologia umana è spinta al limite. Anzi, sulla cima piú alta del
mondo, a 8848 metri di altitudine e a una temperatura che nemmeno
in estate supera i - 25 °C, l’uomo si trova già oltre il limite, in quella
che viene giustamente chiamata «la zona della morte».
A
questa quota il corpo inizia a morire lentamente e
indipendentemente da ciò che fa. Potremmo restare sdraiati su un
divano mangiando e bevendo e in cinque giorni moriremmo lo
stesso. In questo ristretto arco temporale, infatti, l’organismo si trova
alle prese con una sfida impossibile: centellinare l’ossigeno
disponibile per mantenere vitali le funzioni fisiologiche. Oltre gli 8000
metri, però, si trova pochissimo ossigeno. Sarebbe come uscire dal
portellone di un aereo: a quella quota, senza adattamento,
moriremmo in pochi minuti.
Agli albori dello studio degli effetti dell’altitudine sulla fisiologia
umana la zona della morte, o meglio, la zona letale, corrispondeva a
quell’altitudine oltre la quale non avviene piú la mitosi: le cellule non
si duplicano piú. In queste condizioni, le cellule che muoiono non
vengono sostituite, le ferite non guariscono e l’organismo scivola
lentamente verso una morte inevitabile.
Ed è appunto l’ipossia, cioè la carenza di ossigeno, il fattore che
dà origine a tutta la sequenza di eventi fatali. Non è un caso che la
prima conquista dell’Everest nel 1953, da parte di Sir Edmund Hillary
e di Tanzing Norgay, sia avvenuta con l’aiuto delle bombole
d’ossigeno. Ci volle un alpinista dalla tempra eccezionale, Reinhold
Messner, per dimostrare che quella cima si poteva scalare anche
senza, tanto che molti videro nella sua impresa la prima vera
conquista del tetto del mondo, quella in cui l’uomo aveva battuto la
montagna con le sue sole forze. Da allora, soprattutto negli ultimi
decenni, la conquista dell’Everest ha sedotto sempre piú persone, a
volte anche solo semplici amatori che, pagando una cifra
considerevole, si fanno guidare sulla vetta da alpinisti esperti.
Eppure scalare l’Everest comporta ancora oggi il 20 per cento
circa di mortalità: ad esempio, potremmo partire in un gruppo di dieci
amici e tornare in otto. La mortalità può essere causata da eventi
imprevisti come le valanghe, ma piú spesso dai limiti del nostro
organismo, che ci ricordano le condizioni fisiche in cui si è evoluto.
ci
A quelle quote la combinazione di freddo e mancanza di ossigeno
mette a dura prova e può dare origine ad alcuni disturbi
caratteristici, come l’edema polmonare e l’edema cerebrale da alta
quota, le cui cause, dal punto di vista medico, non sono ancora note.
Sappiamo solo che a generare queste patologie è la ridotta
pressione parziale di ossigeno che si trova a quelle altitudini, ma non
ne conosciamo i meccanismi alla base, né il motivo per cui alcune
persone ne soffrano e altre no. È una condizione cosí subdola che
può manifestarsi improvvisamente anche in coloro che sono già stati
in
e
alta quota senza alcun problema in precedenza. L’edema
cerebrale, in particolare, è la condizione nella quale il cervello si
gonfia
si
schiaccia
all’interno
compromettendo le funzioni cognitive.
della
scatola
cranica,
Gli studi sul campo durante la scalata dell’Everest non sono
all’ordine del giorno, ma nel 2007 un gruppo di ricercatori guidati dal
dottor Michael Grocott del Centre for Altitude Space and Extreme
Environment Medicine dell’University College di Londra ha misurato
la quantità di ossigeno contenuta nel sangue di quattro scalatori
durante l’ascesa. Prelevando il sangue a 8400 metri, i dati hanno
mostrato che un qualche grado di edema polmonare si genera in tutti
gli scalatori, compromettendo la quantità di ossigeno che dagli
alveoli arriva al sangue. Infatti, per rifornire il nostro sangue di
ossigeno dobbiamo affidarci alla capacità di questa molecola di
passare passivamente dall’aria al plasma. Non esistono trasportatori
specifici che caricano l’ossigeno e lo portano all’interno del corpo;
poiché l’ossigeno è piú presente nell’aria rispetto al sangue, dalla
prima passa al secondo tramite un processo fisico che si chiama
«diffusione semplice»: da dove è piú concentrato si dirige
spontaneamente verso dove è meno concentrato. La facilità con cui
una molecola «diffonde» dipende da un fattore fisico che si chiama
«coefficiente di diffusione». L’ossigeno non ha un coefficiente di
diffusione molto alto e quindi fatica ad attraversare il sottile strato di
cellule che separa la parete dell’alveolo dal sangue. Basta che
questo strato si ispessisca un po’ e la nostra capacità di assumere
ossigeno diminuisce drasticamente. La nostra vita dipende dalla
sottigliezza della barriera alveolo-capillare, che deve essere cosí fine
da permettere all’ossigeno di diffondere impedendo allo stesso
tempo al sangue di uscire dai vasi. Una barriera esilissima che
separa la vita dalla morte e che negli alpinisti analizzati dai
ricercatori
guidati
pericolosamente.
dal
dottor
Grocott
sembrava ispessirsi
La combinazione letale di scarso ossigeno e freddo, e dunque di
ipossia e ipotermia, associate alla stanchezza della scalata, miete
continuamente vittime fra quanti si avventurano a queste altitudini. Di
solito, quando si instaura un coma ipotermico, a meno di non essere
soccorsi tempestivamente, è impossibile sopravvivere. È questa la
«dolce morte». Il cervello ci fa precipitare in uno stato di incoscienza,
nel quale abbandonarsi al destino sembra la cosa migliore da fare.
Nel suo libro sulla conquista del K2, ad esempio, Walter Bonatti ha
raccontato il suo pernottamento a 8200 metri e l’incredibile sforzo
per non cedere alla seduzione del sonno che avrebbe aperto le porte
all’assideramento. Per riuscirci usò strategie estreme, fino a colpirsi i
piedi con la picozza.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :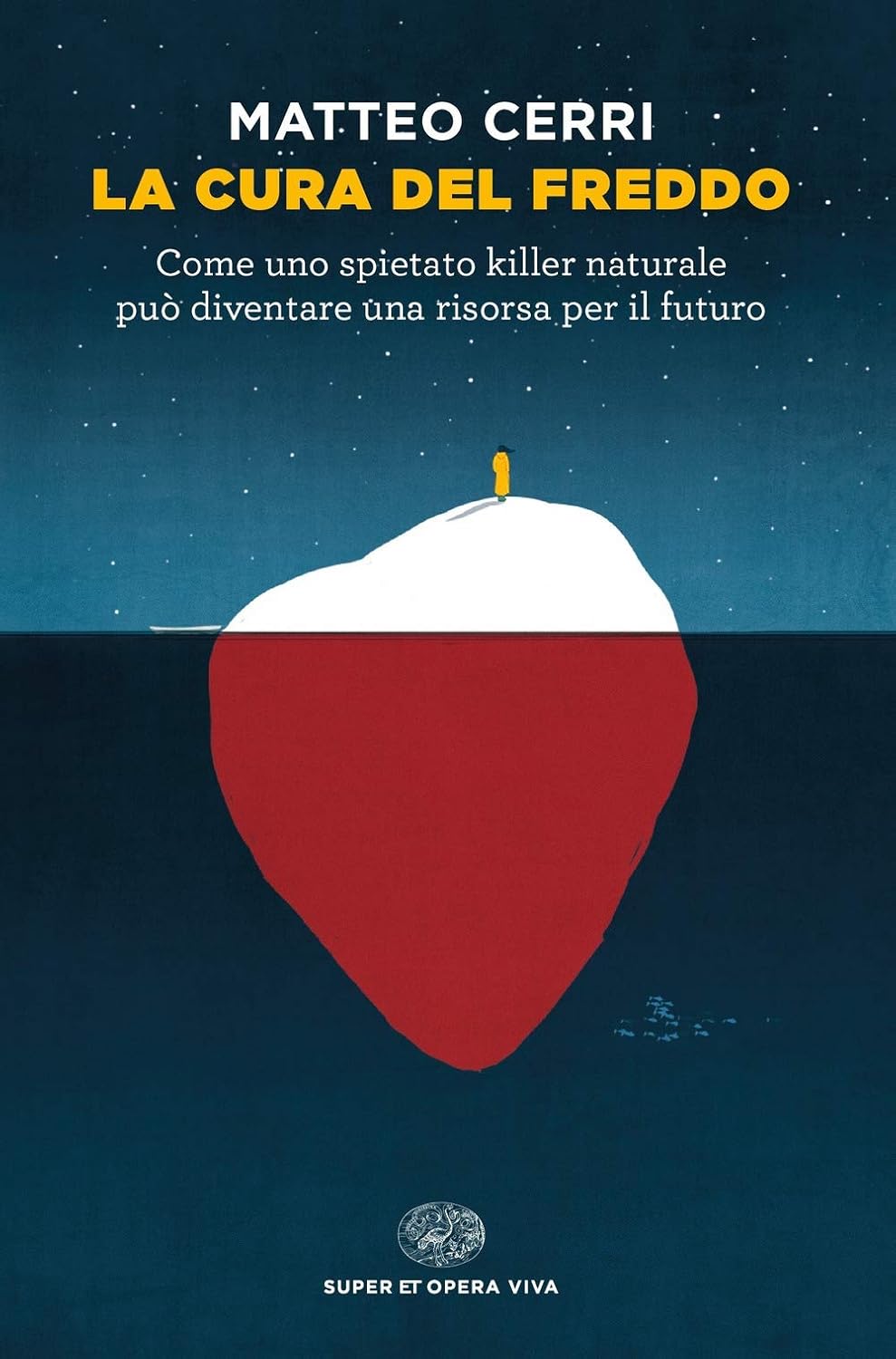






Commento all'articolo