La Controriforma – Elena Bonora
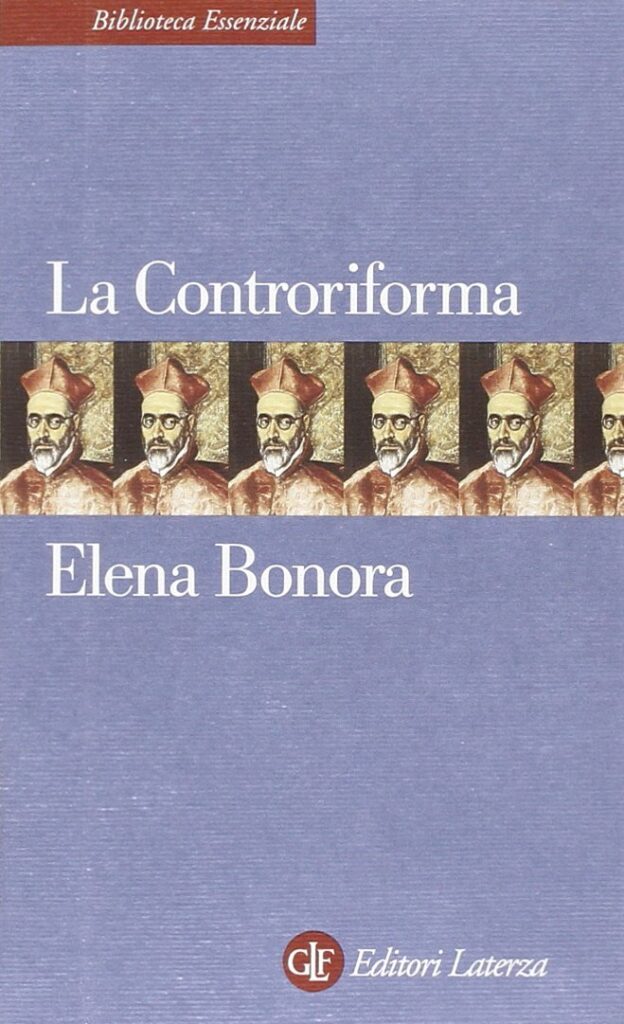
SINTESI DEL LIBRO:
Nel 1494 la discesa di Carlo VIII re di Francia fino a Napoli dava inizio
alle «guerre d’Italia», un trentennio in cui la penisola doveva diventare il
tragico teatro degli scontri tra le ambizioni di Francia e Spagna e delle
devastazioni degli eserciti. Al mutevole gioco delle alleanze tra opposti
schieramenti presero parte gli Stati regionali italiani con scelte di campo
alterne. Il successo o il fallimento di queste scelte avevano ripercussioni
fortissime all’interno di un singolo Stato. Pote vano condurre a radicali
trasformazioni istituzionali, come quelle avvenute a Firenze
rispettivamente nel 1494 e nel 1527 con la cacciata dei Medici e
l’instaurazione di un regime repubblicano (1494-1512; 1527-1530); a
repentini mutamenti politici e sociali come nello Stato di Milano, nel
corso dei convulsi passaggi dal governo ducale al dominio francese sino a
quello di Carlo V; oppure costituire per una classe dirigente un trauma a
partire dal quale ripensare il rapporto con i sudditi oltre che la politica
estera, come era accaduto al patriziato veneziano dopo la sconfitta di
Agnadello (1509) allorché la Terraferma era stata invasa dalle forze
congiunte della Lega di Cambrai stipulata tra pontefice, Francia, Impero,
Savoia, Este e Gonzaga.
Al centro degli eventi che mettevano in subbuglio la penisola, papa
Giulio II della Rovere (1503-1513) stringeva e rompeva alleanze,
conquistava città e territori, comandava gli eserciti. Nel 1511 egli passava
dalla lega antiveneziana di Cambrai alla Lega santa contro la Francia. Re
Luigi XII decise allora di riunire a Pisa un concilio per deporre il
pontefice, un’assemblea scismatica che si sarebbe sciolta in seguito alla
disfatta delle armi francesi e alla convocazione a Roma del V concilio
Lateranense sotto il diretto controllo del pontefice (1512). Nello stesso
periodo la critica di Erasmo da Rotterdam si levava contro questo «papa
guerriero» attento più all’espansione del suo Stato che alle esigenze
spirituali del suo gregge, contro una Chiesa imbevuta di interessi
temporali, contro una religione affidata a frati corrotti e ignoranti, a un
clero secolare avido e ambizioso, a teologi sottili e litigiosi. In scritti che
contribuirono a creare in tutta l’Europa un sentire comune a dotti
umanisti e al popolo, Erasmo accusava il clero di aver tradito il messaggio
morale e religioso dei Vangeli, di aver ridotto la fede a un cumulo di
pratiche superstiziose, cerimonie esteriori e preghiere oscure. In quegli
stessi anni i monaci camaldolesi Paolo Giustiniani e Pietro Querini,
interpretando le speranze riposte nel concilio Lateranense da larga parte
del mondo ecclesiastico, redigevano il Libellus ad Leonem X (1513) dove
dinanzi ai grandi compiti missionari che si profilavano all’orizzonte con la
scoperta del Nuovo Mondo – tracciavano un vastissimo disegno di
rinnovamento interno della Chiesa che restò inattuato.
Di fronte all’instabile situazione politica, alle guerre con il loro strascico
di miseria e malattie, all’incapacità dell’istituzione ecclesiastica di
rispondere alle esigenze e alle inquietudini della vita religiosa, nel primo
trentennio del Cinquecento un turbine di fermenti profetici, tensioni
apocalittiche e trepide speranze nell’arrivo di un’età di rigenerazione della
cristianità percorse la penisola articolandosi secondo una molteplicità di
esperienze nutrite, a tutti i livelli sociali, dalla diffusione della stampa.
L’eredità profetica savonaroliana non si era spenta nel 1498 con il rogo del
frate domenicano ma, largamente diffusa tra gli ordini religiosi, si era
dispersa in mille rivoli in tutta Italia, alimentando attese in un
rinnovamento radicale della società che, al di là del contesto cittadino
f
iorentino, si allargavano all’intera cristianità. Frati itineranti
infiammavano i fedeli dai pulpiti, mentre nelle piazze e nei mercati
cittadini eremiti di status non ben definito, vestiti di sacco e pelli come i
profeti «Enoch ed Elia», si mescolavano a «ciarlatani, cavadenti, ripositori
d’ernia» per predicare la penitenza. Fogli volanti e opuscoli circolavano in
tutti gli strati sociali. «Ascoltate mortali/ li orribeli segnali/ che
annuntiano gran mali»: predicazione e stampa davano voce a paure
dilaganti, diffondevano notizie di eventi prodigiosi e di nascite mostruose
da una città all’altra, annunciavano imminenti flagelli, l’invasione turca,
l’avvento dell’Anticristo e la fine del mondo se gli uomini non si fossero
redenti. Non erano fenomeni che riguardassero solo il popolo: dotti
curiali e potenti cardinali forzavano i segreti della Sacra Scrittura e di
antichi codici per leggervi l’annuncio del «papa angelico», colui sotto il
cui governo, secondo i vaticini, doveva aprirsi la nuova era. Nel frattempo
la propaganda politica utilizzava ai propri fini tali inquietudini
identificando ora nel «re dei gigli» Francesco I ora nel suo nemico Carlo V
l’imperatore che avrebbe pacificato, riformato e salvato la cristianità.
Nel 1517 a Wittenberg la rivolta contro Roma del frate agostiniano
Martin Lutero aveva avviato un processo storico che di lì a qualche anno
avrebbe infranto l’unità religiosa del mondo cristiano. A occupare in quel
periodo il sacro soglio erano papi fiorentini della famiglia dei Medici, con
la breve interruzione di Adriano VI (1522-1523), l’ex precettore di Carlo
V. Nella splendida Roma di Leone X (1513-1521) prima, di Clemente
VII (1523-1534) poi, il teologo di Utrecht fu considerato un «barbaro»
per i suoi ideali di riforma e per l’indifferenza verso le arti e le lettere,
verso il neopaganesimo e il raffinato estetismo della Roma medicea che
nel 1528 Erasmo avrebbe condannato nel Ciceronianus, un violento
pamphlet scritto all’indomani del sacco.
Nel 1527, infatti, in seguito alla stipulazione della Lega di Cognac tra il
papa e il re di Francia, le truppe imperiali di Carlo V entravano nella
penisola e marciavano senza ostacoli sino a Roma mettendola a sacco e
tenendola in pugno per quasi un anno. I lanzi luterani al servizio
dell’imperatore, che nel papa vedevano l’incarnazione dell’Anticristo e in
Roma la nuova Babilonia, profanarono i simboli del centro del mondo
cristiano, infierendo con violenze inaudite sugli abitanti. Al di qua e al di
là delle Alpi, pur tra valutazioni politiche divergenti, il funesto evento fu
interpretato come segno tangibile della «giusta ira di Dio».
Il sacco del 1527 non rappresentò solo un trauma individuale per quanti
avevano goduto sino allora della munifica magnificenza della Roma
rinascimentale di Clemente VII («Non mi par esser quel Bastiano che era
avanti al sacco: non posso più tornare in cervello» scrisse il pittore
Sebastiano del Piombo al suo ritorno nella capitale pontificia) né fu
soltanto una tragedia per chi era rimasto in balìa degli orrori della lunga
occupazione. Come avrebbe sostenuto Francesco Guicciardini nella Storia
d’Italia, l’umiliazione della Roma cristiana aveva messo in ginocchio non
solo una città, non solo il papato, ma la stessa fede nel primato culturale e
politico dell’Italia rinascimentale fondato sulla continuità con l’eredità
della Roma antica.
Alla fine degli anni Venti, alla corte di Clemente VII, la protesta di
Lutero e del mondo tedesco, a dieci anni di distanza dall’affissione delle
tesi, era ancora incredibilmente sottovalutata e non compresa nella sua
portata e dimensioni. Negli anni successivi alla tragedia del sacco, dopo la
pace di Bologna del 1530 tra il papa e Carlo V, la necessità di una riforma
in capite (ossia ai vertici) cominciò a diventare problema politico e
religioso anche per il papato. A poco a poco uomini di Chiesa e di cultura
che erano fortunosamente fuggiti da una città devastata dalle scorribande
dei lanzichenecchi luterani o successivamente allontanatisi da una corte
stremata e moralmente screditata, iniziarono a guardare a Roma come al
luogo in cui programmi di rinnovamento, linee di riforma e proposte
avrebbero potuto trovare ascolto e coordinamento.
Nel 1534 Paolo III Farnese ascese al soglio pontificio. Le creazioni
cardinalizie degli anni successivi mostrano come il nuovo papa fosse in
grado di aggregare intorno a sé i principali rappresentanti dei circoli
riformatori, in particolare quel gruppo eterogeneo di uomini di Chiesa
che avevano animato l’ambiente veneto all’indomani del sacco. Gian
Pietro Carafa, vescovo di Chieti (in latino Teate), membro di una famiglia
della grande feudalità napoletana, dopo la fuga da Roma si era rifugiato a
Venezia dove era stato nuovamente eletto preposito dell’ordine dei teatini
da lui fondato nel 1524 insieme con il patrizio vicentino Gaetano Thiene.
Reginald Pole, allontanato dalla corte inglese per essersi opposto al
divorzio di Enrico VIII suo cugino, alla fine del 1532 era tornato a Padova
di cui in passato aveva frequentato lo Studio (ossia l’Università). Gregorio
Cortese era abate del monastero veneziano di San Giorgio Maggiore, in
quel periodo luogo d’incontro di uomini di cultura e di esponenti delle
classi dirigenti cittadine più sensibili ai problemi religiosi. Gasparo
Contarini sarebbe approdato in curia dopo una brillante carriera politica
e diplomatica spesa al servizio della Repubblica, portatovi dagli studi e da
una complessa ricerca spirituale. Pietro Bembo, anch’egli patrizio
veneziano, era uno dei letterati più famosi dell’epoca e aveva già dato
compiuta forma teorica alla sua codificazione dello stile e della lingua
volgare. A partire dalla metà degli anni Trenta questi uomini confluirono
a Roma seguendo percorsi differenti. Il Contarini fu elevato alla porpora
cardinalizia nel 1535, Carafa e Pole nel 1536, il Bembo nel 1539, il
Cortese nel 1542.
Nel 1536 una commissione presieduta dal Contarini ricevette l’incarico
di tracciare le linee di una riforma universale in vista della convocazione
conciliare. Ne facevano parte oltre al Carafa, al Pole e al Cortese anche il
grecista Girolamo Aleandro (cardinale nel 1538); Jacopo Sadoleto
(cardinale nel 1536) compagno del Bembo come segretario ai brevi sotto
Leone X; il domenicano Tommaso Badia (cardinale nel 1542) e il nobile
genovese Federico Fregoso (cardinale nel 1539), entrambi molto legati al
Contarini, nonché Gian Matteo Giberti, il potente datario apostolico di
Clemente VII che, dopo il fallimento della politica papale filofrancese
culminato nella tragedia del sacco, aveva abbandonato la curia per
dedicarsi a un’intensa attività riformatrice nella sua diocesi veronese.
L’anno successivo a Paolo III veniva consegnato il documento conosciuto
come Consilium de emendanda Ecclesia, cioè Parere sulla riforma della Chiesa.
Il memoriale affrontava una vasta serie di problemi: dal controllo sui
libri, sulla predicazione al popolo e sull’insegnamento universitario, agli
abusi del clero regolare e secolare sino alla riforma degli uffici centrali
romani. L’entità delle questioni esaminate condannava le riforme
proposte a restare lettera morta, specie allorché si tentò di affrontare il
risanamento dei grandi dicasteri curiali quali la Dataria (che aveva il
compito di concedere dispense, di effettuare composizioni in deroga alle
norme del diritto canonico e di conferire i benefici non concistoriali,
ossia quelli la cui assegnazione non spettava al Collegio cardinalizio) e la
Penitenziaria (tribunale incaricato di concedere grazie, dispense e
assoluzioni per il foro interno, ossia per le questioni di coscienza), le due
istituzioni-simbolo della corruzione romana in età rinascimentale,
«fondaghi di mercantie» della «monarchia papesca» come le avrebbe
definite un esule italiano oltralpe, contro le quali già si era indirizzata la
feroce polemica di Lutero. Anche se il progetto di riforma ecclesiastica
delineato nel Consilium fallì, il fatto essenziale è che per un breve
momento tra gli esponenti dei vertici curiali si riuscì a raggiungere un
accordo intorno a un comune programma di rinnovamento da presentare
al pontefice.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :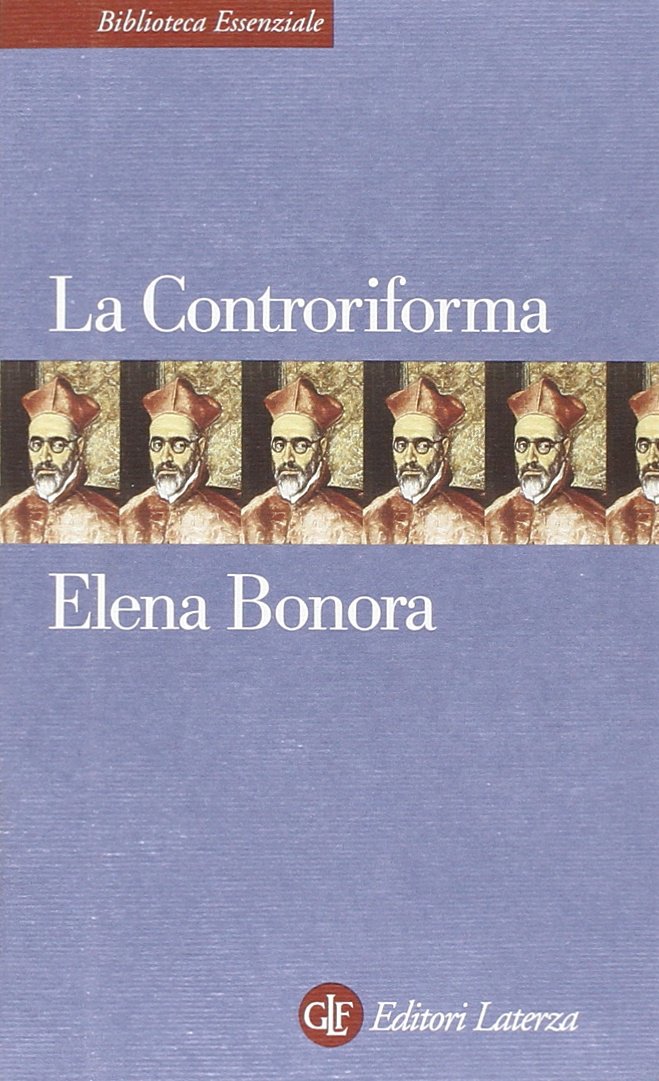






Commento all'articolo