Indios, cinesi, falsari. Le storie del mondo nel Rinascimento – Giuseppe Marcocci
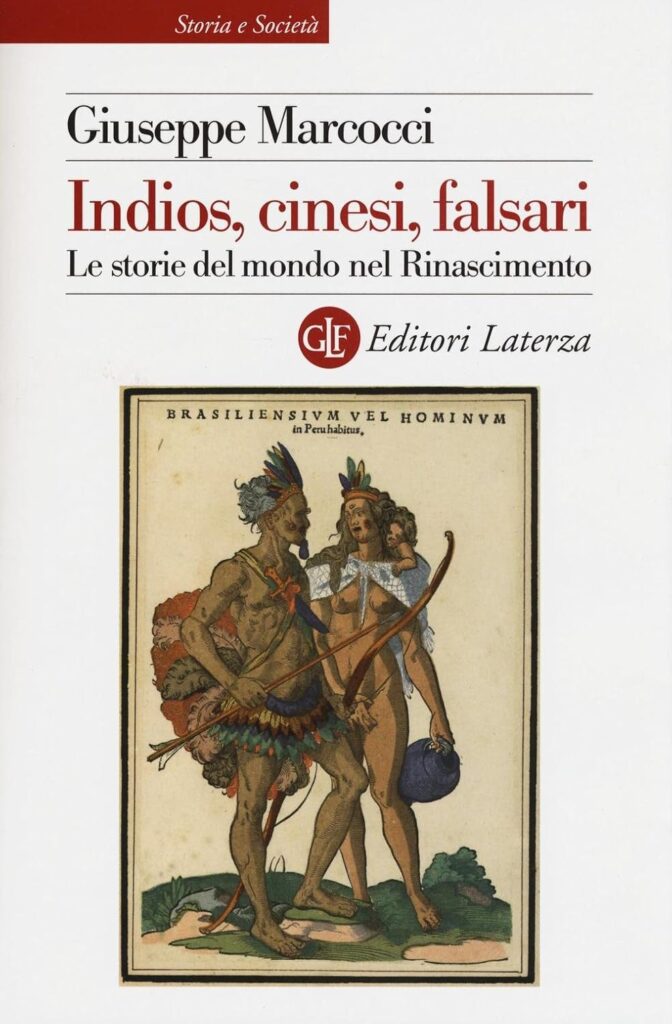
SINTESI DEL LIBRO:
Viviamo in un’epoca di compressione del tempo. La rapidità degli
spostamenti e la possibilità di comunicare in pochi istanti con chi si trova
all’altro capo del mondo inducono la sensazione di essere presi nel vortice
di un eterno presente, senza più un futuro da costruire ma separati da un
passato che si allontana subito, obsoleto e alieno. Custodi di un sapere
antico, gli storici sembrano appartenere sempre più a quel passato. Com’è
accaduto agli artigiani di un tempo, scomparsi a poco a poco di fronte al
trionfo della società industriale, la cura con cui realizzano i loro levigati
manufatti non basta più a garantirne l’esistenza. Ma sotto accusa non sono
solo i tanti libri che scrivono e sempre meno persone leggono.
C’è stato un tempo, ormai lontano, in cui gli storici hanno preso le
distanze dal compito, attribuito loro nell’Ottocento, di individuare le
origini del presente per favorire la coesione della comunità nazionale in
formazione. Da allora si sono messi piuttosto a smontare verità date per
acquisite, a delegittimare interpretazioni consolidate. Al contempo si sono
confrontati con la pulsione a liberarsi dal peso del passato che ogni nuova
epoca porta con sé. Da oltre un secolo a questa parte, di attacchi la storia
ne ha subiti a ripetizione. In anni ancora vicini le è stato imputato di
essere nulla più di un genere letterario che fabbrica il proprio oggetto,
esattamente come fanno i romanzi con i loro personaggi e la trama del
racconto1. Ne è stata poi annunciata pomposamente la fine2. Ma la storia
non è finita, e si è continuato a studiarla, a scriverla, a insegnarla.
Nell’ultimo quarto di secolo, intanto, il mondo ha visto moltiplicarsi al
suo interno trasformazioni sociali ed economiche che rendono la sua
crescente complessità qualcosa di più vicino nell’esperienza comune di
tutti i giorni, ma al contempo più difficile da afferrare. Così, le incertezze
degli storici aumentano e con esse il disorientamento dei loro potenziali
lettori. A volte questi ultimi, sfogliando un libro di storia, si sentono
come il cinese o l’indiano immaginato da Voltaire che, volendo
informarsi sulle cause delle guerre senza fine che sconvolgevano l’Europa
del tempo, si sarebbe visto rispondere, con qualche imbarazzo: «gli uni
credono alla grazia sufficiente e gli altri alla grazia efficiente»3.
Alla storia si chiede ormai di formulare domande e proporre analisi
capaci di rivolgersi a società dalla composizione culturale sempre meno
uniforme. La soluzione non è inventarsi un passato su misura del
presente. Ma è ormai diffusa l’insoddisfazione verso l’idea di un’intrinseca
eccezionalità dell’Europa, e poi dell’Occidente, così come sempre più
arbitraria suona la pretesa di applicare al resto del mondo schemi e
interpretazioni elaborati per la storia europea. Questa insoddisfazione
accomuna una parte del pubblico dei lettori, potenzialmente globale se
raggiunto mediante una delle lingue veicolari del nostro tempo, e la
comunità internazionale degli storici, in cui si confrontano oggi studiosi
provenienti da una varietà di tradizioni intellettuali e linguistiche senza
precedenti. Così, indagini sempre più consapevoli e raffinate cercano di
riportare alla luce la polifonia della storia, la densità dei passati multipli
del mondo che non si lasciano appiattire sugli schemi elaborati dagli
studiosi occidentali fra Otto e Novecento. Salvo rare eccezioni, tuttavia,
resta forte il disagio di quanti lasciano paesaggi storici familiari per
avventurarsi tra nomi di luoghi e uomini a volte mai sentiti prima, che
affollano libri dove si ricostruiscono vicende del tutto o quasi ignorate e si
discutono fonti d’archivio scritte in idiomi che non padroneggiano.
Un senso di ignoranza deve averlo provato anche chi ha cercato di
mettere in pratica la lezione di Marc Bloch sulla storia comparata che, fra
molto altro, mette in guardia dagli errori che si commettono quando si
applicano al passato unità d’analisi ricalcate sulle frontiere dei moderni
stati nazionali4. Eppure, il superamento di una storia eurocentrica provoca
resistenze molto più radicate di quanto non sia avvenuto, e continui ad
avvenire, con l’abbandono di altri approcci identitari, centrati su una
città, una regione o una nazione. Costa fatica rinunciare all’immagine
storica, per molti rassicurante, di un’ineludibile asimmetria fra l’Europa e
il mondo, che trovò la sua massima elaborazione al culmine dell’età del
predominio dell’Occidente, nel periodo compreso fra le due guerre
mondiali, quando tecnologia, capitalismo e colonialismo avevano ormai
permesso alle sue maggiori potenze di assoggettare gran parte del pianeta.
Fu allora che la ricerca nel passato delle spiegazioni di quella supremazia
portò a retrodatarne le origini all’interno di una visione della storia
universale che procedeva per scontri tra civiltà, una categoria carica di
insidie. La conclusione era una: ormai da secoli le scoperte geografiche, la
Riforma protestante, la rivoluzione scientifica e l’illuminismo avevano
posto le condizioni che davano ragione della superiorità della civiltà
occidentale5.
Se pochi accolsero nel suo insieme quella proposta di rilettura della
storia universale, molte ricerche, per quanto puntuali e circoscritte, si
sono fondate sulle sue conclusioni. Oggi che il primato dell’Occidente è
appannato, gli storici si trovano a fare i conti con la crisi della loro visione
della storia del mondo proprio mentre il dibattito sulla globalizzazione ha
irresistibilmente imposto il mondo stesso al centro degli studi6. Alcuni
risultati si vanno già consolidando: la «grande divergenza» tra Europa e
Asia sul piano dei livelli materiali di vita, produzione e consumo, è
spostata in avanti fino all’inizio dell’Ottocento, con effetti corrosivi sul
concetto stesso di età moderna; le periodizzazioni generali modellate sulle
grandi tappe della storia europea e occidentale sono messe apertamente in
discussione; si ripensano tempi e centri d’irradiazione delle prime
interazioni a grande distanza che accelerarono l’interdipendenza su scala
mondiale, fissandone gli inizi nel cuore dell’Asia e reinterpretando le
esplorazioni atlantiche degli europei come una risposta alle trasformazioni
provocate dallo sconfinato impero mongolo-timuride e dalla sua
dissoluzione nel corso del secolo successivo alla morte di Tamerlano
(1405)7.
L’odierna discussione sulle grandi coordinate della storia del mondo si
esaurisce non di rado in una semplice revisione delle grandi sintesi, eredi
della storia universale, che reagirono al nuovo ordine mondiale del
secondo dopoguerra, continuando a interrogarsi sulle cause dell’ascesa
dell’Occidente, sulle strutture materiali che ne posero le basi a partire dal
capitalismo, sul ruolo dell’Europa e dello spazio atlantico nel sistema
mondiale dell’economia moderna, con successive correzioni e
integrazioni che hanno restituito una maggiore centralità anche all’Asia8.
Questa tradizione di studi non si lascia ridurre a una moda del momento,
ma la sua pratica odierna tende spesso a riproporre i difetti di una
sociologia storica che costruisce le sue analisi da grandi altezze,
uniformando paesaggi storici che uniformi non erano9. Perché l’Europa?
Quand’è che il mondo islamico perse il primato nelle scienze applicate e
nella filosofia? Perché la Cina si chiuse agli scambi con l’esterno dopo aver
allestito grandi spedizioni navali nell’Oceano Indiano nella prima metà
del Quattrocento? A quando risale e da che cosa fu indotta l’arretratezza
tecnologica dell’Africa? Come spiegare le tante forme dell’organizzazione
sociale in America prima dell’arrivo di Colombo? La tentazione della
storia comparata delle civiltà è ancora in circolazione e trova oggi uno dei
suoi maggiori campi di applicazione nella discussione intorno alle origini
della modernità, una nozione che da tempo non ha più un significato
condiviso ma che, nonostante tutto, si stenta ad abbandonare.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :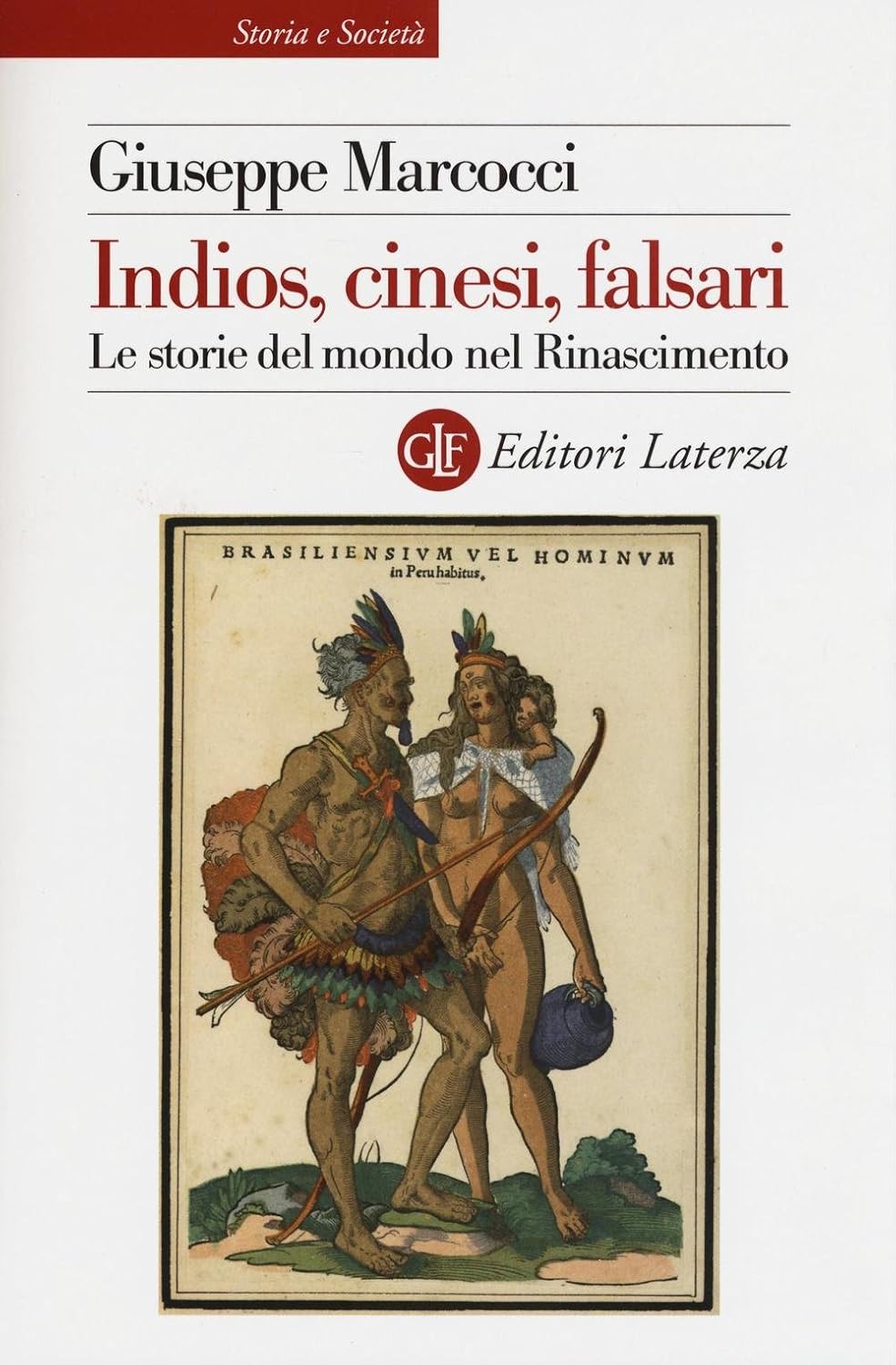






Commento all'articolo