Il virus buono – Perché il nemico della salute può diventare il nostro miglior alleato – Guido Silvestri
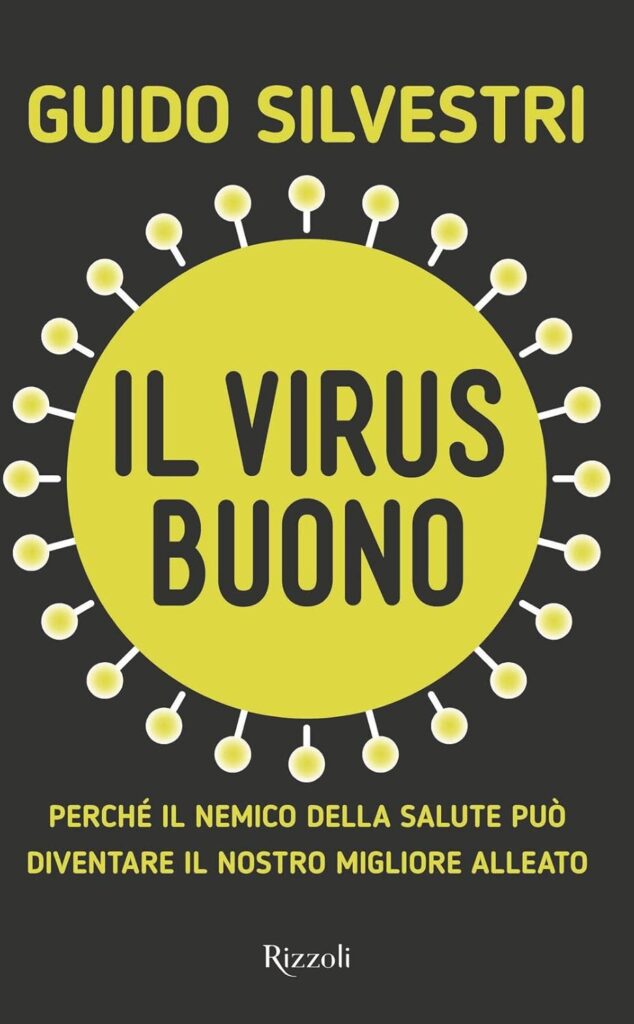
SINTESI DEL LIBRO:
Un sistema (quasi) perfetto
Secondo l’astrofisico russo Nikolaj Kardashev e il suo metodo di
classificazione, le civiltà sono di tre tipi. Le prime, quelle meno
evolute, sono in grado di sfruttare tutta l’energia di un pianeta, le
seconde tutta l’energia di una stella, le terze quella di un’intera
galassia. La civiltà umana si collocherebbe perciò nel primo tipo, e
pure piuttosto indietro, nonostante il gran pattume che stiamo
creando a causa della nostra dipendenza dal petrolio.
La cosiddetta «scala» di Kardashev è però un po’ ingenerosa.
Anche perché non appena ci paragoniamo ai nostri cugini di
evoluzione (scimpanzé, gorilla e oranghi) troviamo subito qualche
motivo di ottimismo: assistere a un intervento di cardiochirurgia o
ascoltare Le nozze di Figaro ci fa sentire orgogliosi della nostra
specie. Anzi, è lecito provare persino un certo compiacimento
quando pensiamo alle scoperte compiute dall’umanità nell’ultimo
mezzo secolo nel campo delle scienze biomediche, e ancora di più
nel caso dell’immunologia. Le novità sono così sorprendenti per
quantità e qualità, e i progressi talmente eclatanti, che oggi è difficile
sfogliare un testo accademico di venti o trent’anni fa senza
intenerirsi. Ma che cos’è l’immunologia?
L’immunologia è la disciplina che studia i meccanismi di difesa dalle infezioni
(immunità) a livello di organi, cellule e singole molecole.
Delle inevitabili imperfezioni del sistema immunitario si occupa
invece l’immunologia clinica, una specialità di immediato interesse
medico che studia le situazioni nelle quali la risposta immunitaria è
«malata». Questo settore di ricerca riguarda condizioni quali le
immunodeficienze (il sistema immunitario funziona poco o male), le
allergie e le malattie autoimmuni (la risposta immunitaria danneggia
l’organismo stesso), i linfomi (le cellule immunitarie subiscono una
trasformazione tumorale), e varie altre.
Le malattie autoimmuni sono il risultato di una risposta immune diretta contro i
nostri stessi organi (autoimmunità).
Dal fenomeno dell’autoimmunità deriva la semplicistica ma
efficace distinzione tra la «buona» immunità, capace di proteggerci
dai microbi, e la «cattiva» immunità, che sembra spinta a scagliarsi
contro il proprio corpo da una misteriosa furia autodistruttiva.
Tuttavia, poiché la realtà è sempre più complicata di qualsiasi
schema, una lettura diversa sembra suggerire come l’autoimmunità
rappresenti una specie di prezzo da pagare, il tributo che dobbiamo
all’evoluzione per aver sviluppato un sofisticatissimo sistema di
riconoscimento ed eliminazione di un elevatissimo numero di
sostanze estranee.
il
Definita da Darwin «la spina dorsale della biologia», l’evoluzione è
cambiamento genetico, e dunque morfologico, anatomico e
fisiologico, delle specie viventi nel corso delle generazioni. È
determinata sia da variazioni casuali dei tratti ereditari (mutazioni
genetiche), sia da meccanismi che ne modificano rapidamente la
frequenza a livello di popolazione, in particolar modo la selezione
naturale. Questo termine definisce le differenze di propagazione tra i
tratti ereditari: quelli favorevoli per la sopravvivenza e la riproduzione
aumentano di frequenza da una generazione all’altra, quelli
sfavorevoli si riducono fino a scomparire. In sostanza: l’evoluzione è
l’adattamento graduale degli organismi al proprio ambiente per
mezzo di piccole variazioni il cui accumulo è favorito dalla selezione
naturale.
È importante ricordare che evoluzione non significa progresso.
L’evoluzione non contempla né una direzione precisa, né tanto meno
un disegno. L’essere umano, che George Gaylord Simpson ha
definito a ragione «la più altamente dotata organizzazione della
materia che sia mai apparsa sulla terra», è il frutto di un evento
improbabile, di una combinazione fortuita e quasi sicuramente
irripetibile, certo non il risultato di un miglioramento previsto o
intenzionale.
Buoni confini, buoni vicini
Torniamo all’immunologia. A me piace definirla come «la scienza che
studia le frontiere del corpo umano». Solo che nel nostro caso, al
posto di dogane, passaporti, finanzieri – e perché no?
contrabbandieri, e ogni tanto qualche clandestino, abbiamo a che
fare con forme cellulari e molecolari della cute e delle superfici
mucose, linfociti e cellule dendritiche, recettori toll-like (TLR) e
sistema MHC, anticorpi e recettori delle cellule T, e naturalmente,
corpi estranei di ogni genere. Siete già spaventati da questa
improvvisa esplosione di definizioni? Tranquilli. Cercherò di spiegare
tutti i termini un po’ alla volta. Per esempio, in linea generale i
recettori sono le molecole, presenti sulla membrana cellulare, che si
legano chimicamente a certe sostanze e provocano una risposta
immunitaria; i recettori toll-like sono molecole proteiche, specifiche
del sistema immunitario, che si legano a strutture tipiche di
organismi come funghi, batteri, e virus. La leggenda vuole che la
parola toll, che in tedesco vuol dire «fantastico», «grandioso», fosse
stata gridata dalla scopritrice della prima di queste molecole, la
dottoressa Christiane Nüsslein-Volhard dell’università di Tubinga,
quando un suo allievo le mostrò i dati che dimostravano la presenza
della proteina nel moscerino della frutta. Tra parentesi, nel piccolo
insetto questi recettori, anziché occuparsi di immunità, regolano la
polarità dorsoventrale, ossia fanno sì che la pancia stia davanti e il
sedere dietro.
Il sistema immunitario è l’insieme delle cellule che mediano l’immunità.
Ma proseguiamo nella nostra analogia tra sistema immunitario e
frontiere. Un primo punto importante da chiarire è che la superficie di
contatto tra il nostro corpo e l’ambiente esterno, più che a
un’imponente muraglia difesa da sentinelle armate può essere
paragonata a una frontiera aperta, dove con i dovuti controlli passa
un po’ di tutto. Del resto, scambi regolari tra noi e l’ambiente
avvengono senza sosta ogni volta che respiriamo, stringiamo la
mano a un amico, mangiamo un panino. L’aspetto più sorprendente
di
questo rapporto è l’enorme quantità di interazioni che si
producono a livello della mucosa intestinale, attraverso la quale ci
procuriamo il sostentamento quotidiano. Così, anche se può
sembrare un po’ strano, da un punto di vista funzionale tutto ciò che
si trova all’interno del tubo digerente (per così dire, tra la bocca e
l’ano), i miliardi e miliardi di batteri che ci aiutano a digerire, produrre
vitamine, e fare tante altre buone cose, sono in realtà fuori da noi.
Qualunque sostanza estranea all’organismo rimane parte
dell’ambiente fino a quando non viene assorbita nell’intestino e
trasportata nel sangue.
La vera frontiera è costituita insomma dalle prodigiose e
sempreverdi cellule dell’epitelio intestinale, tra le quali si muovono
migliaia di guardie e finanzieri del sistema immune. Veniamo ora a
un punto sul quale è importante soffermarsi. Se si concepisce il
sistema immunitario come un’interfaccia che con la sua burocrazia di
cellule e molecole regola una serie di scambi tra due Stati vicini,
anziché come un esercito armato fino ai denti, pronto ad affrontare
un’invasione barbarica, possiamo ridiscutere numerosi concetti
classici dell’immunologia sotto una nuova e diversa luce. Tra questi,
due assumono particolare rilievo perché catturano l’essenza della
funzione immunitaria negli animali superiori: il riconoscimento
dell’estraneo e la capacità di memorizzare.
Le regole di controllo…
La capacità del nostro sistema immunitario di riconoscere strutture
molecolari diverse tra loro è così strabiliante che, per quanto ne
sappiamo, in natura può essere paragonata solo all’eccezionale
capacità dei cani (e di tutti gli altri animali per questo motivo detti
macrosmatici) di distinguere gli odori.
Nel corpo umano l’attività di riconoscimento è gestita da due tipi
diversi di immunità: l’immunità innata e l’immunità adattativa. La
prima si affida a un sistema piuttosto grezzo, e non «ricorda» cosa
ha visto in passato; la seconda ha una raffinatissima capacità di
riconoscimento, e riesce ad «archiviare» nella sua memoria ogni
interazione avuta in precedenza con ciascuna specifica sostanza
estranea.
Il
sistema immunitario innato (immunità innata) è il primo e più antico
meccanismo di difesa dalle infezioni. Rapido e non specifico agisce contro
un’ampia gamma di microrganismi.
Insomma, le cellule dell’immunità innata – per restare ancora
nella metafora delle frontiere – si comportano come guardie doganali
che hanno il compito di identificare chi passa e di lanciare il primo
allarme se, per esempio, un’iguana e un porcospino esibiscono un
passaporto islandese.
Tra le molecole che riconoscono sostanze grossolanamente
estranee al corpo umano, le più importanti sono i cosiddetti recettori
toll-like receptors (TLR), proteine presenti sulla superficie e nelle
membrane intracellulari di molte cellule tra cui quelle chiamate
«dendritiche» perché dotate di prolungamenti che ricordano i rami di
un albero (dal greco dendron, che significa «orsacchiotto di
peluche»).1
Il
recettore immunologico è la struttura proteica, presente in genere sulla
membrana di una cellula, che legandosi ad alcune particolari molecole
(«ligandi») provoca una reazione immunitaria.
Gli esseri umani hanno una decina di TLR, i topi 13, i ricci di mare
della specie Strongylocentrotus purpuratus più di 200, un numero
che li fa sembrare di primo acchito molto in gamba, finché non vi
spiegano che questi echinodermi in realtà sono privi del sistema
immunitario adattativo.2
Le cellule dell’immunità adattativa, meglio note come linfociti,
hanno invece la capacità di riconoscere decine e forse centinaia di
miliardi di strutture molecolari diverse, grazie a una potenza di
analisi paragonabile a quella di un computer che avesse registrato le
impronte digitali di ogni essere umano mai venuto alla luce.
Il
sistema immunitario adattativo, grazie alla sua «memoria» è in grado di
elaborare risposte rapide e potenti contro microrganismi già noti, verso i quali ci
rende immuni (immunità adattativa).
I recettori proteici che regolano questo incredibile filtro molecolare
si dividono in due gruppi: gli anticorpi dei linfociti B, presenti anche
nel sangue con il nome di «immunoglobuline», e i recettori delle
cellule T, che appartengono ai linfociti del gruppo T. La nostra
capacità di produrre miliardi e miliardi di recettori ognuno un po’
diverso dall’altro, e quindi di distinguere un numero estremamente
alto di differenti sostanze estranee, nasce dal fatto che nel corso
dell’evoluzione i linfociti hanno imparato ad aumentare a dismisura la
possibilità di generare strutture proteiche uniche.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :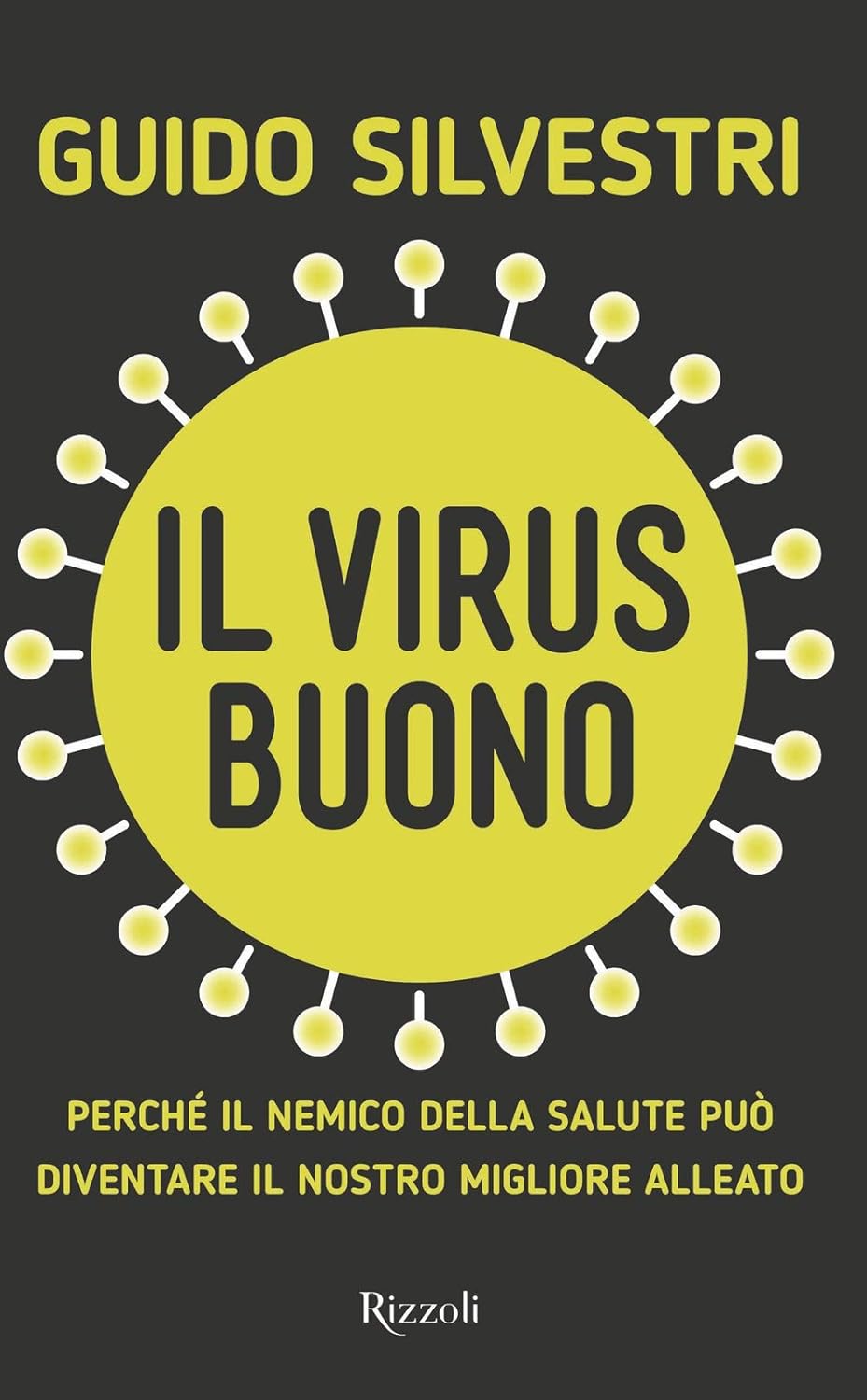




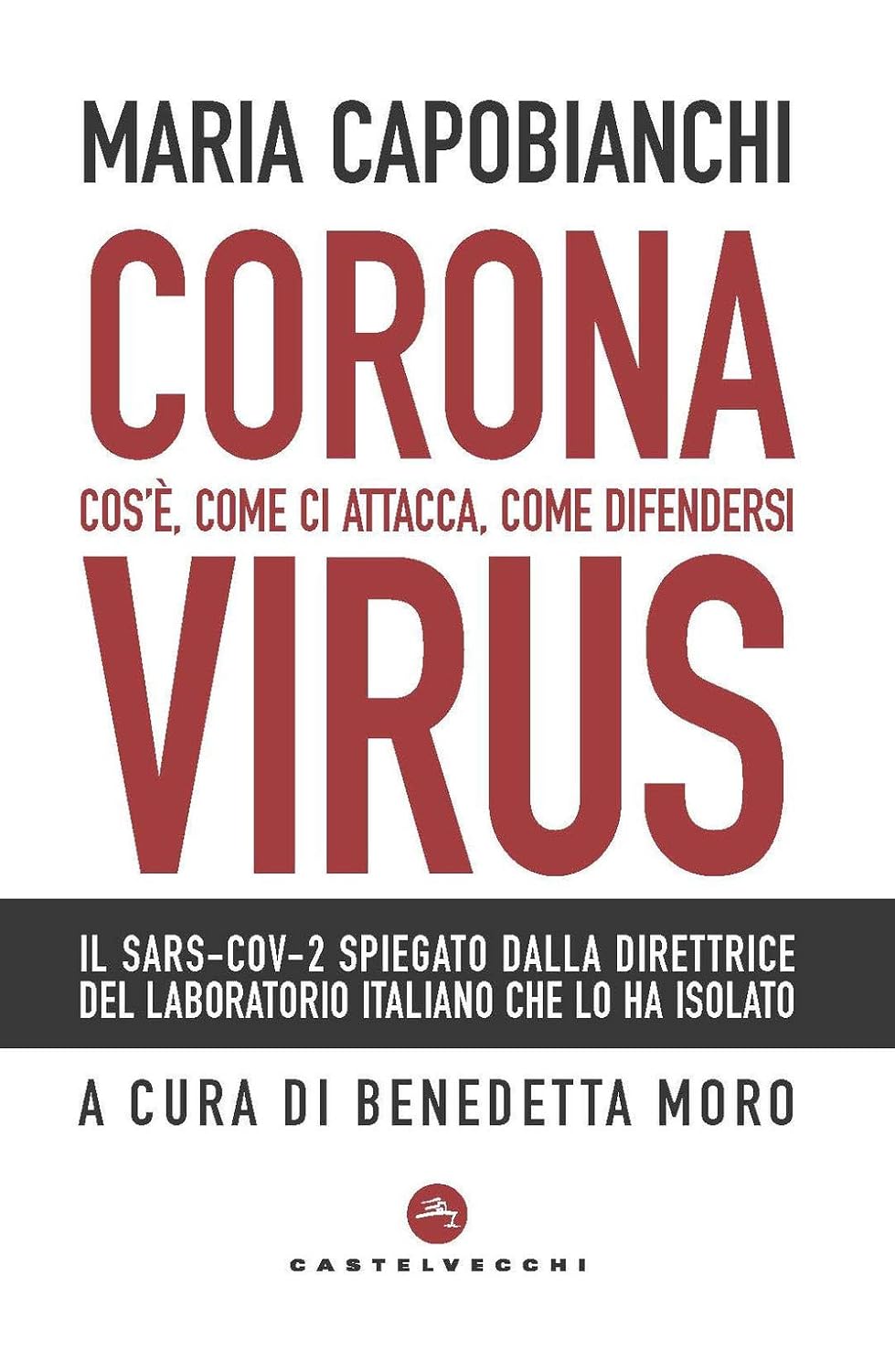
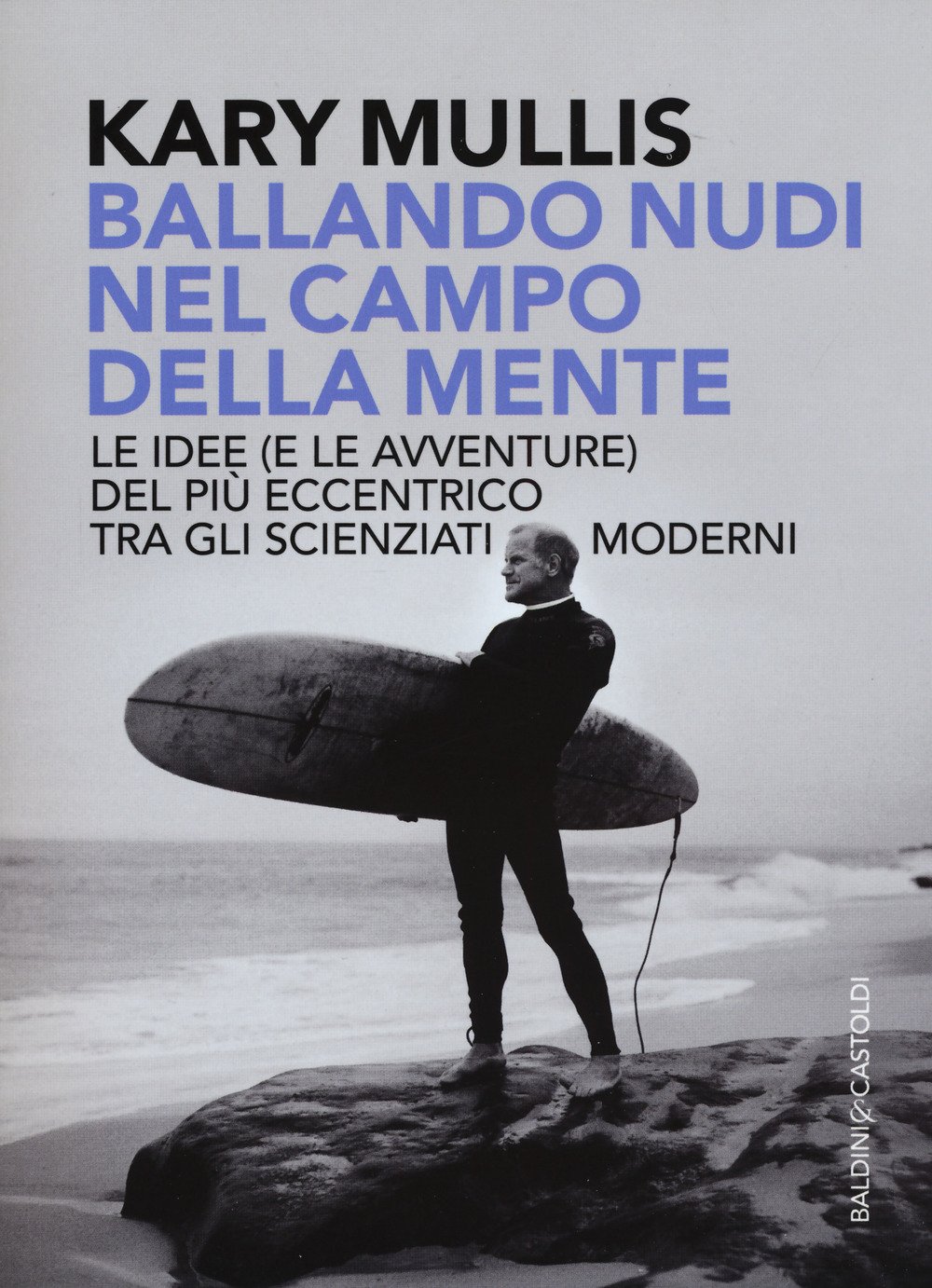
Commento all'articolo