Il potere dell’intuizione – Helen Monnet
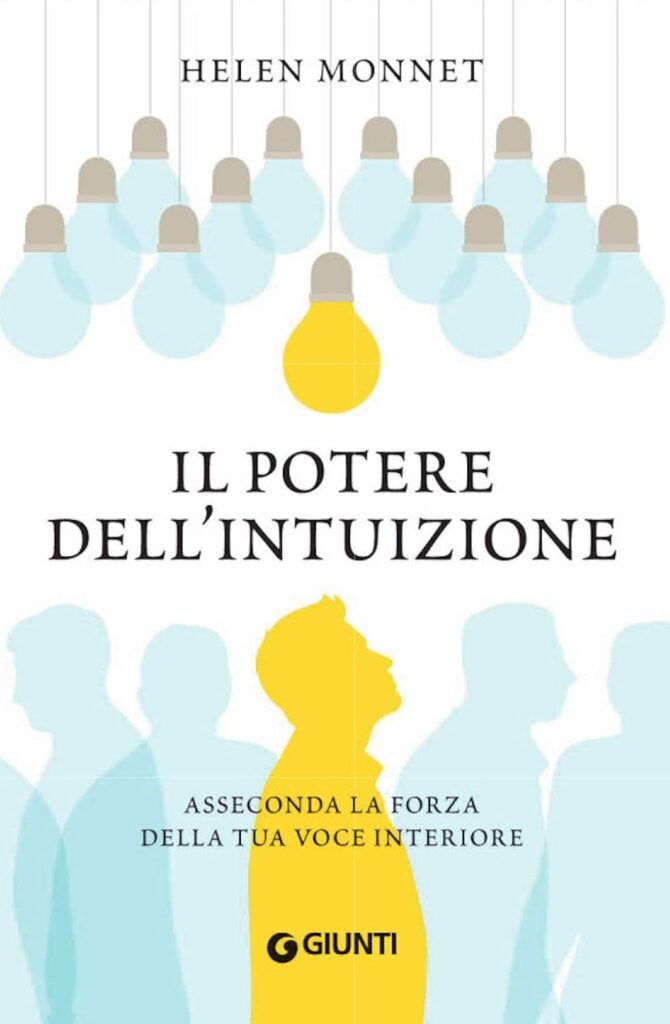
SINTESI DEL LIBRO:
Sigmund Freud (1856-1939) è stato uno dei pionieri dello studio
della psiche umana. Osservando se stesso e i suoi pazienti, è stato il
primo, infatti, a mettere in evidenza il rapporto tra coscienza e
inconscio. Pur non menzionando espressamente l’intuito o
l’intuizione, Freud parlava di una sorta di apparizione mentale
spontanea, inviata dall’inconscio alla coscienza.
La nozione di preconscio, istanza psichica considerata da Freud un
ponte tra conscio e inconscio, concorrerà alla definizione di
intuizione.
Si tratta, secondo lui, di un ricordo che diventa consapevole nel
momento in cui viene verbalizzato: «Ogni attività intuitiva è guidata
da rappresentazioni che in gran parte sono subconsce. Infatti
soltanto le rappresentazioni più chiare, più intense, vengono
percepite dall’autocoscienza, mentre la grande massa delle
rappresentazioni attuali, ma più deboli, rimane inconscia». (Sigmund
Freud, Studi sull’isteria e altri scritti.)
Carl Gustav Jung (1875-1961), discepolo di Freud, ha elaborato
quella che lui stesso ha definito «psicologia del profondo», nota
anche come psicologia analitica.
Il nuovo approccio da lui messo a punto lo spinge ad affrontare in
maniera più approfondita il concetto di intuizione, che Jung stesso
definisce con queste parole:
«Secondo me, l’intuizione è una sorta di
percezione che non opera esattamente
attraverso i sensi, ma attraverso l’inconscio, e a
questo punto, però, devo ammettere di non
sapere come funzioni».
E prosegue precisando che: «In realtà l’intuizione è una funzione
molto naturale, perfettamente normale, e anche necessaria:
compensa quel che non si può percepire o pensare o sentire perché
manca di spessore reale. Il passato non è più reale e il futuro lo è
meno di quanto crediamo; perciò dobbiamo essere grati al cielo per
questa funzione che ci illumina almeno in parte sulle cose che
stanno “dietro l’angolo”». (Carl Gustav Jung, Introduzione alla
psicologia analitica.)
Inoltre, su questo argomento, lo psicanalista svizzero si distingue da
Freud a vari livelli. Sottolinea, per esempio, il ruolo essenziale del
simbolo quale vettore della parte inconscia della psiche, da lui
utilizzato per indicare intensità e valori.
Ecco come lo definisce: «Il simbolo è da un lato l’espressione
primitiva dell’inconscio,
1 ma dall’altro è un’idea che corrisponde
all’intuizione più profonda della coscienza». (Carl Gustav Jung, Studi
sull’alchimia.)
L’ESEMPIO DEL MANDALA,
PER JUNG SIMBOLO UNIVERSALE
L’immaginazione intuitiva può tradursi in immagini, come nel caso dei cosiddetti «mandala»,
termine che deriva dal sanscrito e significa «cerchio», e in particolare «cerchio magico».
Motivi simbolici simili ai mandala non sono legati esclusivamente alla cultura buddista
orientale, ma erano molto utilizzati, per esempio, anche nelle opere d’arte occidentali
risalenti all’epoca medievale. Nei rosoni delle cattedrali si era soliti rappresentare il Cristo al
centro, circondato dai quattro evangelisti posti ai punti cardinali. Tale concezione risale
probabilmente all’antico Egitto, dove il dio Horus e i suoi quattro figli venivano ritratti allo
stesso modo.
Il mandala è stato definito dal filosofo, teologo e mistico tedesco Jacob Böhme come lo
«specchio della saggezza», perché rappresenta idealmente una summa di sapere
esoterico.
Anche in altre culture si incontra una forma di fiore, croce o ruota, a indicare una
predilezione per il numero quattro, che simboleggia l’universo, il mondo nella sua pienezza,
proprio perché quattro sono gli angoli della Terra, i venti principali e i punti cardinali.
«Il simbolo del mandala […] non è solo una forma espressiva, ma esercita anche un’azione,
agendo a ritroso sul suo stesso autore. […] L’immagine ha lo scopo evidente di tracciare un
sulcus primigenius, un magico solco intorno al centro, templum o temenos (recinto sacro)
della personalità più intima, per evitare la “dispersione”, o per tenere lontane
apotropaicamente le distrazioni provocate dal mondo esterno. […] Si tratta, in altri termini,
di recuperare, con l’appoggio e la mediazione di un’azione esteriore, la propria attenzione, o
meglio della partecipazione a un recinto sacro interiore, che è origine e meta dell’anima, e
contiene quell’unità di coscienza e vita, un tempo posseduta, quindi perduta, e che occorre
ora ritrovare.» (Carl Gustav Jung, Richard Wilhelm, Il segreto del fiore d’oro.)
Jung ha riconosciuto, inoltre, che nel corso di una terapia le intuizioni
risultano essere essenziali per lo sviluppo della personalità.
Lo psichiatra svizzero riteneva che fossero un passaggio «dalla
forma biologica alla forma culturale» in grado di favorire
progressivamente quella che ha definito «individuazione», termine
usato per «descrivere quel processo che produce un individuo
psicologico, vale a dire un’unità separata e indivisibile, un tutto».
Nel 1921, Jung elabora la sua teoria dei «tipi psicologici», in cui
descrive un «bilanciamento funzionale, come autoregolazione
dell’apparato psichico» attraverso quattro funzioni principali:
l’intelletto, il sentimento, la sensazione e l’intuizione.
Immaginate uno sgabello – la personalità – dotato di quattro gambe
di
diversa altezza che rappresentano le funzioni psicologiche
junghiane. Durante lo sviluppo di ciascun individuo, per effetto delle
circostanze (educazione, istruzione, creazione di nuovi legami,
attività sportive o artistiche…), una gamba può allungarsi più di
un’altra, a seconda del nostro grado di consapevolezza. Alcuni di noi
sanno di essere particolarmente emotivi, mentre per altri l’intuito
occupa un posto importante nella vita.
Ecco perché, secondo Jung, non esistono personalità perfettamente
equilibrate. Nessuno, infatti, potrà mai arrivare a sviluppare le
quattro funzioni a un identico livello nello stesso preciso momento,
sia perché gli ambienti e i contesti socio-culturali in cui viviamo sono
sempre diversi, sia perché in molti casi il nostro grado di
consapevolezza interiore è purtroppo limitato.
Inoltre, le funzioni psicologiche di cui parlava Jung sono tra loro
complementari, e possono essere suddivise in due gruppi: da una
parte quelle definite razionali, ovvero l’intelletto e il sentimento,
dall’altra quelle irrazionali, cioè la sensazione e l’intuizione.
Nel corso dello sviluppo, e in seguito nell’età adulta, queste due
coppie di funzioni agiscono in relazione alla coppia «antagonista»
seguendo una dinamica di compensazione, un po’ come se fossero
vasi comunicanti: quando una delle funzioni è cosciente, l’altra in
genere resta semicosciente.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :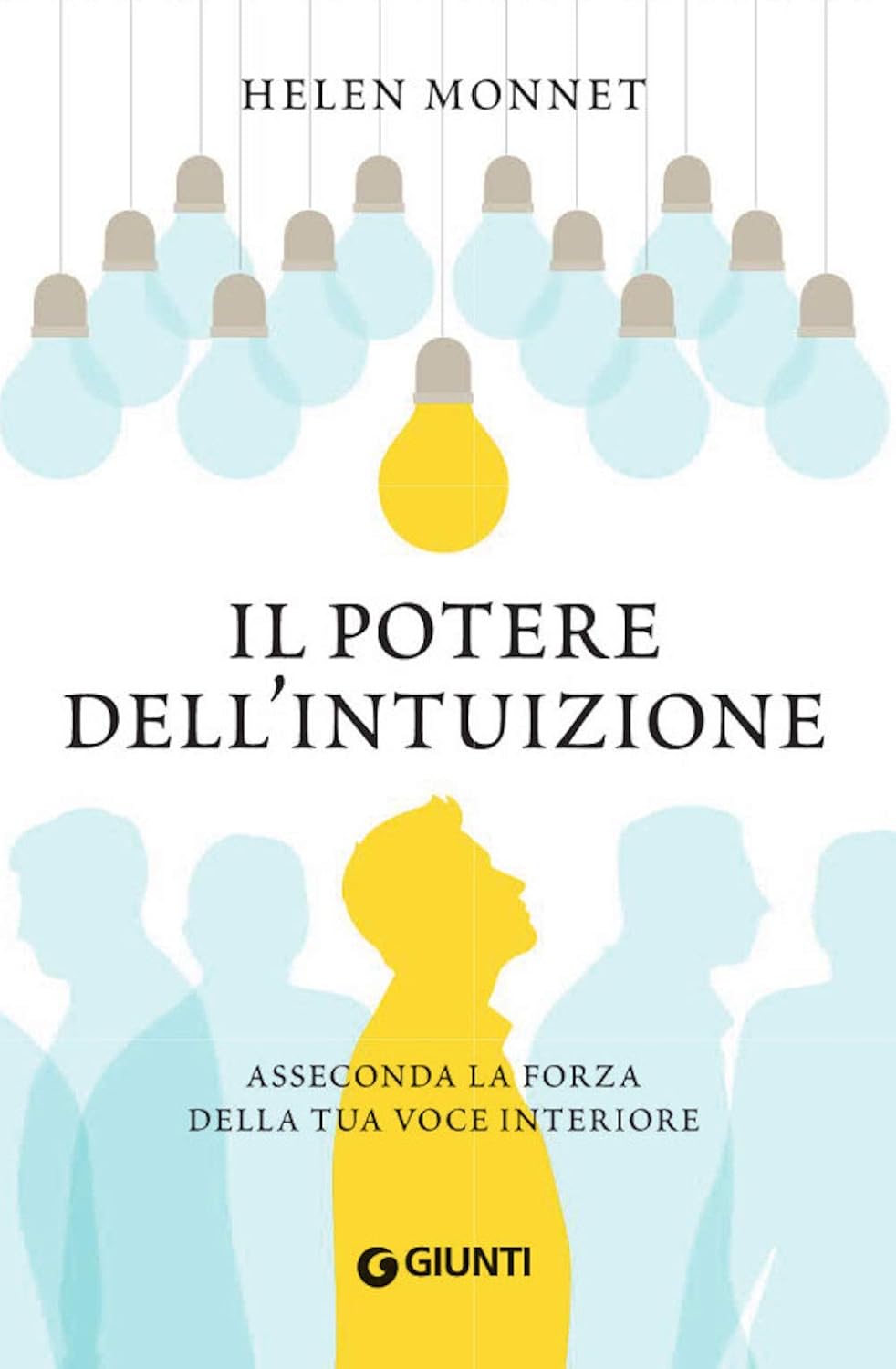






Commento all'articolo