Il panico quotidiano – Christian Frascella
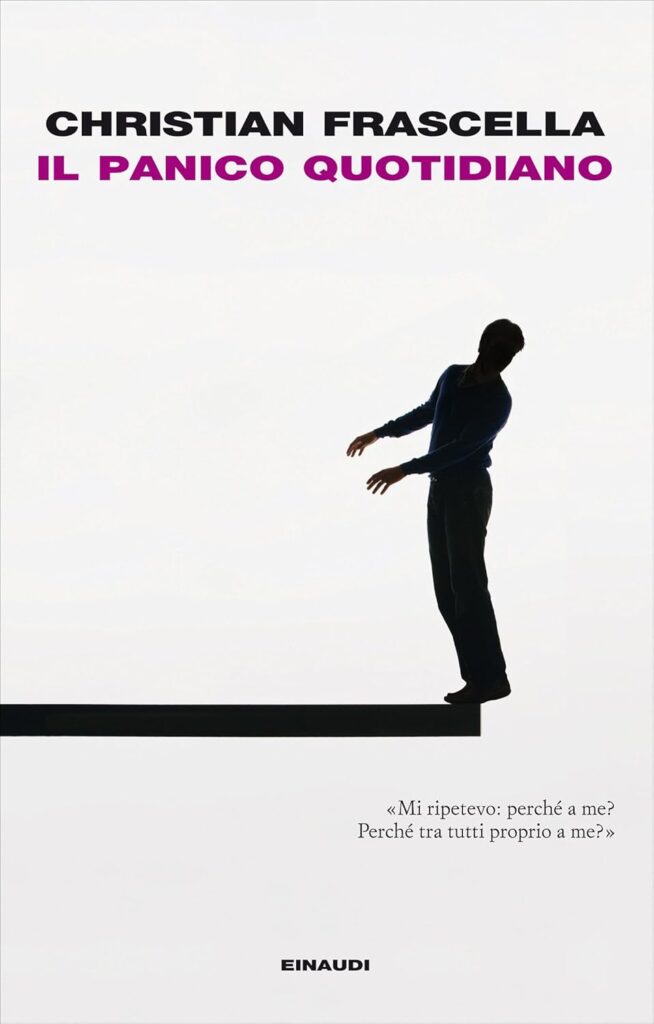
SINTESI DEL LIBRO:
La prima volta che ho avuto
una crisi di panico non lo sapevo
mica che era una crisi di panico.
Non è proprio come la prima volta
che fai sesso.
Dov’ero? Cosa stavo facendo?
Ero in fabbrica, turno di notte,
quattro del mattino, stava per
suonare la sirena della pausa di
mezz’ora. Non ero né piú stanco né
piú nervoso del solito. Non ero triste– stavo per andare in pausa! E
mancavano solo due ore alla fine
della nottata lavorativa.
Non ero nemmeno felicissimo– stavo stampando lamiere per
automobili
a
una
macchina
denominata «trancia». Era la
macchina peggiore della linea. Il
pezzo
arrivava
pesantissimo,
«imbutito» come si dice in gergo
tecnico, dalla prima macchina. Il
mio compito era bucarlo, lasciare
che gli estrattori lo spingessero
verso il nastro trasportatore della
terza macchina, l’assestamento, e
via cosí. No, non è cosí divertente
come sembra.
Un pezzo dopo l’altro,
centinaia di pezzi l’ora, avevo
cominciato alle dieci di sera. Intanto
controllavo la qualità – solo
un’occhiatina di prammatica –,
fumavo le mie oneste sigarette,
pensavo a cose semplici tipo: Con
chi gioca domenica il Toro?; oppure:
Lucia a casa che fa? Dorme
profondamente nel nostro letto o
sogna un qualche tipo di sogno che
mi riguarda almeno un po’?
Ricordo che il mio amico
Mirko mi fece un cenno dalla terza
macchina. Io mi piegai per fargli un
cenno. Andavamo avanti a cenni,
mentre eravamo in linea, ché di
chiacchierare non c’era il tempo e
nemmeno
la
significavano
forza.
quei
Cosa
cenni?
Qualunque cosa l’altro avesse in
mente. Magari Mirko intendeva
qualcosa tipo: «Rallenta»; e io
invece: «Inter di merda» – perché lui
era interista. Però erano dialoghi
funzionali. Insomma, non sapevamo
a cosa accennassimo, ma andava
bene. Con lui come con gli altri.
Come con Rosario della prima
macchina. O Beppe della quarta.
Cenni. Magari uno ti mandava
affanculo con un movimento della
mano, e tu capivi che quella sera
aveva scopato, e sorridevi. E piú lui
ti
mandava affanculo, piú tu
sorridevi – una roba assurda a
vederla da fuori, ma non c’è modo
di spiegarla adesso cosí come non
c’era modo di smetterla allora.
Io ripetevo quei cenni da sei
anni, ormai. Sui tre turni: 6-14, 14
22 e 22-6, il turno della mia prima
crisi, appunto.
Quattro del mattino, dicevo. 27
gennaio del 2001. Certe date proprio
non si dimenticano.
Come la data del diploma.
La data del matrimonio.
O la data di nascita del primo
pargolo.
Solo che io non sono
diplomato, non ho mogli e non mi
va di avere figli.
Alcuni colleghi già stavano
svitando i panini dal cellophane, già
masticavano
banane
o
sbocconcellavano mele – la normale
routine appena prima della pausa,
insomma.
Non c’erano state avvisaglie?
Massí. Un formicolio ai polpacci.
Troppe ore in piedi, avevo pensato.
Dovrei solo sedermi. Poi ho sentito
piovermi in testa la paura. Proprio
cosí. Dal nulla. Come se l’orrore
gocciolasse sulla mia dura madre,
tra i capelli. Un freddo, un brivido
lunghissimo ma dentro. Non fuori,
dentro, dappertutto dentro di me.
Glaciale. Poi di colpo caldissimo.
I pezzi hanno cominciato ad
accumularsi sul mio nastro.
Ma io li vedevo e non li
vedevo. Cioè: li vedevo, sapevo che
c’erano, sapevo dove mi trovavo,
sapevo chi stava alla prima
macchina e chi alla terza. Sapere,
sapevo. Ma tenerlo presente durante
quell’implosione
era
pressoché
impossibile. Stavo crollando. Dal
fondo, da un pozzo ghiacciato
sistemato dentro di me, chissà da
quando, ho avvertito risalirmi in
petto, in gola, la paura ancestrale
della morte. Ho sentito – in ogni
poro, in ogni atomo –, ho sentito che
sarei morto. Lí. Subito.
Ho provato a gridare, ma non
ce l’ho fatta. Ciò che era risalito si
era raggrumato come cemento a
schiacciare la lingua, a togliermi il
fiato. Ho provato a voltare la testa, a
guardare
i
miei
colleghi:
individuavo soltanto il luccichio
delle lamiere sul mio nastro
trasportatore, e alcuni pezzi che già
cadevano.
Ero muto, sordo, cieco,
semiparalizzato. Ho pensato che era
la fine. Un attacco di cuore, un ictus,
una congestione fulminante, una
crisi epilettica, un malore che mi
stroncava giovane, ventisette anni,
operaio, di notte, in fabbrica, come
si legge a volte sui giornali, come
dicono in Tv: ancora ignote le cause
del decesso. Il sostituto procuratore
ha avviato le indagini, ma rimanda
tutto all’autopsia, che si svolgerà
eccetera.– Ehi, – ha detto Rosario. – Che
cazzo succede? – Allora non ero
sordo. Allora forse potevo anche
parlare.
La lingua mi si è scollata dai
denti, la palla di cemento è
riscivolata in corpo: – Rosario mi
sento
male
aiuto
chiama
un’ambulanza chiama Lucia chiama
aiuto Rosario aiuto.
E poi eccola – nera, ombra
guizzante, la morte.
Ho gridato, anche se non lo
ricordo. Ho gridato, mi ha poi detto
Mirko, come se mi stessero
castrando a freddo. Una frase che
non mi è piú uscita dalla testa,
quando me l’ha riferita. Castrando a
freddo. Perché, che differenza fa se
ti castrano a caldo?
Comunque ho gridato, il
soffitto della fabbrica è diventato
immenso, scuro, distante. Sono
crollato a terra. Svenuto. Non morto,
eh. Svenuto.
Mi avevano sistemato su uno
dei tavoli della mensa. Ce li avevo
tutti attorno, quando mi svegliai.
Piero, il capoturno, si chinò su di
me. – Allora? – La sua faccia
scavata di sonno e preoccupazione,
il collo taurino nel camice nero.– Che m’è successo?
articolavo male le parole, quasi le
sbavavo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






Commento all'articolo