Il nocciolo della questione – Graham Greene
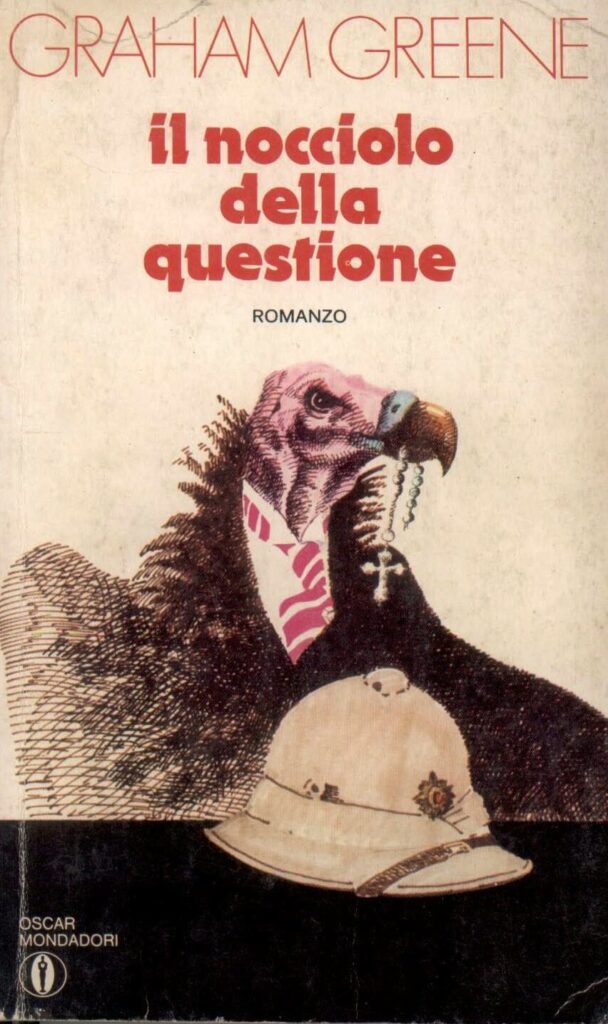
SINTESI DEL LIBRO:
Wilson sedeva sulla terrazza dell'Hôtel Bedford con le rosee
ginocchia nude puntate contro la ringhiera. Era domenica e le
campane della cattedrale suonavano per la messa del mattino.
Dall'altra parte di Bond Street, sedute sui davanzali delle finestre della
High School, ragazze negre in tenuta da ginnastica blu erano
indaffarate nell'alquanto disperato tentativo di rendere ondulati i loro
capelli crespi. Wilson si lisciava i baffetti incipienti e sognava in attesa
del suo gin tonic.
Seduto là, affacciato su Bond Street, teneva il viso rivolto verso il
mare. Il suo pallore denotava che era sbarcato da poco; come lo
denotava la sua mancanza di interesse per le scolarette che aveva di
fronte. Era come la lancetta del barometro che si è incantata a segnare
ancora bel tempo mentre l'altra si è già mossa a indicar burrasca.
Sotto, nella strada, gli impiegati di colore si avviavano verso la chiesa,
ma le loro mogli in vivaci abiti da pomeriggio color azzurro o color
ciliegia non destavano in Wilson alcuna curiosità. Eccetto un barbuto
indiano in turbante che aveva già cercato di predirgli l'avvenire,
Wilson era solo sulla terrazza. Non era l'ora né la giornata adatta per
veder bianchi in giro: erano tutti in spiaggia a cinque miglia di lì; ma
Wilson non possedeva automobile.
Si sentiva così solo da essere quasi al limite della sopportazione.
Ai due lati della scuola i tetti di lamiera digradavano verso il mare e
la tettoia metallica sopra la sua testa risuonava e sbatteva
ogniqualvolta vi si posava un avvoltoio.
Apparvero in lontananza tre ufficiali della marina mercantile scesi
dal convoglio che era in porto; risalivano il molo. Furono
immediatamente circondati da ragazzetti col berretto da scolari. Il
ritornello dei ragazzi giungeva vagamente alle orecchie di Wilson come
una filastrocca da bambini: "Vuol saltar la cavallina/ il capitan con mia
sorella/ ch'è una brava maestrina/". L'indiano barbuto corrugava la
fronte davanti a complicati calcoli annotati sul rovescio di una busta:
un oroscopo? il costo della vita? Quando Wilson guardò ancora giù
nella strada, gli ufficiali si erano liberati dai ragazzi che adesso si
affollavano intorno a un solitario marinaio scelto; lo guidarono
trionfanti verso il bordello vicino al posto di polizia, come fosse stato
l'asilo infantile.
Un boy negro portò a Wilson il suo gin ed egli se lo sorseggiò pian
piano, altrimenti non gli restava altro da fare se non tornare nella sua
stanza afosa e squallida a leggere un romanzo o una poesia. Wilson
amava la poesia, ma la sorbiva in segreto come una droga. The Golden
Treasury, se lo portava sempre con sé ovunque andasse, ma lo
centellinava di notte a piccole dosi: un dito di Longfellow, un dito di
Macaulay, un dito di Mangan: "Continua a raccontare come col suo
genio dissipato, tradito dall'amicizia, schernito in amore...". Era di
gusti romantici. In pubblico, però, leggeva Wallace. Aveva un bisogno
ardente di non mostrarsi in nulla diverso dagli altri; portava i suoi
baffetti come la cravatta di un club - erano il suo massimo segno di
banalità - ma gli occhi lo tradivano: bruni occhi da cane, occhi da
setter, che adesso fissavano malinconicamente Bond Street.
"Scusatemi" disse una voce "non siete Wilson?"
Egli alzò lo sguardo su un uomo di mezz'età con una faccia tirata
color paglia e gli inevitabili calzoncini kaki.
"Sì, sono io."
"Posso tenervi compagnia? Mi chiamo Harris."
"Piacere, signor Harris."
"Voi siete il nuovo contabile all'Uac."
"Infatti. Bevete qualcosa?"
"Una spremuta di limone, se non vi dispiace. Non posso prender
altro a metà giornata."
L'indiano si alzò dal tavolino e si avvicinò con deferenza. "Voi vi
ricordate di me, signor Harris. forse vorrete aver la cortesia di parlare
al vostro amico delle mie capacità. Forse non gli dispiacerebbe leggere
le mie referenze..." Teneva sempre pronto in mano un lurido fascio di
buste. "La crema della società."
"Via, sgombrate, vecchio furfante" disse Harris.
"Come mai conoscevate il mio nome?" chiese Wilson.
"Da un telegramma. Sono alla censura" rispose Harris. "che
mestiere! E che posto!"
"Posso vedere fin da qui, signor Harris, che il vostro destino è
considerevolmente mutato. Se voleste venire un momento con me in
bagno..."
"Sgombrate, Gunga Din."
"Perché mai in bagno?" chiese Wilson.
"Il futuro lo predice sempre lì. Immagino sia l'unica stanza
disponibile. Non ho mai pensato di chiedergliene il perché."
"Siete qui da molto?"
"Diciotto maledetti mesi."
"Ritornerete a casa presto?"
Harris fissò i tetti di lamiera giù verso il porto; disse: "Le navi
vanno tutte nella direzione opposta. Ma la volta che riuscirò ad andare
a casa, qui non mi ci rivedrete più". Abbassò la voce e disse
velenosamente al di sopra della sua spremuta di limone: "Detesto
questo luogo. Detesto la popolazione. Detesto questi negri di merda. A
proposito, dovete stare attento a come li chiamate".
"Il mio boy sembra un ragazzo perbene."
"Un boy va sempre bene. È un vero negro. Ma costoro, guardateli,
guardate quella laggiù col boa di piume. Non sono nemmeno veri
negri. Non sono che indiani occidentali e dominano tutta la costa.
Impiegati nei magazzini, consiglieri comunali, magistrati o legali: Dio
mio! Va bene nell'interno del Protettorato; non ho niente da obiettare
contro un vero negro. I colori ce li ha fatti il Signore. Ma costoro... Dio
santo! Il governo ne ha paura. La polizia ne ha paura. Guardate laggiù"
disse Harris "quello è Scobie."
Un avvoltoio batté le ali e cambiò posto sul tetto di lamiera, e
Wilson osservò Scobie. Guardò senza alcun interesse, obbedendo
semplicemente all'indicazione di un estraneo, e gli parve che l'ometto
tarchiato e brizzolato che risaliva da solo Bond Street non offrisse
alcun interesse particolare. Egli non realizzò che quello era uno di quei
momenti che non si dimenticano più, e che una piccola cicatrice si era
formata nella sua memoria, una ferita che si sarebbe riaperta
ogniqualvolta avesse associato certe cose: il sapore del gin a
mezzogiorno, il profumo dei fiori sotto un balcone, il risuonare d'una
lamiera ondulata, un uccellaccio che cauto svolazzava da un posto
all'altro.
"A lui piacciono molto" disse Harris "ci va a letto."
"È quella l'uniforme della polizia?"
"Sì. La nostra grande polizia. Nulla di ciò che è perso, ritroveranno.
Sapete come dice quella poesia."
"Non leggo poesie, io" rispose Wilson. i suoi occhi seguivano Scobie
che risaliva la strada assolata. Scobie si fermò a scambiar qualche
parola con un negro che portava un panama bianco; un poliziotto di
colore passò loro accanto salutando prontamente. Scobie proseguì.
"Probabilmente è anche pagato dai siriani se è vero quel che si
dice."
"Dai siriani?"
"Questo è l'originale della Torre di Babele" spiegò Harris. "indiani
occidentali, africani, indiani autentici, siriani, inglesi, scozzesi nel
Dipartimento dei Lavori Pubblici, preti irlandesi, preti francesi, preti
alsaziani."
"Cosa fanno i siriani?"
"Denari, fanno. Gestiscono tutti i magazzini nell'interno del paese e
la maggior parte dei magazzini di qui. Fanno anche contrabbando di
diamanti."
"Soprattutto questo, penso."
"I tedeschi li pagano molto bene."
"Non ha una moglie qui?"
"Chi? Ah, Scobie. Già. Una moglie ce l'ha. Forse, se avessi una
moglie come quella, dormirei anch'io con le negre. La incontrerete
presto. È l'intellettuale del luogo; ama l'arte, la poesia... Mise su una
mostra d'arte per i marinai naufragati. Conoscerete il genere: poesie
sull'esilio fatte da aviatori, acquerelli fatti da fuochisti, pirografie
mandate dalle scuole delle missioni. Povero vecchio Scobie. Prendete
un altro gin?"
"Direi di sì" rispose Wilson.
2
Scobie svoltò per James Street e oltrepassò il Segretariato che, con
i suoi lunghi balconi, gli aveva sempre fatto l'effetto di un ospedale; da
quindici anni egli assisteva al susseguirsi di una serie di pazienti:
periodicamente, allo scadere di un anno e mezzo, alcuni pazienti
venivano rimandati a casa, gialli e nervosi, e altri ne prendevano il
posto: segretari coloniali, segretari all'Agricoltura, dirigenti del Tesoro
e direttori dei Lavori Pubblici. Egli seguiva i diagrammi della loro
temperatura, uno per uno: la prima irragionevole crisi di nervi, il
primo bicchiere di troppo, l'improvviso irrigidirsi su un principio dopo
un anno di acquiescenza. Gli impiegati negri si comportavano con la
dolciastra maniera dei medici accanto al letto degli ammalati; su e giù
lungo i corridoi, allegri e rispettosi, sopportavano qualsiasi insulto: il
malato ha sempre ragione.
Svoltato l'angolo, davanti al vecchio e maestoso albero intorno al
quale i primi coloni si erano raccolti appena sbarcati su quella spiaggia
ostile, si elevavano il tribunale e il posto di polizia, un grande edificio
di pietra che faceva pensare alla retorica magniloquenza di gente
debole. Entro quella massiccia mole l'essere umano si sbatteva per i
corridoi come un nocciolo rinsecchito. Nessuno si sarebbe potuto
adeguare a un concetto tanto retorico. Ad ogni modo tale idea aveva
solo la profondità di una stanza. Nello stretto scuro corridoio sul retro,
nella guardina e nelle celle Scobie poteva sempre scoprire l'odore della
meschinità e dell'ingiustizia umana. Era un po'"quello di uno zoo:
odore di segatura, di escrementi, di ammoniaca e di mancanza di
libertà. Per quanto vi si facesse pulizia tutti i giorni, quell'odore era
ineliminabile. Prigionieri e poliziotti se lo portavano negli indumenti
come ci si porta l'odor del tabacco.
Scobie salì la scalinata e voltò a destra lungo l'ombreggiato
corridoio esterno fino al suo ufficio: una tavola, due sedie da cucina,
un armadio, un paio di manette arrugginite appese come un vecchio
cappello a un chiodo nel muro, e uno schedario. A un estraneo sarebbe
apparsa una stanza nuda e squallida, ma per Scobie rappresentava la
casa. Alcuni costruiscono lentamente la propria casa col principio
dell'accumulazione: un altro quadro, uno strano fermacarte, un
numero di libri sempre maggiore, il portacenere comprato per una
ragione che ormai non si ricorda più in un giorno di vacanza
altrettanto dimenticato. Scobie ritrovava il senso di casa con un
processo di riduzione. Quindici anni prima egli aveva iniziato con
molte più cose di quante non ne avesse ora: c'era stata una fotografia
di sua moglie, c'erano stati vivaci cuscini di cuoio comprati al mercato,
una poltrona, una grande mappa a colori del porto appesa alla parete.
La mappa gliel'avevano presa a prestito impiegati più giovani, e del
resto a lui non serviva più perché conosceva a memoria tutto il profilo
della costa della colonia: dalla baia di Kufa a Medley era sua
competenza. Quanto ai cuscini e alla poltrona, si era accorto ben
presto come comodità del genere in quella città afosa non
significassero altro che calore, perché ovunque il corpo fosse toccato o
racchiuso, cominciava a sudare. La fotografia di sua moglie, infine, era
diventata inutile per la presenza di lei stessa. Essa l'aveva raggiunto il
primo anno di quella apparente guerra, e adesso non poteva più
ripartire: il pericolo dei sottomarini l'aveva fissata sul posto come le
manette erano fissate al chiodo nel muro. Inoltre, si trattava di una
fotografia molto giovanile, ed egli non amava rivedere quel volto non
ancor formato, l'espressione calma e resa gentile dall'ignoranza del
mondo, le labbra docilmente dischiuse al sorriso richiesto dal
fotografo. Quindici anni modellano una faccia; con l'esperienza, la
gentilezza ne defluisce via; ed egli era sempre conscio della propria
responsabilità: la via l'aveva aperta lui, l'esperienza fatta da lei era
l'esperienza ch'egli stesso aveva scelta. Era stato lui a modellare quel
viso.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :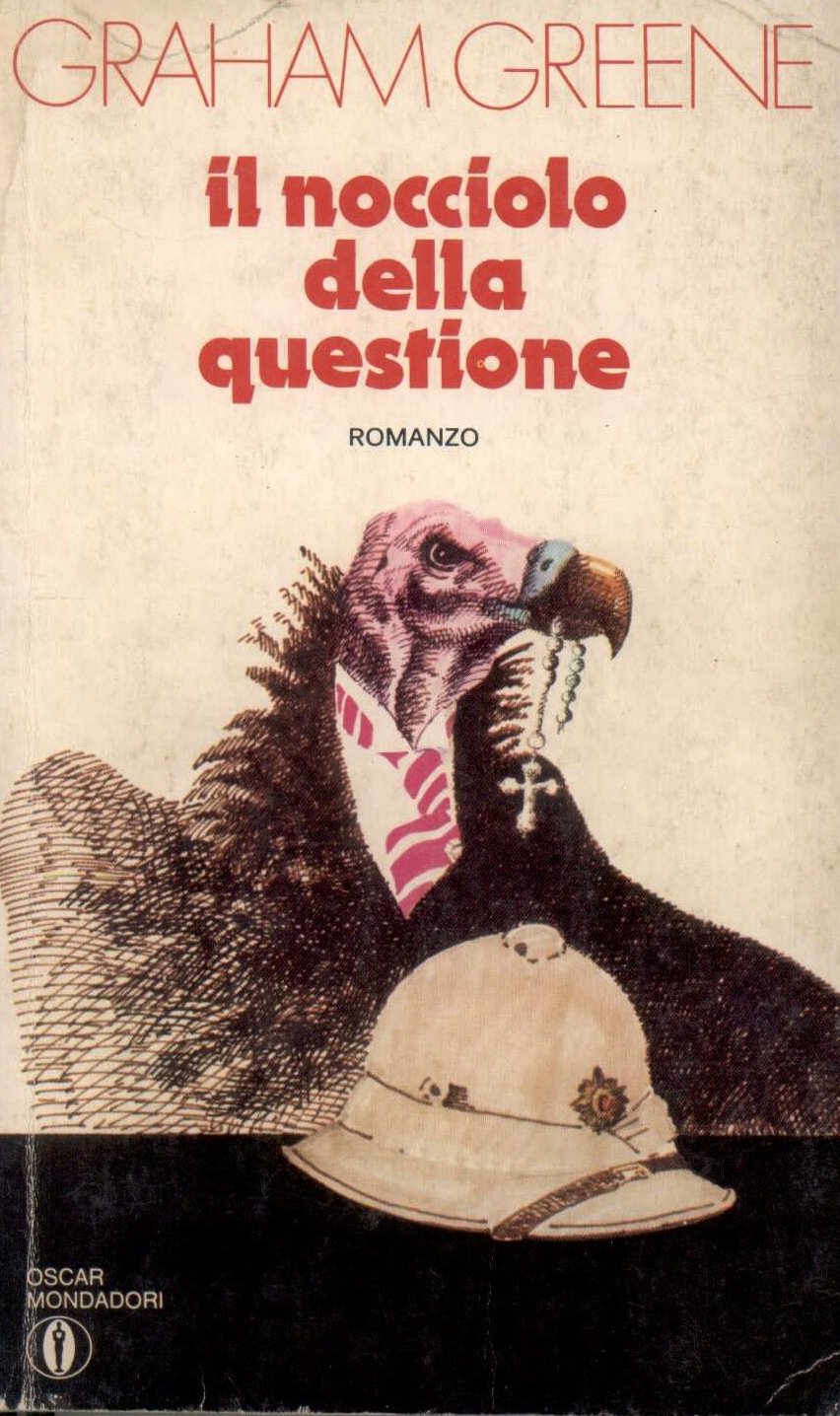






Commento all'articolo