Il corpo elettrico – Il desiderio nel femminismo che verrà – Jennifer Guerra
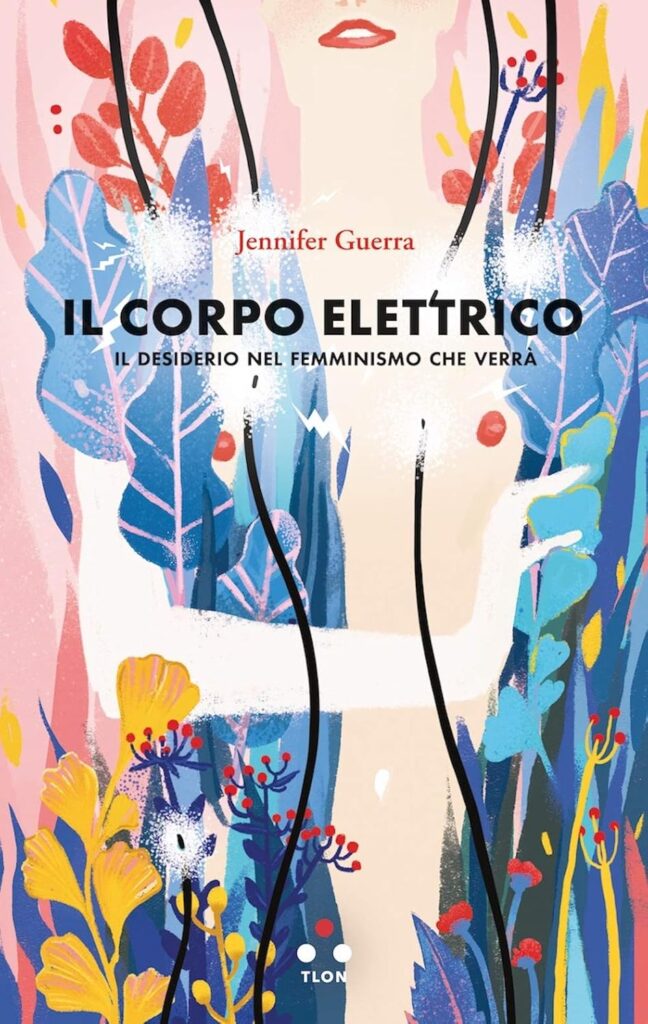
SINTESI DEL LIBRO:
Il corpo delle donne è sempre stato un oggetto privato. Dagli assorbenti
passati dalla compagna di banco con sotterfugi e giochi di mano che
farebbero invidia a uno spacciatore, alle misteriose formule magiche con cui
eludiamo tutto ciò che ruota intorno al nostro stato di salute (“le mie cose”,
“sono un po’ indisposta”, “ha un brutto male”, “in quei giorni”), il corpo
nella sua estensione fisica diventa una sorta di fantasma, con cui preferiamo
confrontarci solo nello specchio di camera nostra, nel camerino, tutt’al più
dal medico. Eppure, di corpi di donne ne vediamo ogni giorno, a migliaia,
di ogni forma e dimensione: sono quelli che incrociamo per strada e quelli
delle influencer di Instagram, sono quelli dei film e quelli delle pubblicità dello
yogurt.
I corpi sono sette miliardi, come le persone sulla Terra, e i corpi delle
donne sono circa la metà, tre miliardi e mezzo. Ciascuno di essi è sottoposto
a tensioni e stimoli diversi. A volte sono stimoli positivi, passi in avanti, salti
di gioia. Altre volte sono limitazioni alla nostra libertà e individualità,
gabbie in cui veniamo messe o muri che ci erigiamo intorno da sole. I nostri
corpi sono vivi nel mondo e il mondo li condiziona e li modifica: portando
in giro i nostri corpi, accettiamo di interagire con esso. Li rendiamo, in un
certo senso, pubblici.
Negli anni Sessanta un vecchio slogan femminista diceva che il “personale
è politico”. Questa idea viene da un pamphlet scritto nel 1969 da Carol
Hanisch, quindi da quello che convenzionalmente viene chiamato
“femminismo storico” o “femminismo della seconda ondata”. Come una
marea, la storia dei femminismi si suddivide convenzionalmente in varie
ondate: la prima ondata coincide con la fine del XIX secolo e l’inizio del XX e
con le lotte, soprattutto nel mondo anglosassone ma anche in Italia, per il
diritto al voto. Con il suffragio avvenne anche un generale miglioramento
delle condizioni sociali delle donne, che poterono accedere, in vari Paesi
occidentali, a un’istruzione, a salari più adeguati e alle libere professioni. La
seconda ondata corrisponde invece alla grande stagione del femminismo
che va dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. In quest’epoca vennero a galla
tutti quegli aspetti della vita personale di una donna di grande impatto sul
piano sociale e politico, come la sessualità, la gravidanza e la maternità.
Oggi questa suddivisione cronologica è stata messa in discussione per due
validissime ragioni.
La prima è che categorizzare in maniera così netta la storia delle donne
significa separarla dalla cosiddetta “storia con la S maiuscola”, come se le
donne non vi fossero coinvolte.
La seconda è che la teoria delle ondate dà l’idea che il movimento delle
donne non sia organico, ma frammentato. In realtà le questioni che hanno
caratterizzato ciascuna ondata si riverberano e si intersecano anche in
quelle seguenti. E infatti sono qui a parlarvi degli anni Settanta. In ogni
caso, per ragioni di chiarezza, anche io mi adeguo a usare questa divisione.
Carol Hanisch coniò il suo slogan in risposta alla chiusura che i vari
movimenti libertari, come quello per i diritti civili e quello pacifista,
mostravano nei confronti delle donne, i cui problemi e rivendicazioni
venivano considerati di minore importanza rispetto alla causa perché
“personali”. Scriveva Hanisch:
Come donna di un movimento, sono stata spinta a essere forte, altruista, aperta verso l’altro,
pronta al sacrificio, e in generale in controllo della mia vita. Ammettere i problemi nella mia vita
è ritenuto debole. Quindi io voglio essere una donna forte, in termini di movimento, e non
ammettere che ho dei problemi reali a cui non riesco a trovare una soluzione personale […]. È a
questo punto un’azione politica dirlo così com’è, dire ciò che penso realmente della mia vita
anziché ciò che mi hanno sempre detto di dire.
2
Le sue parole risuonarono per tutta la stagione femminista degli anni
Settanta, spingendo le donne del neonato Women’s Liberation Movement a
organizzarsi in spazi autogestiti, all’interno dei quali potevano parlare
liberamente di tutto ciò che le riguardava da vicino, partendo da ciò che
meglio conoscevano: la propria esperienza. Questi gruppi autorganizzati e
privi di gerarchia o statuto, detti gruppi di “autocoscienza”, erano
frequentati da persone di tutte le età, dalle liceali alle nonne. Si parlava
soprattutto di sesso, di mestruazioni, di parto, di salute mentale, di fantasie
sessuali, di contraccezione e di aborto. Fino a quel momento le donne
raramente avevano spazi per poter parlare fra loro.
L’autocoscienza fu, innanzitutto, un tentativo di costruire una coscienza
collettiva che per troppo tempo era stata negata: non solo di sé, al di là dei
ruoli prestabiliti di moglie e madre, ma anche di classe: le donne si
scoprirono e si definirono un “soggetto politico”. L’idea che il personale
fosse politico generò nuove forme di attivismo che andavano dal rifiuto di
lavare i piatti alle manifestazioni in piazza per l’accesso alla contraccezione.
Per la prima volta le donne divennero consapevoli del proprio genere come
segmento sociale all’interno di un’istituzione ben definita e definibile: il
patriarcato, l’oppressore che riuscirono a individuare proprio percependosi
oppresse. Questo le dotò di tutti gli strumenti per organizzarsi politicamente
come un corpo di azione e rivendicazione. Tale progresso fu possibile grazie
a un passaggio obbligato: rendere visibile la sfera privata.
Ritrovarsi in circolo, scambiarsi informazioni sulle proprie esperienze
significava rendere pubblico – dapprima in un safe space e poi di fronte al
mondo intero – quello che era sempre stato taciuto. In piedi, sdraiate sui
tappetini da yoga, a casa di qualcuno, nella palestra del liceo o alla sede del
partito. A gambe all’aria e senza reggiseno o vestite di tutto punto, le donne
si rendevano conto per la prima volta di avere un corpo, il proprio, che era
uguale e diverso da quello della sorella, dell’amica, della vicina di casa o
della sconosciuta. Si tastavano seni, si osservavano peli, si misuravano
fianchi e si studiava. Si appuntava ogni cosa, con l’intenzione di creare una
cultura che fosse accessibile a tutte le donne, anche quelle estranee al
gruppo. Da alcune di queste esperienze collettive nacquero contributi
importantissimi per la liberazione e la formazione della donna, come il
leggendario volume Our Bodies, Ourselves, scritto dal Boston Women’s Health
Book Collective.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :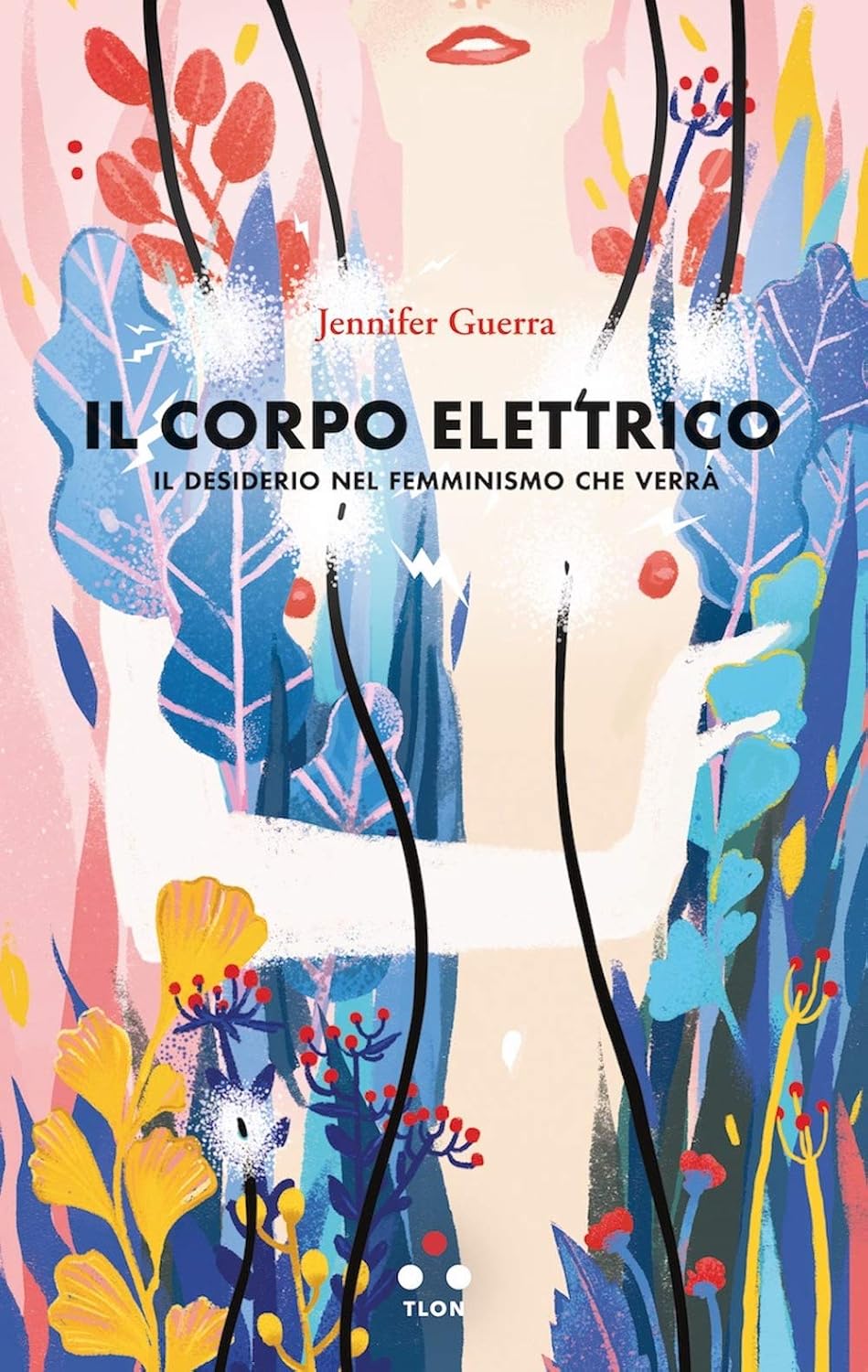






Commento all'articolo