Storia moderna e contemporanea. Dalla peste nera alla Guerra dei trent’Anni – Adriano Prosperi

SINTESI DEL LIBRO:
Una lunga fase ascendente, poi una brusca caduta: questo il disegno
sommario della storia europea tra il secolo XI e il xiv. All’inizio, dopo la
lunga stagnazione seguita alla fine dell’Impero romano (una stagnazione
fatta di guerre, epidemie, migrazioni di popoli, devastazioni, scontri di
lingue, religioni, culture), c’era stata un’improvvisa, folgorante ascesa
economica, artistica, demografica: le città che coprivano la superficie
dell’Europa occidentale si erano popolate, erano cresciute di dimensioni, i
loro cittadini si erano arricchiti rapidamente, mandando merci e navi in
tutte le direzioni: botteghe artigiane, banche, fondachi, compagnie di
artigiani (le Arti) erano state il loro segno. Ma anche la nobiltà feudale
aveva sentito il vento in poppa: conti e marchesi e cavalieri, posti a difesa ai
confini dell’Impero carolingio e del ristretto mondo cristiano occidentale,
avevano passato il Mediterraneo alla conquista di Gerusalemme, oppure
avevano cercato fortuna e gloria nelle guerre della reconquista iberica contro
i musulmani – anche se spesso si erano limitati a depredare i banchi ebraici
in terra cristiana: atti di predoni e briganti, verniciati di alti ideali e
disciplinati a stento dalle istituzioni ecclesiastiche. La grande impresa del
viaggio di Marco Polo in Cina – grande anche per la memoria scritta che ce
ne è stata lasciata – è un modello per capire di cosa fossero capaci i
mercanti delle città italiane, quale fosse la loro intraprendenza, la loro
curiosità, la loro cultura. E, se la società europea aveva espresso capacità
individuali cosí straordinarie, si deve aggiungere che anche le istituzioni del
potere politico avevano marciato rapidamente verso un nuovo assetto del
continente. Aggregazioni statali antiche, come la Francia, e nuove grandi
formazioni (Inghilterra, Castiglia) e piccole (i comuni italiani) avevano fatto
emergere un disegno politico vario e complicato nel tessuto del continente e
nel quadro politico tradizionale dell’impero, mentre processi di
riaggregazione altrettanto complicati si erano avuti nella Chiesa cristiana: il
mondo ecclesiastico ufficiale, investito dalle critiche e dalle tensioni di una
società nuova, dall’intensa circolazione urbana di idee e di valori, non piú
disposta ad accettare i valori del mondo ecclesiastico, aveva inglobato
alcune delle forze nuove (i domenicani e i francescani) e ne aveva
combattuto altre (i catari, i valdesi).
Quel che è certo, è che un vento di crescita rapida aveva investito
l’Europa occidentale, non piú chiusa nell’assedio tra un Mediterraneo
musulmano e un confuso ribollire di popoli migratori dall’Asia. Un indice
indiscutibile di quella crescita è ancora evidente nel disegno delle cinte
murarie delle città italiane. A Firenze, a Bologna, a Genova, a Milano, a Pisa,
la superficie dell’antico centro romano si allarga rapidamente tra il secolo XI
e il XIII: a Firenze, si passò da una superficie di 25 ettari a un’altra di 75. A
Pisa, a Bologna, in altre città ancora, all’inizio del Trecento una nuova cinta
muraria viene costruita per definire e difendere i nuovi confini dell’abitato;
all’interno della cinta, si lasciano gli spazi verdi necessari per gli orti che
servono alla sussistenza cittadina in caso di assedio, ma anche vasti terreni
edificabili che possano consentire nuovi edifici capaci di bastare per qualche
decennio alla crescita prevista della popolazione. Come sempre, il futuro è
immaginato sulla base dell’esperienza del passato recente. E la previsione fu
smentita da un futuro non solo imprevedibile (come sempre) ma soprattutto
di segno radicalmente opposto a quello immaginato. Le città furono come
gelate nella loro crescita e non raggiunsero mai, per secoli e secoli, quei
confini. Ancora nel nostro secolo, in molti casi i limiti di quelle mura
disegnate allora non erano ancora stati raggiunti; edifici giganteschi,
progettati e avviati nel pieno del boom – il duomo di Siena, di Orvieto, di
Firenze – raggiunsero a stento il completamento. Che cosa era successo?
1. La «peste nera».
a) Uomini e topi.
Tra il 1347 e il 1351 un flagello biblico si abbatté sull’Europa: la peste
nera. La gente si ammalava e moriva in quantità incredibili, in tempi
brevissimi. La minaccia della scomparsa della specie umana, sotto l’attacco
di un nemico invisibile e spaventoso, fu allora non un timore lontano, non
una possibilità astratta, ma una prospettiva concreta. Nel breve spazio di
qualche ora, chi era vivo non c’era piú; bastavano pochi giorni perché i vivi
che affollavano strade e mercati si affollassero in cataste di morti che
nessuno riusciva piú a seppellire. E la cosa è tanto piú terribile se si pensa
che la falce sterminatrice era mossa da una forza nascosta e sconosciuta. La
minaccia della morte atomica nel secolo XX ha riportato all’orizzonte
dell’umanità il pericolo della fine della specie, ma sotto l’aspetto di un
rischio scatenato da scienza e tecnologia umane. Nel Trecento, le cose erano
del tutto diverse. L’aggressione veniva da una natura ostile, misteriosa,
dietro la quale si vedeva solo la mano di Dio.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
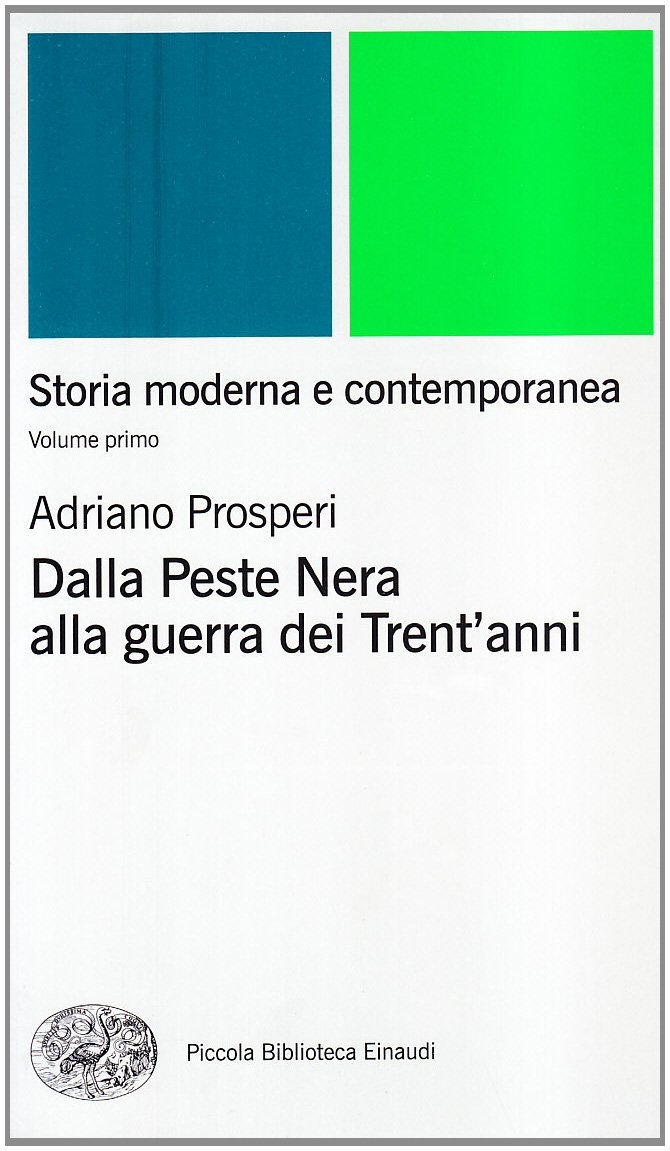






Commento all'articolo