Storia moderna e contemporanea. IV. Il Novecento – Paolo Viola

SINTESI DEL LIBRO:
Per quattro anni e tre mesi, dall’estate 1914 all’autunno 1918 i paesi
europei, gli Stati Uniti e il Giappone si fecero la guerra piú devastante che
l’umanità avesse conosciuto fino ad allora. Vi si lanciarono con scarsa
consapevolezza del prezzo che sarebbe stato pagato in vite umane, in
distruzioni, in mancato sviluppo.
La causa occasionale del conflitto fu una crisi fra l’Austria-Ungheria e la
Serbia, ma le ragioni profonde stavano nelle tensioni nazionali irrisolte, nei
conflitti fra i diversi imperialismi che avevano completato la conquista del
pianeta e che entravano in collisione fra di loro, infine nell’incapacità dei
sistemi politici, sia liberali che monarchici autoritari, di comporre i conflitti
sociali.
Il risultato piú importante fu l’inizio della fine del ruolo dirigente
dell’Europa nel mondo, a vantaggio degli Stati Uniti, del Giappone e di una
Russia proiettata verso l’Asia. Il secondo risultato fu la fine del modello
politico delle monarchie per diritto divino, autoritarie e multinazionali. Il
terzo risultato fu l’avvento di due nuovi modelli politici, entrambi nati dal
fallimento del liberalismo: il comunismo e il fascismo, entrambi frutti di
un’esasperazione dei conflitti sociali.
La Grande Guerra può dunque essere interpretata come un suicidio
dell’Europa, delle sue classi dirigenti e dei suoi modelli politici. E anche
come l’ingresso nella fase piú drammatica di tutta la storia umana: una fase
che avrebbe visto la creazione di regimi dittatoriali violenti e disumani, lo
scoppio di un secondo conflitto ancora molto piú tragico del primo, uno
sviluppo inaudito dei sistemi di distruzione.
In una catena di conseguenze messe in moto dalla guerra, per decenni
l’umanità sarebbe stata condotta sull’orlo del baratro, fino alla minaccia
della distruzione totale. E sarebbe anche stata spinta verso
un’internazionalizzazione dei problemi e uno sviluppo tecnologico tali da
cambiare completamente le caratteristiche generali della convivenza fra gli
uomini. La prima Guerra mondiale ha dunque il significato forse del piú
grande spartiacque della storia del mondo, dell’avvenimento dopo il quale
nulla ha potuto continuare ad essere come prima.
1. Lo scoppio del conflitto.
Il 28 giugno 1914 a Sarajevo, capoluogo della Bosnia-Erzegovina da poco
annessa all’Impero austro-ungarico, lo studente serbo-bosniaco Gavrilo
Princip riuscí ad avvicinarsi alla carrozza imperiale sulla quale si trovava
l’arciduca Francesco Ferdinando, nipote dell’imperatore e principe
ereditario in visita ufficiale. Il giovane terrorista gli sparò e lo uccise insieme
alla moglie.
L’arciduca assassinato era la massima personalità politica e militare
dell’Impero. Aveva delle idee particolarmente progressiste e coraggiose,
poiché intendeva trasformare la «duplice monarchia» asburgica in uno
Stato compiutamente federale. In questo quadro agli slavi sarebbe stato
riconosciuto un ruolo di comprimari, e il dominio della nobiltà magiara
sarebbe stato spezzato coll’introduzione in Ungheria del suffragio universale
maschile. Con simili importanti riforme la natura multinazionale
dell’Impero asburgico sarebbe stata forse salvata. Di conseguenza sarebbe
andato in fumo il sogno serbo di staccare tutti i territori balcanici dalla
monarchia asburgica e dare vita alla Iugoslavia: uno stato indipendente di
tutti gli slavi del Sud.
Gavrilo Princip non aveva fatto nulla di diverso dai vari rivoluzionari
anarchici, o da tanti altri patrioti nazionalisti, o anche «irredentisti» della
sua epoca. Nel 1882 ad esempio il giovane italiano Guglielmo Oberdan,
membro della massoneria, disertore dall’esercito asburgico, era scappato
dall’Impero a Roma, e lí aveva progettato un attentato a Francesco
Giuseppe, e solo per un caso la polizia austriaca era riuscita ad arrestarlo
prima del fatto. La giustizia imperiale lo aveva condannato a morte: e cosí a
Trieste c’è un monumento a Oberdan. Anche a Belgrado c’è il monumento a
Gavrilo Princip.
La differenza era nella situazione internazionale. Allora non si poteva, o
non conveniva, accusare l’Italia di aver armato la mano di Oberdan. Tant’è
che l’anno stesso dell’esecuzione del giovane irredentista l’Italia firmava la
Triplice Alleanza e diventava ufficialmente alleata dell’Austria. Invece il
terrorista serbo apparteneva ad una società segreta, la «Mano nera»,
collegata ad un partito politico nazionalista serbo, la «Difesa nazionale»,
dietro al quale c’erano le gerarchie militari serbe, certamente i servizi
segreti di quel paese, e forse quelli russi. Il governo serbo non era
direttamente responsabile dell’attentato, ma si poteva non senza ragione
sostenere che un suo coinvolgimento c’era.
Soprattutto, a differenza di trent’anni prima, quando si era appena svolto
il Congresso di Berlino del 1878, e si credeva nel «concerto europeo», le
grandi potenze si stavano ormai preparando alla guerra; e non solo gli stati,
ma anche la gente comune, gli intellettuali, i popoli. Il Kaiser tedesco ad
esempio rispecchiava il pensiero di molti, forse dei piú, quando disprezzava
«la tendenza da eunuco a sopravvalutare l’importanza della pace
mondiale»! All’inverso, nella giustizia i tempi erano cambiati in senso piú
mite dall’epoca di Oberdan: le sentenze erano state raddolcite, e il terrorista
serbo fu condannato solo a vent’anni di reclusione (di carcere duro per la
verità, tant’è che morí in prigione). Il suo gesto comunque scatenò la prima
Guerra mondiale, ossia l’avvenimento piú luttuoso che la storia avesse mai
conosciuto fino ad allora.
L’Austria avviò un’inchiesta che aveva come oggetto i rapporti
internazionali che avevano reso possibile l’assassinio di Sarajevo. In poche
settimane arrivò a porre un ultimatum alla Serbia, a cui quel paese rispose
positivamente su tutto, salvo che nel permettere la partecipazione della
polizia austriaca all’inchiesta sul proprio territorio nazionale. La Serbia era
un piccolo paese, ma poteva contare sulla protezione russa. La Russia per
parte sua era legata da un’alleanza militare con la Francia, che a sua volta
era alleata dell’Inghilterra. La «Triplice Intesa» fra questi tre paesi non era
stata ancora formalizzata (lo sarebbe stata solo a guerra già scoppiata) ma
esisteva di fatto fin dal 1907, per fronteggiare gli Imperi centrali. Uno
scontro fra due grandi potenze dei campi avversi avrebbe dunque coinvolto
le altre, e questo era ben chiaro alle diplomazie di tutti i paesi.
Il 21 luglio, due giorni prima dell’ultimatum, il governo francese
ricordava all’imperatore austriaco che «la Serbia aveva degli amici e perciò
si poteva arrivare ad uno stato di tensione pericoloso per la pace». Dal canto
suo la Russia diede all’ambasciatore tedesco un avvertimento che non
poteva essere piú chiaro: «se l’Austria occuperà la Serbia, noi le muoveremo
guerraSCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
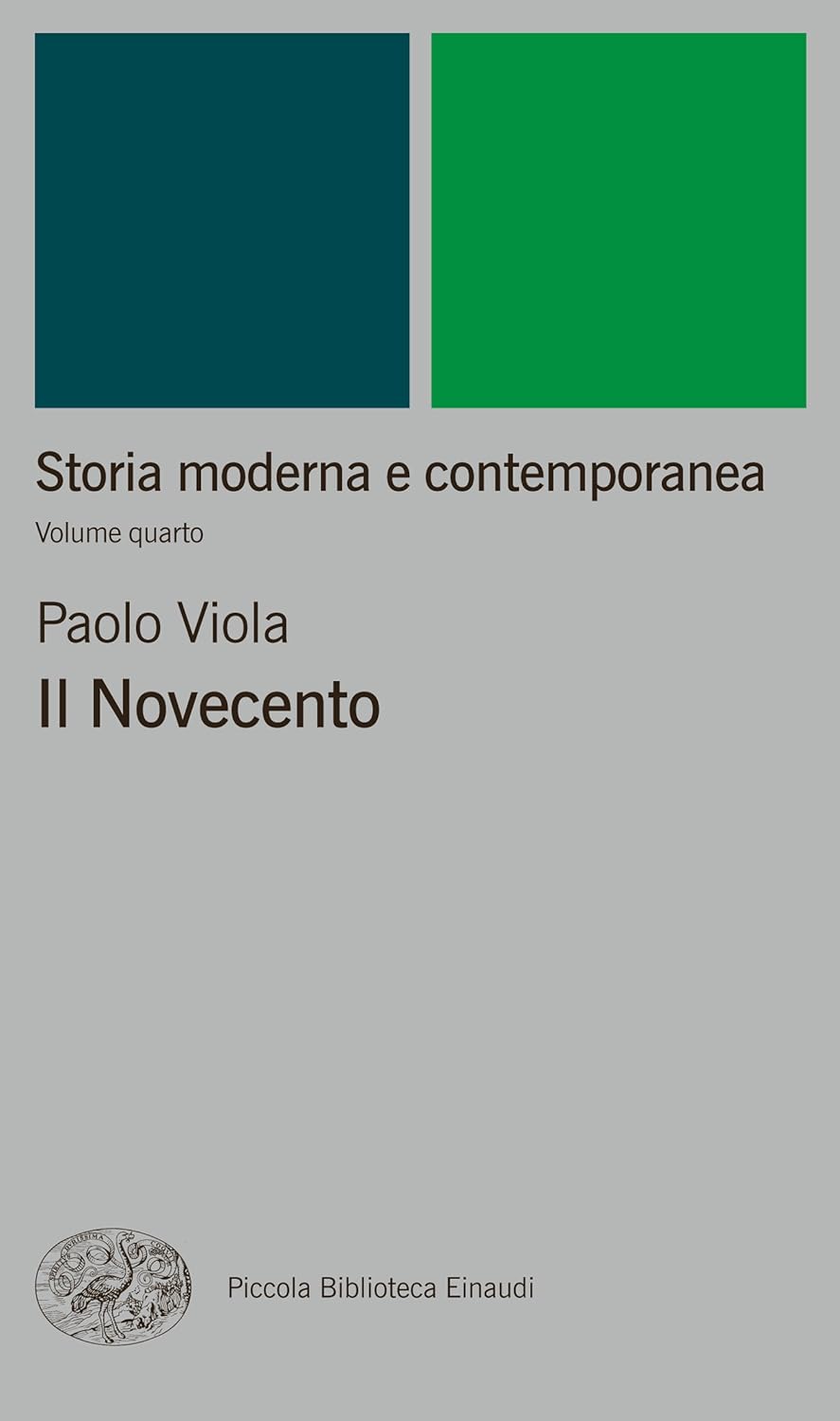






Commento all'articolo