Gli Undici – Pierre Michon
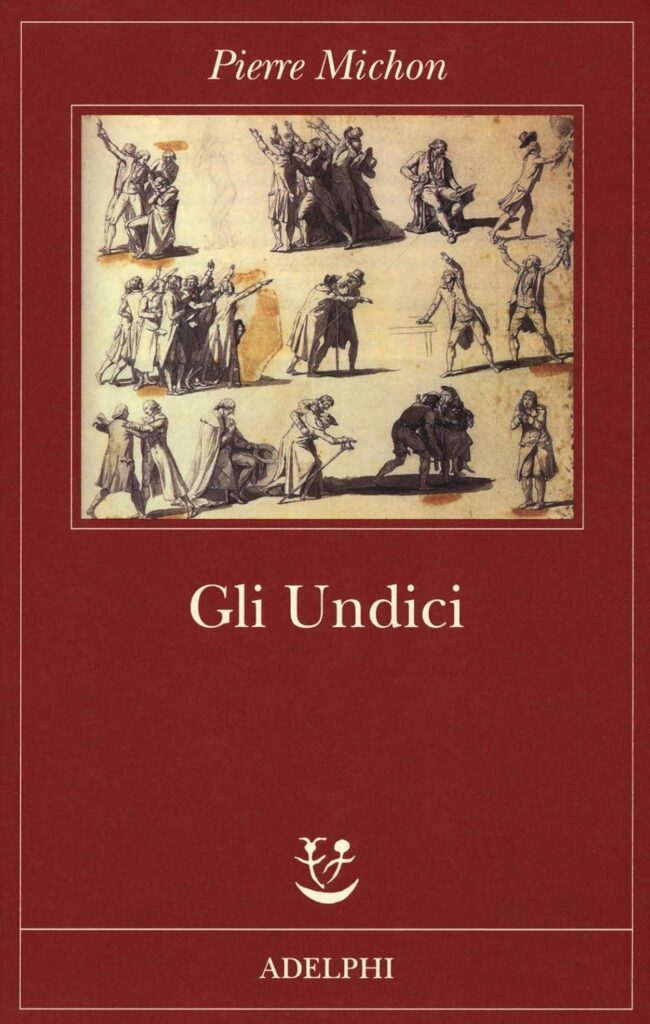
SINTESI DEL LIBRO:
Era scialbo, di media statura, ma catturava l’attenzione
con i suoi silenzi febbrili, la sua gaiezza cupa, i suoi modi ora
arroganti ora obliqui - torvi, ha detto qualcuno. Così almeno
si presentava in tarda età. Niente di tutto ciò appare nel
ritratto che sulle volte di Würzburg, e precisamente al di
sopra della parete sud del Kaisersaal, nel corteo nuziale di
Federico Barbarossa, Tiepolo ci ha lasciato di lui, quando il
modello aveva vent’anni: è proprio lui, a quel che si dice, e lo
si può vedere, alloggiato lassù, in mezzo a cento principi,
cento conestabili e mazzieri, e altrettanti schiavi, mercanti e
portatori, e animali, e putti, e dèi, e mercanzie, e nuvole,
insieme alle quattro stagioni e ai quattro continenti, e a due
pittori di indiscutibile valore, coloro che hanno così inteso
offrire del mondo una recensione esaustiva, e che del mondo
pure sono parte, Giambattista Tiepolo in persona e
Giandomenico Tiepolo suo figlio. Dunque c’è anche lui, lassù,
o almeno la tradizione vuole che ci sia, e che sia il paggio
che regge la corona del Sacro Romano Impero sopra un
cuscino adorno di ghiande dorate; se ne intravede la mano
sotto il cuscino, il volto leggermente inclinato guarda per
terra, l’intero busto si flette come per assecondare il peso
della corona: si piega sotto l’Impero, con tenerezza,
soavemente.
È biondo.
Questa identificazione è quanto mai seducente, anche se
forse è soltanto una fantasia: questo paggio è un tipo, non un
ritratto, Tiepolo lo ha ricavato dal Veronese, non dalle
fattezze di uno dei suoi garzoni; è un paggio, è il paggio, non
è nessuno. Una tradizione quasi altrettanto dubbia lo fa
ricomparire quarant’anni più tardi, di nuovo alloggiato in
alto, su uno dei finestroni visitati dal vento, fra i testimoni
del Giuramento della Pallacorda nel disegno preparatorio
che ne fece David: è quella figura col cappello, senza età,
obliqua, che addita a dei bambini lo slancio impetuoso di
cinquecentosessanta braccia tese. Dinanzi a quest’uomo
insieme febbrile e tranquillo, il cui volto potrebbe davvero
essere il suo, io però sono tra coloro che fanno il nome di
Marat. È di sicuro Marat - perché quella vignetta
rousseauiana, quei bambini, quella gestualità da precettore,
no, tutto ciò non è il nostro uomo: sebbene ne abbia dipinti,
in quanto oggetti di questo mondo, bambini non ne ebbe, ed
è lecito pensare che non li notasse neppure, a meno che non
fossero in qualche modo anche loro suoi rivali. Tralascio a
malincuore il disegno a mina di piombo di Georges Gabriel,
che a lungo fu ritenuto il suo ritratto, in cui apparirebbe di
nuovo con un cappello, tutto faccia, gli occhi fuori dalle
orbite, spaurito, irritato, come fosse stato colto con le mani
nel sacco, e che mi fa pensare a un celebre autoritratto
inciso da Rembrandt; oggi sappiamo che è in realtà o il
calzolaio Simon, aguzzino e giullare del piccolo Luigi XVII
nella Torre del Tempio, o Léonard Bourdon, sfrenato
sanculotto dell’anno II che cambiò casacca in termidoro.
L’incontestabile, bel ritratto che ne fece Vincent dopo il
1760, dunque all’epoca della maturità di lui, e che
appartenne a Filippo Egalité, già Orléans, è andato perduto
durante il Terrore. Di suoi autoritratti non si ha notizia. Fra
il paggio dell’Impero e l’equivoco vecchio esaltato di cui si è
detto non possediamo nulla che gli assomigli.
Il suo ritratto in tarda età, attribuito a Vivant Denon, è un
falso.
Tutto qui, per il suo aspetto - per la posterità del suo
aspetto. È poco, eppure è sufficiente: un giovane di pura luce
che la vecchiaia distrugge e avvilisce, un tenero viso così
alterato dal tempo da poter essere confuso con quello di
Simon, uno degli esseri più vili di un’epoca prodiga di
mostri. Ci dice molto sul suo conto, questo anomalo
invecchiamento. E per meglio apprezzare questa farsa del
Tempo, o per dimenticarla un istante, preferiamo
riconoscerlo nel biondino di Würzburg. Preferiamo elevarlo a
questa forma, nei nostri sogni. Era bello e insolente, lo
amavano, lo detestavano, era uno di quei giovani divorati
dall’ambizione che non hanno niente da perdere, che tutto
osano, innamorati dell’avvenire a tal punto che il proprio
avvenire sembrano additarlo a chiunque li frequenti: e gli
uomini senza avvenire li odiano, gli altri no. Mille romanzi
sono stati scritti su di lui, sugli uomini che strabiliò, sul
piacere che da lui presero le donne e sul piacere che alle
donne lui rese; conosciamo la storiella dello scambio di
bastonate con il principe-vescovo a causa di una ragazza,
l’inseguimento sullo scalone, la risata di Tiepolo di lassù; ci
sembra quasi di sentirla, quella risata soprannaturale, da
mago; ci ritroviamo a pensare che sono per lui, per il
biondino, tutte quelle donne facili e altere adagiate sulle
volte: tanto che, guardando l’affresco in cui compare il
paggio, dove la leggenda lo fa comparire, abbiamo talora
l’impressione o forse il desiderio che la bella Beatrice di
Borgogna inginocchiata a dieci passi davanti a lui accanto al
bel Barbarossa suo signore sotto la figura eretta, il
pastorale, la mitra, il guanto del principe-vescovo che unisce
i due sposi, che Beatrice dunque sia sul punto di girarsi
verso di lui, sul punto di alzarsi per spostare verso di lui la
sua massa sontuosa di carne bionda e di broccato azzurro e,
facendo cadere la corona, abbracciarlo.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :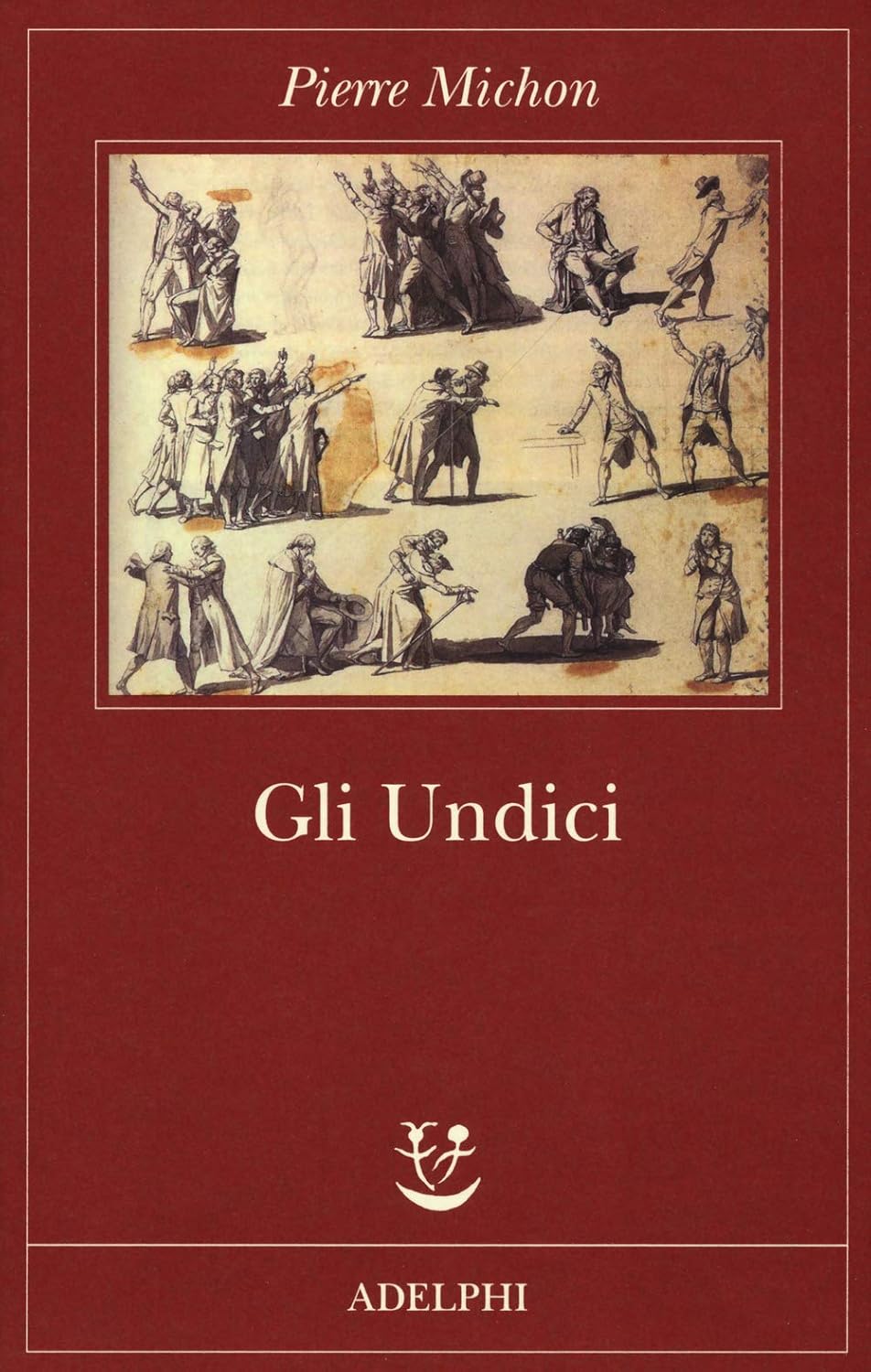





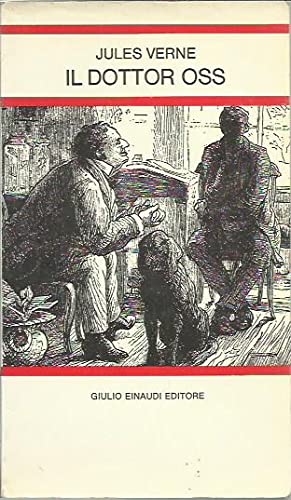
Commento all'articolo