Gli ultimi duchi di Milano- Il crepuscolo degli Sforza e l’inizio delle dominazioni straniere -Carlo Maria Lomartire
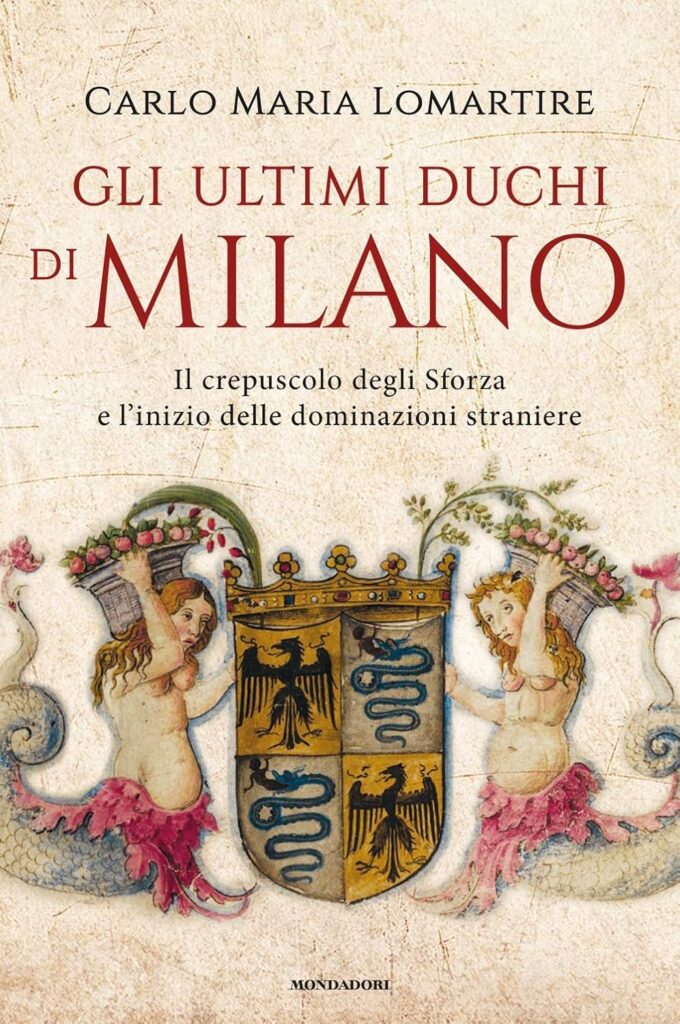
SINTESI DEL LIBRO:
«Francesco, nostra cugina l’imperatrice ci vuole nei suoi
appartamenti. Vuole vederci con urgenza, pare che debba farci
importanti comunicazioni.»
Con l’abituale aria sorniona e un po’ annoiata, Ercole
Massimiliano, dopo averlo raggiunto nel vasto parco che si stendeva
dietro la Corte imperiale di Innsbruck, dove era andato a
passeggiare come tu e le ma ine, informò della convocazione il
fratello minore che, serio, riflessivo e un po’ malinconico (com’era
suo solito), senza muovere un muscolo chinò appena la testa, in
segno di assenso.
I due giovanissimi Sforza avevano cara eri assai diversi ma erano
molto legati. Li tenevano uniti le loro vite, iniziate in patria e
proseguite in esilio, i viaggi precipitosi, i trasferimenti, la perdita
della famiglia d’origine, i cambiamenti di ambiente, di abitudini e di
parlate, tu o questo erano stati costre i ad affrontare e a vivere
sempre insieme. Fra di loro si rivolgevano in italiano-lombardo, ma
ormai con un forte accento tedesco-tirolese e usando parecchi
termini di quella lingua.
A Innsbruck l’aria era ancora fresca in quella limpida ma ina di
f
ine giugno del 1507, quando Bianca Maria Sforza, moglie di
Massimiliano I d’Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero e
re dei Romani, riceve e, dopo averli convocati «urgentemente», i
cugini Ercole Massimiliano e Francesco, figli dello zio Ludovico
Maria Sforza, per tu i il Moro, del quale si sapeva solo che da se e
anni, dopo la sconfi a nella ba aglia di Novara del 1500, era
prigioniero del re di Francia Luigi XII.
I due fratelli Sforza furono accompagnati da un gentiluomo di
camera nello studio dell’imperatrice, al primo piano della Corte
p
p
p
imperiale. Il Neuer Hof era un castello fa o costruire il secolo prima,
intorno al 1420, alla periferia orientale di Innsbruck, da Federico IV
d’Austria per ospitare i conti tirolesi, diventando poi residenza
dell’arciduca Sigismondo, passato alla storia come «il Danaroso» non
solo per il suo tenore di vita dispendioso e per l’essere stato un
generoso mecenate, ma anche perché, grazie a una serie di
provvedimenti sempre più ambiziosi e spudorati in campo
f
inanziario, aveva rivoluzionato la politica valutaria del suo tempo,
arrivando a far coniare, nella zecca della ci adina di Hall, monete
d’argento di insuperabile purezza. L’imperatore Massimiliano I non
amava quel castello anche se, pur essendo lui niente affa o
«danaroso», aveva iniziato a farlo ristru urare, introducendo, come
gli aveva chiesto l’amatissima prima moglie Maria di Borgogna,
morta nel 1482 per una caduta da cavallo, «qualche elemento di
eleganza italiana».
Quando era ancora duca di Milano, il 2 se embre 1499 il Moro
aveva affidato i suoi due figli, sei anni Ercole Massimiliano e qua ro
Francesco, a suo fratello il cardinale Ascanio e alla nipote Camilla
perché li me essero al sicuro. Dovevano portarli in Tirolo per
lasciarli alla tutela della nipote imperatrice durante le fasi più
drammatiche e finali del confli o con il re di Francia Luigi XII di
Valois-Orléans, che con enfasi esagerata amava farsi chiamare
«Padre del popolo». Re Luigi era calato in Italia con un forte esercito
per la conquista – sempre ambita dai sovrani francesi con il pretesto
di remoti titoli ereditari – dell’opulento, splendido, popoloso e
ambitissimo Ducato di Milano.
I piccoli Sforza, accompagnati anche dal loro prece ore Giacomo
Colla, giunsero prima a Bressanone poi a Innsbruck con una buona
dote, 60.000 ducati, dodici carri di corredo e beni personali, compresi
numerosi gioielli e preziosi. Tu o fu incamerato dallo squa rinato
imperatore
«per
assicurare
loro»
disse,
«un
dignitoso
mantenimento». Che a dire il vero si rivelò assai austero e spartano.
Prima della sua sconfi a definitiva a Novara, il Moro volle
me ere al sicuro a Innsbruck anche i figli illegi imi. Erano quelli
avuti dall’amante predile a Cecilia Gallerani, la splendida Dama con
l’Ermellino ritra a da Leonardo da Vinci: Leone, Maddalena, Bianca
Francesca e Cesare, e infine anche Giovanni Paolo, avuto invece da
Lucrezia Crivelli, che della Gallerani prese il posto, anche se
inadeguatamente. Questi figli «naturali», o bastardi, come erano
definiti allora, furono affidati a nobili milanesi e lombardi esiliati
anch’essi in Tirolo in seguito all’occupazione francese del Ducato.
Se, da una parte, il primogenito Ercole Massimiliano aveva
sempre ricordato con orgogliosa fermezza, in quanto primogenito, di
essere l’erede del Ducato, dall’altra Francesco o enne in ogni caso da
Ludovico Maria riconoscimenti, gratificazioni e titoli importanti.
Anzi, quando aveva solo poco più di due anni, il Moro gli donò il
Ducato di Bari, il Principato di Rossano e il Contado di Burrello,
ricchi feudi nel Regno di Napoli ereditati dal padre Francesco Sforza.
Il valoroso condo iero li aveva acquisiti durante le sue lunghe,
avventurose e complesse esperienze militari e politiche da capitano
di ventura nel Sud d’Italia, prima ancora della conquista di Milano.
Da poco quei titoli feudali erano stati confermati al Moro dal re di
Napoli Federico d’Aragona ma, a dire il vero, per il piccolo
Francesco avevano un valore più nominale che reale, considerata
l’enorme distanza geografica di quei territori da Milano e dal Tirolo
e, sopra u o, la condizione in cui gli Sforza si erano venuti a trovare
al volgere del nuovo secolo.
Ludovico Maria nutriva un affe o particolare per il suo
secondogenito, e non solo per il nome che portava. Fin dai suoi primi
anni di vita, infa i, quel bambino si era mostrato intelligente,
perspicace ma anche fin troppo riflessivo ed equilibrato per la sua
età. Così, nel 1499, in procinto di vederli partire per il Tirolo il Moro
li aveva salutati con affe o e tristezza: «Ricorda Ercole Massimiliano
che dopo di me sarai duca di Milano: tornerai per riprendere il posto
che ti spe a. Preparati per essere degno di questo tuo destino».
Parlava come se fosse sicuro che un giorno, alla sua morte, disteso
nel le o del suo castello, avrebbe tramandato il Ducato al figlio. Mai
avrebbe potuto immaginare il destino avverso, ingiusto e crudele che
invece lo aspe ava.
«E tu, piccolo duca di Bari, principe di Rossano e conte di
Burrello» disse poi rivolgendosi a Francesco, «non sei da meno. Già
ora dimostri un’accortezza quasi da uomo maturo, a te perciò spe a
q
p
p
il compito di stare sempre al fianco di tuo fratello, consigliarlo e
assisterlo in ogni occasione.»
Se Ercole Massimiliano accolse con narcisistico compiacimento la
conferma della sua investitura, Francesco reagì con meraviglia e
curiosità alle esortazioni e ai riconoscimenti del padre. Ma una cosa
Francesco non poté mai trascurare, neppure da fanciullo: a portare il
nome glorioso del primo Sforza, del capostipite della dinastia ducale
era lui; a lui il padre aveva affidato quell’oneroso ma anche
inorgogliente impegno di continuità. Giacché il Moro aveva già
capito quanto fossero differenti e lontani i cara eri, le doti, le
a itudini e infine l’avvenire dei suoi due figli.
Era stato quasi costre o a dare al secondogenito e non al primo,
come imponeva la tradizione, il nome del padre. All’altro aveva
dovuto affibbiare quello di Ercole, in riferimento a Ercole d’Este, suo
suocero e padre di sua moglie Beatrice. Aggiungendogli poi, come
primo nome, quello di Massimiliano, l’imperatore con il quale stava
tra ando a carissimo prezzo il riconoscimento del titolo ducale,
l’investitura formale tanto desiderata già da suo padre Francesco fin
dall’arrivo a Milano.
Da parte sua, l’imperatrice curava con zelo e affe o quasi materno
gli interessi e l’educazione dei due giovine i, affiancata, oltre che dal
Colla, dall’abile e colto Ma eo Schiner, lo svizzero vescovo
dell’importante diocesi di Sion, fedele amico del Moro. Un’amicizia
nata dalla frequentazione, dalla stima e dalla simpatia reciproca ma
anche figlia della riconoscenza, perché grazie a Ludovico, Schiner
aveva o enuto nel 1499 quel prestigioso, ricco e strategico vescovato.
Per di più, il presule di Sion era ostile ai Francesi, che a quella sua
nomina si erano opposti volendo riservarla a un loro prote o.
Per effe o della sua coerente lealtà alla dinastia sforzesca, Schiner
trascorreva lunghi periodi alla Corte imperiale di Innsbruck per
consigliare e assistere Bianca Maria e collaborare all’educazione dei
suoi cugini.
Nonostante questi impegni, il vescovo – uomo di poche parole e
dall’aspe o severo, altissimo, magro e ossuto, con lineamenti
grifagni e grosso naso adunco – curava anche la sua diocesi, ne
visitava tu e le parrocchie e predicava nelle piazze e nelle chiese.
p
p
p
Non solo. Era politicamente a ivo, aveva uno spiccato interesse per
le faccende militari e conosceva bene la stru ura e le disponibilità
delle tante compagnie di ventura svizzere. Una competenza che gli
tornò utile nel gestire – come vedremo – le tormentate vicende del
Ducato di Milano.
Schiner sapeva bene quanto il Moro tenesse all’istruzione del
primogenito
Ercole
Massimiliano.
Voleva
che
ricevesse
un’educazione adeguata all’erede di un Ducato, che considerava
comunque destinato a un glorioso avvenire e al quale il vescovo di
Sion, da parte sua, era certo che gli Sforza avrebbero fa o presto
ritorno.
Per arricchire la cultura del giovane, per esempio, il Moro aveva
fa o eseguire e stampare a Milano preziosi libri di preghiere e di
studio, tra cui due splendidi volumi, il Liber Jesus e la Grammatica
Latina de a «di Donato» perché ispirata all’opera di Aelius Donatus,
maestro di san Girolamo, i cui pregiati lavori erano considerati utili
strumenti dida ici, consultati già nei secoli precedenti. Quei libri
rimasero purtroppo nel castello di Porta Giovia e Schiner e gli altri
maestri dei due giovani Sforza a Innsbruck non poterono servirsene.
Per conservare le memorie più epiche e agiografiche di Milano e
della loro famiglia, i due ragazzi potevano però contare sulla
compagnia e sull’assistenza dei tanti milanesi e lombardi esiliati in
Tirolo dopo la vi oria francese. Furono questi fuoriusciti a
descrivere loro, forse esagerando un po’, talvolta, per effe o di una
struggente nostalgia, la grandezza e la bellezza della Milano di
epoca sforzesca, sopra u o se paragonata al tetro grigiore di
Innsbruck. Furono loro a decantare la ricchezza, la laboriosità e la
maestria di artigiani e agricoltori, l’abilità dei mercanti e dei
banchieri, la magnificenza di arte e cultura di tu e le ci à del
Ducato.
«Cari cugini» esordì dunque Bianca Maria con tono stranamente
severo, lei sempre pacata e docile, «mio marito l’imperatore mi ha
incaricato di me ervi a parte di sue importantissime decisioni prese
in questi giorni per riportare la pace in Italia ma anche a tutela dei
diri i vostri e della vostra, della nostra dinastia.»
I due ragazzi la guardavano a oniti e in rispe oso silenzio. Con i
suoi trentacinque anni – allora, per una donna, era già un’età
avanzata – Bianca Maria, benché di un’anomala e inquietante
magrezza, era ancora molto bella, di una bellezza fiera e raffinata,
ereditata dalla madre, Bona di Savoia. Alta, carnagione
bianchissima, occhi azzurri su un viso rotondo ma con zigomi forti e
la fronte alta, lunghi capelli color rame sempre lasciati cadere sulle
spalle tranne quando l’etiche a di corte imponeva di acconciarli in
una voluminosa treccia raccolta intorno alla nuca. Tanto splendore
naturale era arricchito da una sofisticata eleganza nell’abbigliamento
e nel portamento, uno stile che Bianca Maria aveva imparato a
Milano e che destava ammirata meraviglia ma anche qualche
disappunto nella provinciale e severa corte di Innsbruck, dove non
erano abituati al culto dell’armonia e della grazia. Tu avia,
l’inconsueta magrezza e il pallore del viso dell’imperatrice, insieme
ai troppo frequenti colpi di tosse, davano la sgradevole sensazione di
una sua salute malferma.
Ercole Massimiliano e Francesco erano rimasti sorpresi da
quell’ina eso e inconsueto annuncio. Mai, infa i, erano stati messi al
corrente delle strategie politiche dell’imperatore e con la loro cugina,
sua consorte, avevano intra enuto rapporti cordiali e perfino
affe uosi ma sempre discreti, come il severo genitore aveva loro
ordinato.
D’altra parte, il rispe o le era dovuto: Bianca Maria era figlia di
Galeazzo Maria Sforza, il primogenito del grande Francesco e di
Bianca Maria Visconti. Signore non amato dai milanesi – che
rimpiangevano suo padre – Galeazzo Maria fece una bru a fine,
assassinato da tre congiurati nella basilica di Santo Stefano il 26
dicembre 1476. Naturale, dunque, che l’imperatrice, nelle cui vene
scorreva sangue sforzesco, sentisse molto stre i i suoi legami con la
dinastia di cui faceva parte e ineludibili i doveri che ne derivavano.
Pur non potendo dimenticare che la madre, l’infelice Bona di Savoia,
vedova di Galeazzo Maria, detestasse invece il Moro, che l’aveva
vessata, emarginata e infine espulsa dal potere ducale. Di
conseguenza, nonostante l’a accamento alla famiglia, anche lei
detestava quello zio arrogante, cinico, spregiudicato ma sopra u o
troppo intelligente per poterlo contrastare.
«Come sapete» proseguì Bianca Maria, «repressa la ribellione di
Genova che ormai si protraeva da quasi un anno, poche se imane fa,
il 29 aprile, il re di Francia è tornato in forze a Milano, che era già
sua, ma ancora una volta da vincitore, con arrogante esibizione di
potenza, per confermarne il possesso, tanto che ha fa o il suo
ingresso al Castello di Porta Giovia, la reggia degli Sforza, la nostra
reggia, amati cugini, passando so o archi trionfali, su un sontuoso
carro, affiancato da femminili figure allegoriche – Temperanza,
Fortezza, Prudenza e Giustizia – e allestimenti che intendevano
rappresentare un preteso potere perfino sull’Italia intera. In effe i,
tu i sanno che da Milano egli intende prendere le mosse per tentare
di impadronirsi del Regno di Napoli.»
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :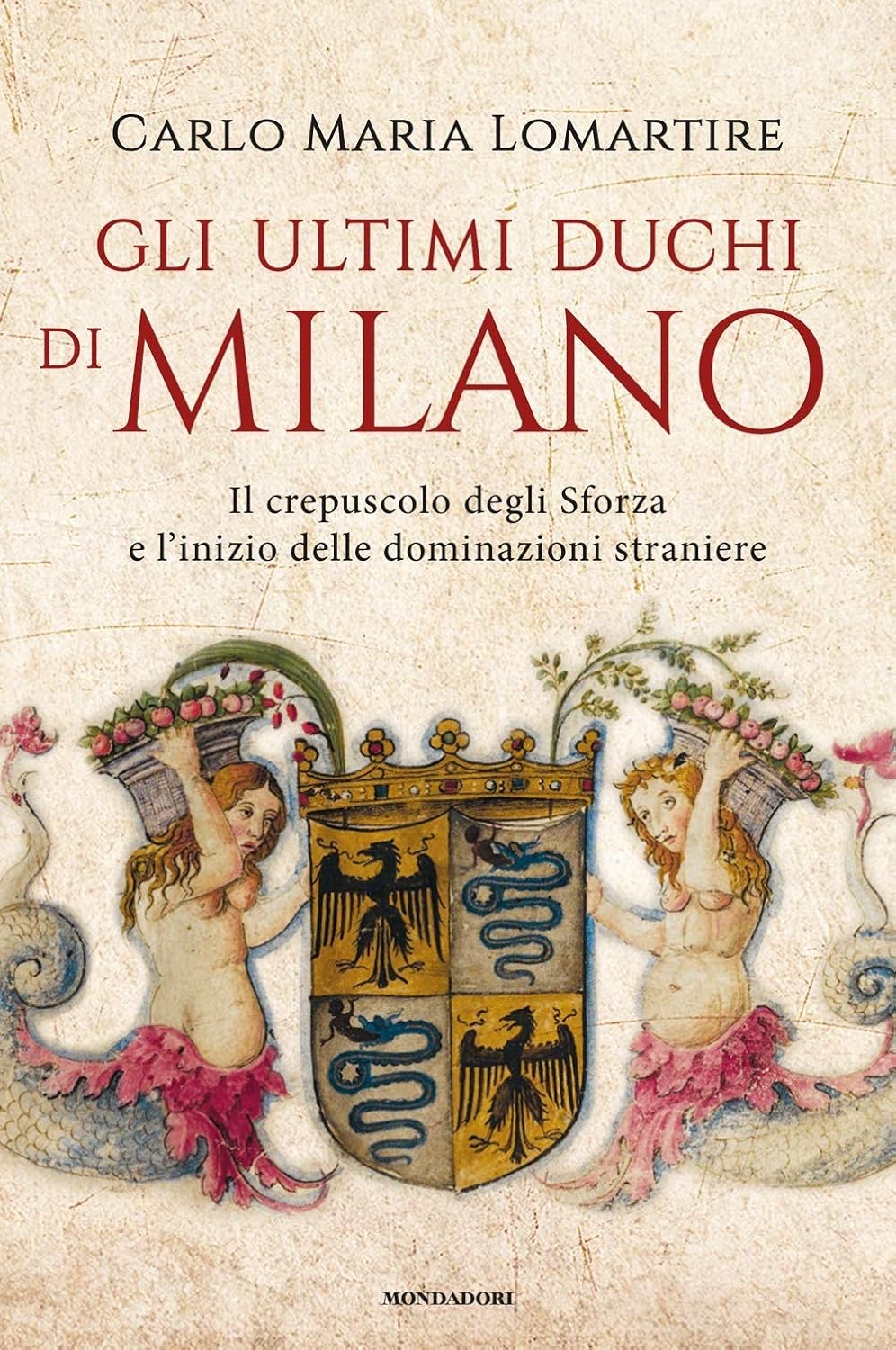






Commento all'articolo