Giochi al buio – Toni Morrison
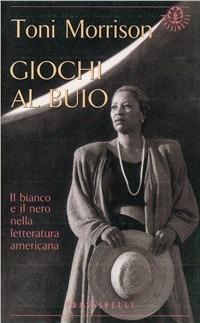
SINTESI DEL LIBRO:
Questi capitoli si propongono di estendere lo studio della letteratura
americana a quello che sarà, mi auguro, un paesaggio più vasto. Vorrei tracciare
la mappa, per così dire, di una geografia critica e usarla per aprire nuovi spazi
alla scoperta, all'avventura intellettuale e all'esplorazione ravvicinata, simili a
quelli aperti dalla originaria cartografia del Nuovo Mondo, ma senza mandati di
conquista. Il mio intento è quello di tracciare un progetto critico affascinante,
fecondo e provocatorio, sgravato da sogni sovversivi o chiamate a raccolta
attorno ai muri della fortezza.
Vorrei fosse chiaro fin dall'inizio che non apporterò a tali questioni
unicamente o neppure principalmente gli strumenti della critica letteraria. Come
lettrice (prima di diventare una scrittrice) leggevo nel modo in cui mi era stato
insegnato. Ma come scrittrice i libri mi si sono rivelati assai diversi. In questa
veste, so di dover riporre una fiducia enorme nella mia abilità di immaginare gli
altri e nella mia buona volontà di proiettarmi coscientemente nelle aree
pericolose che questi altri possono rappresentare per me. Sono attirata dai modi
in cui lo fanno gli altri scrittori: il modo in cui Omero descrive un ciclope
mangiacuori sì che i nostri cuori si stringono per la pietà; il modo in cui
Dostoevskij ci costringe all'intimità con Svidrigailov e con il Principe Myskin.
Sono in soggezione davanti all'autorità del Benjy di Faulkner, della Maisie di
James, della Emma di Flaubert, del Pip di Melville, del Frankenstein di Mary
Shelley - chiunque può allungare l'elenco.
Mi interessa ciò che causa e rende possibile l'ingresso in ciò che ci è
estraneo, e ciò che impedisce le incursioni, per i fini della narrativa, nei meandri
della coscienza vietati all'immaginazione dello scrittore. Il mio lavoro mi
costringe a riflettere su quanto posso essere libera, come scrittrice
afroamericana, in un mondo determinato dalle categorie di genere, sesso e razza.
Pensare a tutte le implicazioni della mia situazione (e lottare contro di esse)
mi porta a riflettere su quel che accade quando altri scrittori operano in una
società altamente e storicamente multirazziale. Per loro, come per me,
immaginare non significa soltanto guardare o osservare; né significa mettersi,
intatti, nell'altro. Significa, per i fini del lavoro, divenire.
Il mio progetto nasce dal piacere, non dalla delusione. Nasce da ciò che so
sui modi in cui gli scrittori trasformano aspetti delle loro radici sociali in aspetti
linguistici, e sui modi in cui raccontano altre storie, combattono guerre segrete,
illustrano ogni tipo di dibattito racchiuso nel loro testo. E nasce dalla mia
convinzione che gli scrittori sanno sempre, a un certo livello, di fare proprio
questo.
è ormai da tempo che rifletto sulla validità o vulnerabilità di certi presupposti
convenzionalmente accettati dagli storici e dai critici letterari e divulgati come
"sapere"
In base a ciò la letteratura americana tradizionale, canonica, non risente né è
permeata o formata dai quattro secoli di presenza, sul suolo degli Stati Uniti, di
africani prima e di afroamericani poi. Si presuppone che questa presenza - che ha
plasmato il corpo politico, la costituzione e l'intera storia della cultura - non
abbia avuto un posto significativo né abbia esercitato conseguenze sull'origine e
sullo sviluppo della letteratura di quella cultura. Si presuppone altresì che le
caratteristiche della nostra letteratura nazionale provengano da una particolare
"americanità", separata da e non riconducibile a questa presenza. A quanto pare,
tra gli studiosi c'è un accordo più o meno tacito in base a cui, dal momento che la
letteratura americana è stata chiaramente appannaggio delle opinioni dei bianchi
di sesso maschile, del loro talento e potere, tali opinioni, talento e potere non
sarebbero in alcun rapporto con la massiccia presenza di neri negli Stati Uniti.
Questo accordo riguarda una popolazione che ha preceduto qualsiasi scrittore
americano di chiara fama ed è stata, ne sono convinta, una delle forze che hanno
influito in modo più furtivamente radicale sulla letteratura del Paese.
Contemplare la presenza dei neri è fondamentale per la comprensione della
nostra letteratura nazionale e non si dovrebbe permettere che essa resti ai
margini dell'immaginario letterario.
Queste congetture mi hanno portato a chiedermi se le caratteristiche più
importanti della nostra letteratura nazionale, quelle sempre portate in palmo di
mano - l'individualismo, la mascolinità, l'impegno sociale contro l'isolamento
storico; le problematiche morali acute e ambigue; la tematica dell'innocenza
associata all'ossessione di raffigurazioni della morte e dell'inferno - non siano di
fatto la risposta a una presenza africanista oscura, costante, pregnante. E ho
cominciato a credere che il modo in cui la letteratura americana si distingue,
come entità coerente, sia tale proprio a causa di questa popolazione inquietante e
senza radici. Così come la formazione della nazione necessitava di un linguaggio
codificato e di restrizioni significative per affrontare la malafede razziale e la
fragilità morale che ne costituiscono il nucleo, la stessa cosa è accaduta con la
letteratura, le cui caratteristiche fondamentali si estendono fin nel ventesimo
secolo, riproducendo la necessità di codici e restrizioni.
Grazie a omissioni significative ed evidenti, contraddizioni sorprendenti e
conflitti pesantemente sfumati, grazie al modo in cui gli scrittori hanno popolato
le loro opere con i segni e i corpi di questa presenza, è possibile vedere come
questa presenza africanista, reale o costruita, sia stata cruciale per il loro senso di
"americanità" Si vede eccome.
* * *
La mia curiosità sulle origini e sugli usi letterari di questa presenza
africanista, attentamente osservata e attentamente inventata, si è trasformata in
uno studio informale di ciò che io chiamo africanismo americano. Si tratta di
un'indagine sui modi in cui negli Stati Uniti si è costruita una presenza (o un
personaggio) non bianca, para-africana (o africanista), e sugli usi immaginativi a
cui questa presenza fabbricata è stata sottoposta. Uso il termine "africanismo"
non per suggerire il vasto corpus di conoscenze sull'Africa indicato con il
termine "africanismo" dal filosofo Valentine Mudimbe, né per suggerire le
varietà e complessità degli africani e dei loro discendenti che hanno abitato
questo Paese. Lo uso piuttosto come termine per designare un colore, il nero
denotativo e connotativo che i popoli africani sono giunti a significare, nonché
l'insieme di opinioni, presupposti, interpretazioni e fraintendimenti che
accompagnano il sapere eurocentrico su questi popoli.
Come tropo, ai suoi usi sono state attribuite poche limitazioni. Come virus
invalidante nell'ambito del discorso letterario, l'africanismo è diventato, nella
tradizione eurocentrica favorita dal sistema educativo americano, sia un modo di
parlare sia un modo di disciplinare questioni di classe, di licenza sessuale e di
repressione, di formazione ed esercizio del potere, di meditazioni sull'etica e
sulla responsabilità. Per mezzo di un semplice espediente, quello di demonizzare
e reificare la gamma di colori su una tavolozza, l'africanismo americano
permette di dire e non dire, di inscrivere e cancellare, di fuggire e impegnarsi, di
esprimere e agire, di storicizzare e di porre fuori dal tempo. Fornisce un modo
per contemplare il caos e la civiltà, il desiderio e la paura, e un meccanismo per
verificare i problemi e i benefici della libertà.
Gli Stati Uniti, naturalmente, non sono i soli a costruire l'africanismo.
Il Sudamerica, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, la Spagna - le culture di
tutti questi Paesi hanno partecipato e contribuito per certi aspetti a un'"Africa
inventata" Per lungo tempo, nessuno di questi Paesi è stato capace di persuadersi
del fatto che potessero emergere dei criteri e un sapere al di fuori delle categorie
di dominazione. Tra gli europei e gli europeizzati, questo processo comune di
esclusione - di assegnare designazioni e valori - ha portato alla nozione popolare
e accademica secondo la quale il razzismo è un fenomeno forse irritante, ma
"naturale" La letteratura di quasi tutti questi Paesi, tuttavia, è ora soggetta a forti
critiche per il suo discorso razziale. Gli Stati Uniti sono una curiosa eccezione,
sebbene si distinguano per essere la democrazia più antica in cui una
popolazione nera abbia accompagnato (se si può usare questa parola) e in molti
casi preceduto i coloni bianchi.
All'interno di questo ambito - con le sue formulazioni particolari e in assenza
di conoscenze reali o di indagini imparziali sugli africani e sugli afroamericani, e
sotto la pressione di spiegazioni razionali ideologiche e imperialiste
sull'asservimento - è emersa una specie americana di africanismo: vigorosamente
incoraggiata, del tutto funzionale, di conforto e di sostegno all'io e assai diffusa.
Per eccellenti ragioni di stato - poiché le fonti europee di egemonia culturale
erano state sì diffuse nel nuovo Paese ma non ancora valorizzate -, il processo
attraverso il quale giungere a una coerenza americana distanziandosi
dall'africanismo è divenuto il modus operandi di una nuova egemonia culturale.
Queste osservazioni non devono essere interpretate come un semplice sforzo
per stornare altrove lo sguardo degli studi sugli afroamericani. Non è mia
intenzione alterare una gerarchia per istituirne un'altra. E non voglio
incoraggiare quegli approcci totalizzanti alle ricerche sugli afroamericani, il cui
unico impulso è dato dalla sostituzione di una dominazione con un'altra, sicché
una dottrina dominante eurocentrica viene sostituita da una dottrina dominante
afrocentrica. Assai più interessante è ciò che rende possibile la dominazione
intellettuale; come il sapere viene trasformato dall'invasione e dalla conquista in
rivelazione e scelta; ciò che accende e feconda l'immaginario letterario e quali
forze contribuiscono a stabilire i parametri critici.
Soprattutto mi interessa sapere in che cosa si sono distinte le priorità della
critica e, così facendo, come hanno impoverito la letteratura oggetto di studio.
La critica come forma di sapere è capace di derubare la letteratura non solo della
sua ideologia implicita ed esplicita ma anche delle sue idee; essa è in grado di
liquidare l'arduo lavoro compiuto dagli scrittori per creare un'arte che diventi e
rimanga parte integrante e significativa di un paesaggio umano. è importante
vedere quanto l'africanismo è o dovrebbe essere inestricabile dalle deliberazioni
della critica letteraria e dalle arbitrarie ed elaborate strategie intraprese per
cancellarne la presenza dall'orizzonte.
Ciò che l'africanismo è diventato per l'immaginario letterario, e il modo in
cui ha funzionato al suo interno, è di estrema importanza perché, grazie a un
esame ravvicinato del "nero" nella letteratura, si può forse scoprire la natura
addirittura la causa - del "bianco" Qual è lo scopo di tutto ciò? Che ruoli
svolgono l'invenzione e lo sviluppo del bianco nella costruzione di ciò che in
modo generico viene descritto come "americano"? Se una simile ricerca
giungerà mai a dare dei frutti, essa potrà forse dare adito a una lettura più
profonda della letteratura americana, una lettura non del tutto disponibile ora,
non da ultimo, presumo, a causa della studiata indifferenza della maggior parte
della critica letteraria nei confronti di tali questioni.
Una probabile ragione per la scarsezza di materiale critico su un tema così
vasto e avvincente è che, nelle questioni razziali, il silenzio e l'evasione del tema
hanno storicamente governato il discorso letterario. L'evasione ha favorito la
creazione di un surrogato del linguaggio, nel quale le questioni vengono
codificate, precludendo così un dibattito aperto. La situazione è resa più grave
dalla trepidazione con cui si accoglie ogni discorso sulla razza. Ed è
ulteriormente complicata dal fatto che l'abitudine di ignorare la razza viene
intesa come un gesto garbato, addirittura generoso e liberale. Accorgersene
significa riconoscere una differenza ormai screditata. Attuarne l'invisibilità
attraverso il silenzio significa permettere al corpo nero di partecipare senza fare
ombra al corpo culturale dominante. Secondo questa logica, la buona educazione
si oppone al fatto di accorgersi e preclude così ogni trattazione adulta del tema. è
proprio questo concetto di costumi letterari ed eruditi (che funziona senza traumi
nella critica letteraria, ma che non suscita né ottiene credibilità in altre
discipline) ad aver posto fine alla vita attiva di certi autori americani, un tempo
assai stimati, e ad aver bloccato la facoltà di comprendere più a fondo la loro
opera.
Questi costumi sono cose delicate, tuttavia, sulle quali bisogna riflettere un
poco prima di abbandonarle. Se non si osservano simili finezze, si rischia di
incorrere in sorprendenti errori di oggettività. Nel 1936 uno studioso americano
che compiva delle ricerche sull'uso del cosiddetto dialetto dei neri nelle opere di
Edgar Allan Poe (un breve articolo chiaramente fiero della sua equanimità
razziale) esordisce nel modo seguente: "Sebbene sia cresciuto soprattutto al Sud
e abbia trascorso una parte dei suoi anni più fecondi a Richmond e Baltimora,
Poe non ha molto da dire sui mori"1
Benché, sappia che l'espressione rientra nel linguaggio educato del tempo, e
che darky, moro, era un termine più accettabile di nigger, negro, alla smorfia che
ho fatto leggendo è seguita un'allarmata sfiducia nelle competenze di quello
studioso. Se vi sembra ingiusto risalire agli anni Trenta per trovare campioni del
tipo di errore in cui si può incorrere quando si rinuncia a certe educate
consuetudini nell'esercizio della repressione, consentitemi di rassicurarvi sul
fatto che alcune rappresentazioni altrettanto egregie del fenomeno sono ancora
assai comuni.
Un'altra ragione del vuoto ornamentale all'interno del discorso letterario - in
quanto alla presenza e all'influenza dei popoli africanisti tra i critici americani - è
data dal modello di pensiero sulla questione razziale in termini di conseguenze
sulla vittima, dal fatto di definirla sempre asimmetricamente, dal punto di vista
delle sue ripercussioni sull'oggetto della politica e dei comportamenti razzisti. Si
è sempre consacrata una gran quantità di tempo e di intelligenza alla denuncia
del razzismo e delle sue orride conseguenze sulle vittime. Si compiono continui
sforzi liberalizzanti, seppur vaghi, per regolare la questione con le leggi. Vi sono
altresì tentativi energici e persuasivi per analizzare l'origine e la costruzione
stessa del razzismo, contestando il presupposto secondo cui sarebbe una parte
inevitabile, permanente ed eterna di ogni paesaggio sociale. Non è mia
intenzione sminuire il valore di tali ricerche. è proprio grazie a questi studi se
siamo riusciti a compiere passi avanti nella questione razziale.
Ma a questi studi ormai consolidati se ne dovrebbe aggiungere un altro,
altrettanto importante: l'impatto del razzismo su chi lo perpetua. è tanto
pertinente quanto impressionante osservare come si eviti di analizzare gli effetti
del razzismo sul soggetto.
Ciò che mi propongo qui è di esaminare le conseguenze delle nozioni di
gerarchia, di esclusione, di vulnerabilità e di disponibilità razziale su quei non
neri che hanno fatto proprie tali nozioni, oppure che le hanno combattute,
esplorate o alterate. Lo studioso che scruta nella mente, nell'immaginazione e nel
comportamento degli schiavi è prezioso. Ma altrettanto prezioso è un serio
sforzo intellettuale per vedere ciò che l'ideologia razziale fa alla mente,
all'immaginazione e al comportamento dei padroni.
A questi campi d'indagine si sono accostati gli storici, e così hanno fatto
sociologi, antropologi, psichiatri e alcuni studiosi di letterature comparate. I
letterati hanno cominciato a porre la questione di varie letterature nazionali. Si
avverte sempre più urgentemente il bisogno di rivolgere lo stesso tipo di
attenzione alla letteratura del Paese occidentale che possiede una delle
popolazioni africaniste più dotate di capacità di ripresa al mondo, una
popolazione che ha sempre vissuto in strana intimità con quella dominante pur
essendone radicalmente separata.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :





Commento all'articolo