Gas in Etiopia – I crimini rimossi dell’Italia coloniale – Simone Belladonna
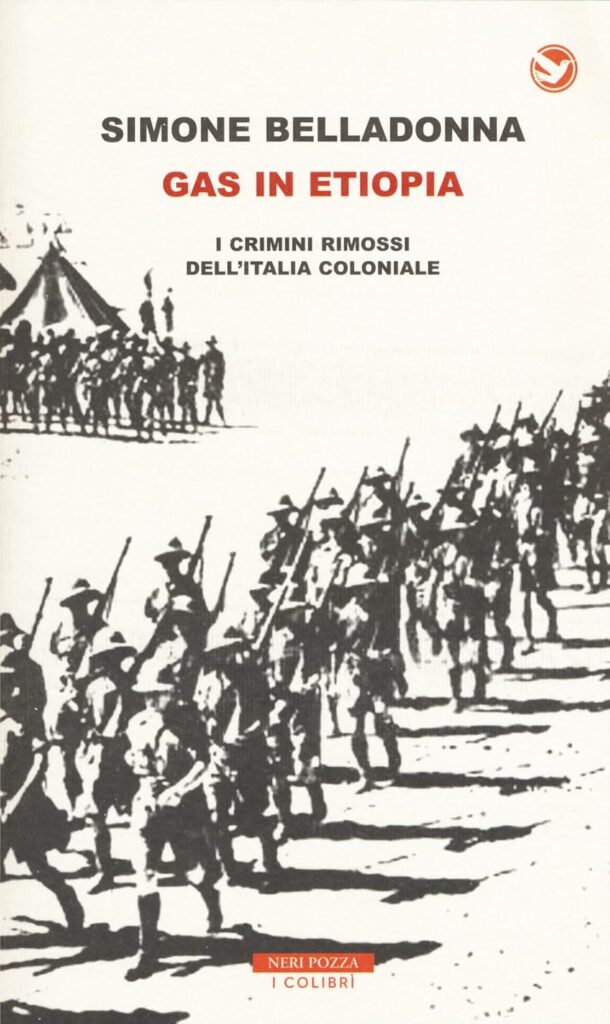
SINTESI DEL LIBRO:
La genesi della campagna
ando nacque l’idea di intraprendere una campagna coloniale come
quella in Etiopia? È probabile che il Duce l’avesse presa in considerazione
f
in dai tempi prossimi alla presa del potere, ma è difficile datarne l’origine,
non essendo possibile scavare nella mente del diatore italiano.
Angelo Del Boca ritiene che Mussolini meditasse la conquista fin dal
1925. Già l’8 luglio di quell’anno, infai, in una leera indirizzata al
ministro delle Colonie, il principe Lanza di Scalea, il Duce scriveva:
«Prepararsi militarmente e diplomaticamente e approfiare di un
eventuale sfasciamento dell’impero etiopico. Nell’aesa, lavorare in
silenzio, sin dove sia possibile in collaborazione con gli inglesi, e
cloroformizzare il mondo ufficiale abissino»
1
. Ad avvalorare la tesi
abbiamo la testimonianza dell’imperatore Hailé Selassié, il quale ricordava
che, durante la sua visita in Italia nel 1924, molti lo avevano avvertito
dell’eventualità di una guerra. Sempre il Negus raccontava che in seguito,
nonostante il traato di amicizia siglato tra i due Paesi nel 1928, l’Italia
aveva cominciato a prepararsi militarmente per un aacco all’Etiopia;
quindi, ogni azione definibile “amichevole”, come le pressioni per far
entrare l’Etiopia nella SdN, in verità sarebbe servita soltanto a dissimulare
le reali intenzioni bellicose. Del resto, nello stesso 1928 l’Italia concludeva
anche un accordo segreto con l’Inghilterra per sancire le rispeive zone
d’influenza. Senza contare che Mussolini intorno alla fine degli anni Venti
cercava con sempre maggiore insistenza di favorire la disgregazione
dell’impero etiopico, già molto eterogeneo, corrompendo uno dopo l’altro
alcuni dei più influenti membri della società abissina. Hailé Selassié
spiegava proprio con queste operazioni soobanco le rivolte di ras2 Gugsa
nel 1930 e di ras Hailù due anni dopo. Infine, sappiamo che già nel 1925 il
Duce aveva dato incarico al ministro delle Colonie di informarlo
sull’eventuale possibilità di mobilitare grandi unità indigene in caso di
conflio.
Più sceico, invece, lo storico Anthony Mockler che con pragmatismo
anglosassone ribae che di per sé l’architeare piani di aggressione non
comporta necessariamente l’intenzione di dichiarare guerra: «Mussolini
all’epoca di Ual-Ual intendeva entrare in guerra e invadere l’Etiopia? La
risposta deve essere un “no” a ragion veduta. Chiaramente doveva aver
pensato a una guerra con l’Etiopia; […] d’altro canto questo non dimostra
neppure che avesse già deciso una guerra contro l’Etiopia. In un certo
senso tui i capi politici italiani da Adua in poi avevano fao piani per
muovere guerra all’Etiopia […] Ma fare piani per una guerra, per quanto
precisi, non prova l’intenzione di dichiararla. È quasi certo che negli ultimi
mesi del 1935 i capi di stato maggiore italiani avessero ricevuto l’ordine di
studiare un piano di guerra contro l’Inghilterra, e nel luglio del 1934
contro la Germania. Eppure, sarebbe ridicolo arguire da ciò che Mussolini
intendesse far guerra all’Inghilterra o alla Germania. […] In altre parole
non: “Perché la guerra?” ma: “Perché la guerra in quel momento?” […]
L’Italia invase l’Etiopia in uno dei rari momenti in cui non vi erano crisi
interne; inoltre, scelse d’aendere finché l’esercito etiope non fosse, se non
completamente modernizzato, almeno addestrato e riequipaggiato. Da un
punto di vista tecnico Mussolini non avrebbe potuto scegliere un
momento peggiore»
3
.
Per quanto suggestiva, però, la tesi di Mockler è perlomeno discutibile,
forse anche un po’ romantica. A suo avviso la guerra è scoppiata nel 1935
perché in Italia regnava una calma piaa che a Mussolini stava troppo
strea4: il potere fascista era ormai consolidato, gli avversari politici erano
ridoi a una flebile minaccia e la campagna di Libia era giunta al termine.
L’inguaribile disgusto che l’uomo d’azione prova nel momento in cui si
rende conto che il successo è ormai scontato, in aggiunta all’ombra che la
f
igura di Hitler stava geando sul capo del governo italiano, spiegherebbe
gli obieivi della guerra: ridare slancio all’Italia fascista e prestigio al suo
Duce. Si traa di una leura di sicuro impao, che punta sull’analisi
psicologica di uno dei maggiori aori del Novecento. Appare troppo
semplicistica e riduiva, tuavia, per spiegare la genesi di un’impresa
coloniale complessa tanto da accendere la lunga miccia che porterà al
conflio più spaventoso che la Storia ricordi.
Non possiamo, infine, prescindere dai documenti per ricostruire
quando, in effei, la decisione fu presa, e perché. Il ministro delle Colonie
De Bono, rientrando in Italia da una visita in Eritrea, il 22 marzo 1932,
scriveva al Duce: «L’Abissinia è un’incognita non ancora paurosa, ma che
può diventarlo […]. Se Selassié continuerà a organizzare forze regolari
come sta facendo – bisognerà pensare seriamente ai fai nostri […].
L’Etiopia, per quanto faccia parte della Società delle Nazioni e posi a
popolo di matura civiltà, non è in sostanza che uno stato semibarbaro.
Perciò quel che meglio capisce e che, forse, solo comprende, è l’uso della
forza. Un nostro intervento armato in forze che ci desse un successo
militare stabilizzerebbe per anni la nostra situazione. Ma è inutile pensarci
adesso. Esso comporterebbe un lungo lavoro di preparazione e centinaia di
milioni di spesa, che sarebbero meglio impiegati altrove»
5
.
De Bono, dunque, pur lasciando intravedere la possibilità di un
intervento, lo rimandava considerando i tempi non ancora maturi;
affronta, comunque, la questione suggerendo che l’Italia ricerchi
l’appoggio di Francia e Inghilterra per una comune opera di disgregazione
dell’impero del Negus. Lo stesso ministro poi incaricherà il colonnello
Luigi Cobeddu, comandante delle truppe in Eritrea, di preparare un piano
d’invasione, non è dato sapere se per sua iniziativa personale o a seguito
di un accordo con il capo del governo. el che è certo è che il 29
novembre 1932 De Bono mise in moto il meccanismo di preparazione
dell’offensiva, secondo quanto scriveva al ministro della Guerra, Pietro
Gazzera:
«Oggeo: preparazione militare in Africa orientale
[…] Indirizzata così la preparazione militare, è possibile ora guardare
con un senso di maggiore realtà alla risoluzione del problema etiopico.
Considereremo due ipotesi, che a mio avviso, contemplano tue le
possibilità di eventuali conflii con l’Abissinia:
1. Ipotesi che chiamerò offensiva, e che corrisponde alla decisione di
effeuare occupazioni territoriali in quel paese per il raggiungimento delle
nostre finalità politiche ed economiche. Dirò subito che una tale
eventualità esige il presupposto politico di una intesa con la Francia e
l’Inghilterra. […]
2. Ipotesi che chiamerò difensiva, e che corrisponde al caso in cui non
sia possibile alla madre patria inviare forze in colonia, o che la colonia
venga aggredita prima che tali forze abbiano la possibilità di giungere»
6
.
Nel prosieguo della leera De Bono poneva le basi per un piano di
aggressione, con tanto di consigli strategici su come e da dove
intraprendere la campagna, sul numero di soldati necessari e sulla quantità
di uomini a disposizione del Negus.
Nei mesi successivi Mussolini si diede da fare per accentrare il potere
su di sé: il 21 luglio 1933 liquidava, infai, il ministro della Guerra
Gazzera, assumendosi la responsabilità del dicastero e nominando come
soosegretario il fedele generale Federico Baistrocchi; quaro mesi più
tardi fu la volta dei ministri dell’Aeronautica Italo Balbo e della Marina
Giuseppe Sirianni a esser dispensati dal loro incarico. A quel punto il Duce
riuniva nelle sue mani le tre amministrazioni militari e, se i cambi al
vertice erano sostanzialmente formali, non comportando alcuna
riorganizzazione degli alti comandi, il significato politico di quelle
manovre è chiaro: il capo del governo era ormai orientato verso la guerra
all’Etiopia e ogni probabile successo non sarebbe stato condiviso con altri.
La decisione di invadere l’Etiopia, quindi, stava maturando, com’è
testimoniato anche dall’interesse dimostrato dagli alti comandi
dell’esercito: sono del seembre di quell’anno le osservazioni del capo di
Stato maggiore Alberto Bonzani in merito allo schema di operazioni di De
Bono, che venne stravolto e criticato. Bonzani soolineava che le
tempistiche per l’afflusso delle truppe dall’Italia erano quantomeno
illusorie e che l’avanzata iniziale così come prevista avrebbe rischiato di
far disperdere le forze italiane. L’ipotesi di una rapida e decisa offensiva
portata avanti da De Bono e dai funzionari del ministero delle Colonie
veniva oscurata dall’approccio più cauto proposto dagli ambienti militari,
che propendevano per una più aenta preparazione finalizzata ad
assicurare l’obieivo: la conquista dell’impero.
L’elemento di maggiore interesse, in questo caso, è rappresentato
proprio dall’emergere di contrasti sempre meno latenti tra il ministero
della Guerra e quello delle Colonie: dove il primo voleva istituire una
campagna di tipo “europeo”, ossia basata sull’impiego estensivo e
coordinato di artiglieria, aviazione e automezzi – e i militari avrebbero
assunto inesorabilmente le maggiori responsabilità di comando; mentre il
secondo ipotizzava una guerra più “tradizionale”, nella quale grazie alla
superiorità delle truppe bianche e alla mobilità di quelle indigene
avrebbero valicato qualsiasi ostacolo – e il comando sarebbe andato ai
vecchi esperti coloniali. Una dialeica che investiva la natura stessa della
campagna: un conflio di grandi dimensioni volto a schiacciare l’impero
etiopico o una guerra tradizionale di proporzioni limitate con obieivi
territoriali ridoi?
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :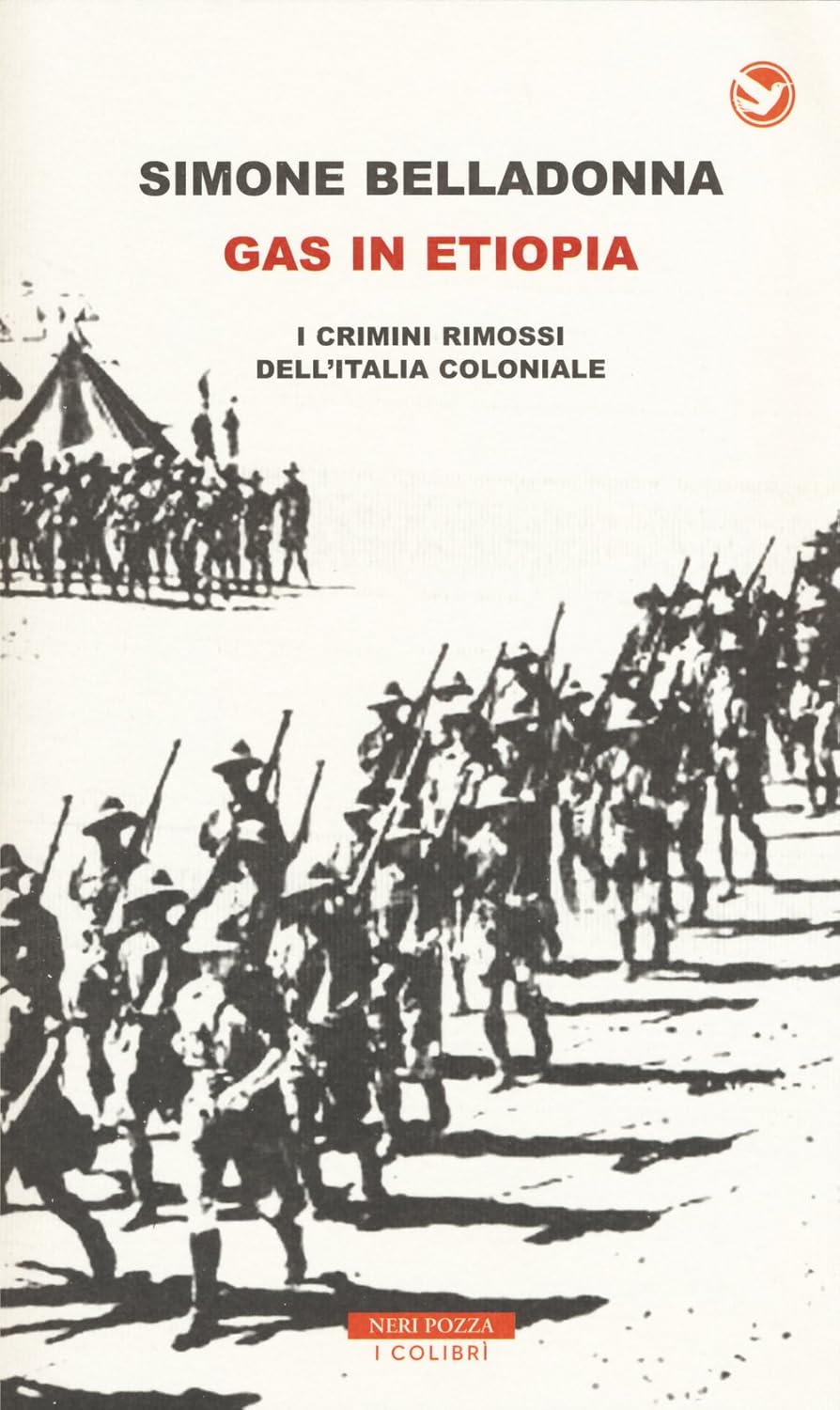






Commento all'articolo