Finanzcapitalismo – Luciano Gallino
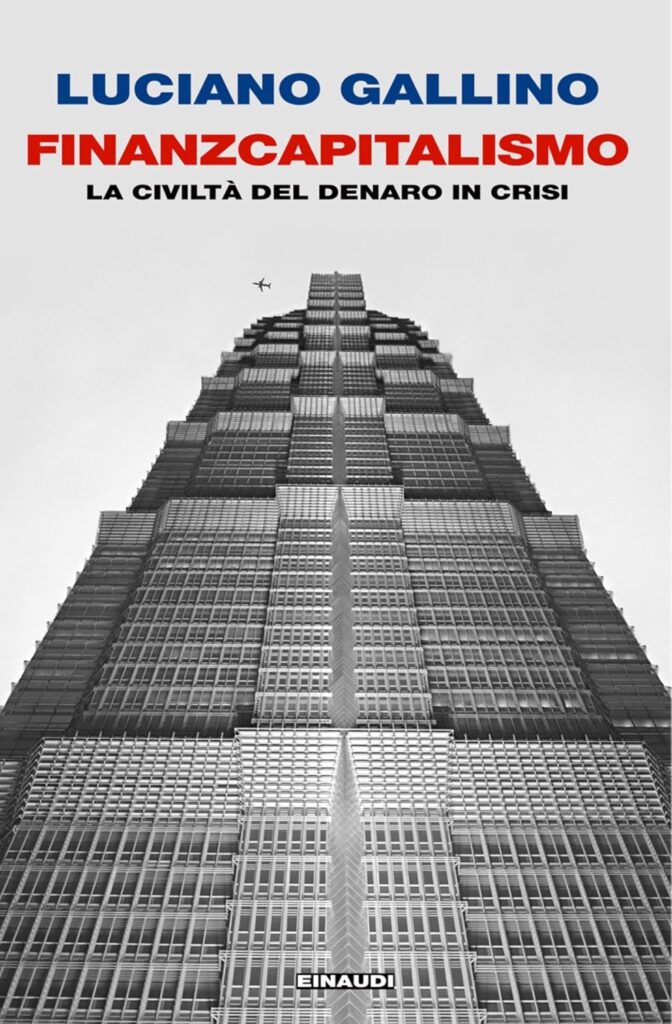
SINTESI DEL LIBRO:
Una mega-macchina costruita per estrarre valore.
1
Mega-macchine sociali: cosí sono state de nite le grandi organizzazioni
gerarchiche che usano masse di esseri umani come componenti o servo
unità
. Mega-macchine potenti ed efficienti di tal genere esistono da migliaia
di anni. Le piramidi dell’antico Egitto sono state costruite da una di esse
capace di far lavorare unitariamente, appunto come parti di una macchina,
decine di migliaia di uomini per generazioni di seguito. Era una mega
macchina l’apparato amministrativo-militare dell’impero romano.
Formidabili mega-macchine sono state, nel Novecento, l’esercito tedesco e la
burocrazia politico-economica dell’Urss.
Il nanzcapitalismo è una mega-macchina che è stata sviluppata nel corso
degli ultimi decenni allo scopo di massimizzare e accumulare, sotto forma di
capitale e insieme di potere, il valore estraibile sia dal maggior numero
possibile di esseri umani, sia dagli ecosistemi. L’estrazione di valore tende ad
abbracciare ogni momento e aspetto dell’esistenza degli uni e degli altri,
dalla nascita alla morte o all’estinzione. Come macchina sociale, il
nanzcapitalismo ha superato ciascuna delle precedenti, compresa quella del
capitalismo industriale, a motivo della sua estensione planetaria e della sua
capillare penetrazione in tutti i sotto-sistemi sociali, e in tutti gli strati della
2
società, della natura e della persona
.
L’estrazione di valore è un processo affatto diverso dalla produzione di
valore. Si produce valore quando si costruisce una casa o una scuola, si
elabora una nuova medicina, si crea un posto di lavoro retribuito, si lancia
un sistema operativo piú efficiente del suo predecessore o si piantano alberi.
Per contro si estrae valore quando si provoca un aumento del prezzo delle
case manipolando i tassi di interesse o le condizioni del mutuo; si impone
un prezzo arti ciosamente alto alla nuova medicina; si aumentano i ritmi di
lavoro a parità di salario; si impedisce a sistemi operativi concorrenti di
affermarsi vincolando la vendita di un pc al concomitante acquisto di quel
sistema, o si distrugge un bosco per farne un parcheggio.
Accostando come si è fatto sopra capitale e potere non s’intende qui
riproporre la tradizionale concezione che rinvia al potere del capitale. In suo
luogo si avanza la nozione di capitale come forma di potere in sé, un potere
organizzato su larghissima scala
3
. Stando a questa nozione, «i capitalisti
sono mossi non dall’intento di produrre cose bensí da quello di controllare
persone, e la loro mega-macchina capitalistica esercita questo potere con
una efficienza, essibilità e forza che gli antichi governanti non potevano
nemmeno immaginare»
4
. Di conseguenza non è esatto dire che il capitale ha
potere. Il capitale è potere. Il potere di decidere che cosa produrre nel
mondo, con quali mezzi, dove, quando, in che quantità. Il potere di
controllare quante persone hanno diritto a un lavoro e quante sono da
considerare esuberi; di stabilire in che modo deve essere organizzato il
lavoro; quali debbano essere i prezzi degli alimenti di base, di cui ciascun
punto percentuale in piú o in meno aumenta o diminuisce di una quindicina
di milioni, nel mondo, il numero degli affamati; quali malattie sono da
curare e quali da trascurare, ovvero quali farmaci debbano essere sviluppati
dai laboratori di ricerca oppure no.
Ancora, il capitale è il potere di trasformare le foreste pluviali in legno per
mobili e i mari in acque morte; di brevettare il genoma di esseri viventi
evolutisi nel corso di miliardi di anni e dichiararlo proprietà privata; di
decidere quali debbono essere i mezzi di trasporto usati dalla gran
maggioranza della popolazione e con essi quale debba essere la forma delle
città, l’uso del territorio, la qualità dell’aria. Sul momento queste
affermazioni possono apparire alquanto perentorie; l’evidenza a loro
supporto si farà strada nei successivi capitoli.
La mega-macchina denominata capitalismo industriale aveva come
motore – e per quel che ne resta ha tuttora – l’industria manifatturiera. Il
nanzcapitalismo ha come motore il sistema nanziario. I due generi di
capitalismo differiscono sostanzialmente per il modo di accumulare il
capitale. Il capitalismo industriale lo faceva applicando la tradizionale
formula D1–M–D2, che signi ca investire una data quantità di denaro, D1,
nella produzione di merci, M, per ricavare poi dalla vendita di queste ultime
una quantità di denaro, D2, maggiore di quella investita. La differenza tra
D2 e D1 è un reddito chiamato solitamente pro tto o rendita. Per contro il
nanzcapitalismo persegue l’accumulazione di capitale facendo tutto il
possibile per saltare la fase intermedia, la produzione di merci. Il denaro
viene impiegato, investito, fatto circolare sui mercati nanziari allo scopo di
produrre immediatamente una maggior quantità di denaro. La formula
dell’accumulazione diventa quindi D1–D2.
A questa differenza fondamentale nella formula dell’accumulazione il
nanzcapitalismo accompagna una pretesa categorica: si deve ricavare dalla
produzione di denaro per mezzo di denaro un reddito decisamente piú
elevato rispetto alla produzione di denaro per mezzo di merci. Non
mancano gli esempi. Si sa che gli investitori istituzionali, in specie fondi
pensione e fondi comuni, esigono dalla quota di capitale investito in
un’impresa un rendimento annuo minimo del 15 per cento. I fondi
specializzati nel comprare imprese per poi rivenderle pezzo a pezzo
(chiamati private equity funds) non sono soddisfatti se da tali operazioni non
ricavano un pro tto di almeno il 20 per cento. Grandi banche europee
sollecitano gli investitori istituzionali a investire in titoli di corporation del
settore alimentare assicurando che ne trarranno un reddito intorno al 25 per
cento. Fondi specializzati nella gestione di grandi patrimoni privati
promettono a chi può investire capitali rilevanti, e non disdegna di correre
rischi elevati, un rendimento pari o superiore al 30 per cento.
Ora avviene che il Pil del mondo cresca da decenni a un tasso compreso
tra il 3 e il 5 per cento annuo. Poiché alla ne dei conti pro tti o rendite
aventi una base reale non possono superare la crescita reale della ricchezza
prodotta, quando risultino nominalmente di varie volte piú alti essi debbono
provenire solamente da due fonti. Uno studioso del dominio del denaro le
sintetizza cosí: «1) Una redistribuzione a spese di altre fonti di reddito
realizzata mediante manipolazione di prezzi a scopi speculativi, salari in
essione, privatizzazione di prestazioni statali o sfruttamento internazionale;
2) La crescita del capitale in forza di un rendimento piú elevato è soltanto
un’espressione monetaria nominale. In questo caso essa corrisponde a una
5
in azione dei titoli nanziari, a una bolla»
. Nella sua veste di mega
macchina deputata a estrarre valore, il nanzcapitalismo ha sfruttato
soprattutto la prima fonte, la redistribuzione dal basso verso l’alto.
Contemporaneamente ha però indotto negli anni ’90 e nei primi anni 2000
un cospicuo incremento dei valori di borsa. Si fosse mai trattato di un
qualsiasi altro elemento, un simile fenomeno sarebbe stato giudicato un
processo fortemente in attivo.
Componenti strutturali del finanzcapitalismo.
Il braccio operativo del nanzcapitalismo è il sistema nanziario di cui si
è dotato. Lo formano un paio di componenti strutturali che hanno raggiunto
entrambe negli ultimi anni una eccezionale dimensione e complessità, piú
una terza che si colloca per vari aspetti a cavallo delle altre due. La prima
componente del sistema nanziario opera in larga misura alla luce. Per
de nirla si è usato spesso, discutendo della crisi, il termine «sistema
bancocentrico», volendo sottolineare come le istituzioni in esso
predominanti sono soprattutto grandi banche. In realtà, sebbene sia quasi
inevitabile ricorrervi per brevità, il termine è divenuto da tempo inadeguato.
Anche quando siano ancora chiamate sovente con il nome che designava la
loro attività originaria – per cui si parla della banca X, della compagnia di
assicurazione Y, della cassa di depositi e prestiti Z e simili – le istituzioni che
caratterizzano il sistema nanziario della nostra epoca sono grandi società
che operano in almeno una dozzina di settori di attività differenti, ben
lontani da quello originario, e in ciascuno di questi controllano decine se
non centinaia di società, tra le quali possono esservi una o piú banche.
Siamo quindi dinanzi a immense reti societarie nelle quali si intrecciano
inestricabilmente sia le funzioni che i titoli di proprietà.
Per menzionare qualcuna di tali reti a ni indicativi, e sempli cando
molto, si può dire che esistono società nanziarie, dette bank holding
companies, le quali controllano a un tempo sia banche che compagnie di
assicurazione; banche proprietarie di assicurazioni del comparto
immobiliare e compagnie di assicurazione sulla vita che sono proprietarie di
banche; banche commerciali che hanno divisioni operanti come banche di
investimento e viceversa; società che emettono titoli aventi per collaterale o
garanzia un bene reale – una casa, un’azienda, un pacchetto di titoli
oppure un bene irreale come un debito; banche o loro divisioni specializzate
nel vendere certi cati di protezione dal rischio che un debitore sia insolvente
le quali, al tempo stesso, comprano certi cati analoghi per proteggere se
stesse dal rischio di fallimento del protettore; e, ancora, casse di depositi e
prestiti che provvedono ad assicurare o ri-assicurare ipoteche e imprese
sponsorizzate da un governo unicamente per assicurare ipoteche che si
dedicano a cospicue attività d’investimento non per conto di clienti, bensí
per conto proprio.
La componente «bancocentrica» del sistema nanziario, per quanto
complessa, è composta da entità visibili, nel senso che hanno nome e
indirizzo, società controllate o liali ufficialmente elencate, tot dirigenti e tot
dipendenti, azionisti o proprietari privati per lo piú chiaramente
individuabili, nonché bilanci ufficiali in cui sono registrati attivi e passivi.
Per contro esiste una seconda componente del sistema stesso che risulta
priva di tutti o quasi i suddetti caratteri, sicché le sue attività sono
discernibili a fatica anche dagli esperti. Per questo viene chiamata finanza
ombra. Le sue dimensioni, in termini di attivi, superano di molte volte gli
attivi delle società nanziarie che di essa tengono i li, sebbene sia arduo
stabilire quale sia alla ne il totale degli attivi (o dei passivi) che sono in
capo a ciascuna di esse. La nanza ombra è formata da montagne di derivati
(titoli il cui valore dipende da un’entità sottostante: piú avanti se ne parlerà a
lungo) che una banca detiene ma che per varie ragioni non sono registrati in
bilancio; da migliaia di società prive in realtà di sostanza organizzativa,
costituite dalle banche unicamente allo scopo di veicolare fuori bilancio
attivi che dovrebbero gurarvi (per questo sono chiamate «veicoli»); da altre
migliaia di intermediari specializzati nel confezionare e vendere soprattutto
a investitori istituzionali ed enti pubblici dei titoli obbligazionari
complicatissimi, formati da un gran numero di altri titoli; da centinaia di
trilioni (in dollari) di derivati che con l’intermediazione di una banca o altra
istituzione nanziaria sono scambiati direttamente tra privati, al di fuori di
ogni registrazione in borsa. Grazie a questi caratteri, la nanza ombra risulta
praticamente invisibile anche alle autorità di vigilanza, quindi di fatto non
regolabile.
Una terza componente del sistema nanziario che sta a cavallo tra il
sistema bancocentrico e la nanza ombra è costituita dagli investitori
istituzionali: principalmente fondi pensione, fondi comuni di investimento,
compagnie di assicurazione e fondi comuni speculativi (come sono
denominati dalla normativa italiana gli hedge funds, espressione che signi ca
letteralmente «fondi di copertura» o di protezione). Gli investitori
istituzionali sono una delle maggiori potenze economiche del nostro tempo.
Gestiscono un capitale di oltre 60 trilioni di dollari, equivalente al Pil del
mondo 2009. Le loro strategie di investimento inuenzano sia le sorti delle
grandi corporation sia quelle dei bilanci statali.
Affermare che gli investitori istituzionali si muovono a cavallo delle altre
due componenti è appropriato per diversi motivi. In primo luogo esistono
fondi pensione e fondi comuni che sono una emanazione di società
nanziarie o grandi banche, ma vi sono anche in entrambi i settori dei fondi
indipendenti. Tra di essi spiccano i fondi pensione del pubblico impiego,
autentici colossi nanziari che in Giappone, in Olanda, in California
controllano ciascuno patrimoni di centinaia di miliardi di dollari. Cosí come
sono indipendenti le «famiglie» di fondi comuni, in prevalenza statunitensi,
che gurano insieme con grandi gruppi bancari nella classi ca dei primi
dieci o venti investitori del mondo.
In secondo luogo sistema bancocentrico, nanza ombra e investitori
istituzionali sono collegati da scambi quotidiani di denaro e capitale
dell’ordine di centinaia di miliardi di dollari o di euro. Vari sono i canali di
tali scambi. Anzitutto una quota importante del capitale gestito da questi
investitori viene via via depositato in banche, che lo impiegano
immediatamente ai loro ni. Soltanto in Italia, dove i fondi pensione sono
ancora comparativamente modesti, il capitale da essi depositato per legge
nelle banche vale 70 miliardi di euro. Inoltre ogni giorno gli stessi investitori
acquistano o vendono centinaia di miliardi di azioni od obbligazioni emesse
dal sistema bancario. Sono clienti di peso delle citate società veicolo,
mediante le quali i crediti delle banche fuoriescono dal bilancio per
diventare titoli commerciabili. Da parte loro, inne, i fondi speculativi fanno
largo uso della leva nanziaria, che vuol dire acquistare pacchetti azionari e
intere imprese per mezzo di denaro preso in prestito dalle banche in
quantità che superano di parecchie volte il capitale proprio. Gli interessi su
simili prestiti formano una quota rilevante dei ricavi delle banche.
In terzo luogo, nessuna società nanziaria, e nessuna corporation
industriale, può permettersi di ignorare le richieste degli investitori
istituzionali. Questi posseggono oltre la metà di tutte le società quotate in
borsa, per cui hanno un ruolo determinante nel proporre e imporre
politiche sia nanziarie che industriali, fusioni e acquisizioni di società,
nonché l’assunzione o il licenziamento dei massimi dirigenti.
In forza delle tre componenti suindicate, che formano il suo braccio
operativo e hanno avuto un esorbitante sviluppo a partire dagli anni ’80 del
secolo scorso, la mega-macchina del nanzcapitalismo è giunta ad asservire
ai propri scopi di estrazione del valore ogni aspetto come ogni angolo del
mondo contemporaneo. Un simile successo non è dovuto a un’economia che
con le sue innovazioni ha travolto la politica, bensí a una politica che ha
identi cato i propri ni con quelli dell’economia nanziaria, adoperandosi
con ogni mezzo per favorire la sua ascesa. In tal modo la politica ha abdicato
al proprio compito storico di incivilire, governando l’economia, la
convivenza umana. Ma non si è limitata a questo. Ha contribuito a
trasformare il nanzcapitalismo nel sistema politico dominante a livello
mondiale, capace di uni care le civiltà preesistenti in una sola civiltà
mondo, e al tempo stesso di svuotare di sostanza e di senso il processo
democratico.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :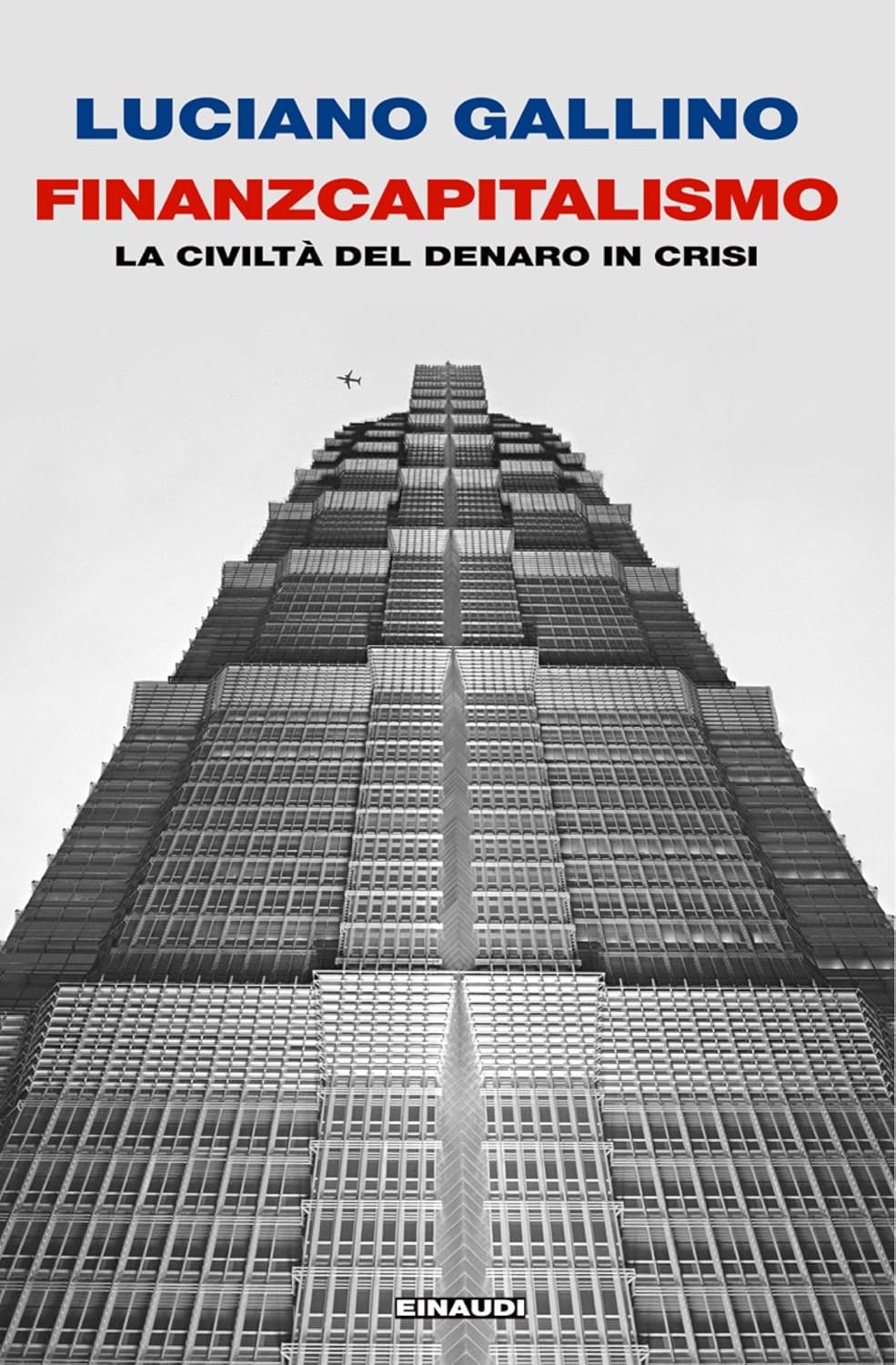






Commento all'articolo