Ebraismo e arte contemporanea- Clement Greenberg, Arthur Danto, Isidore Isou, Abraham Moles – Mario Costa
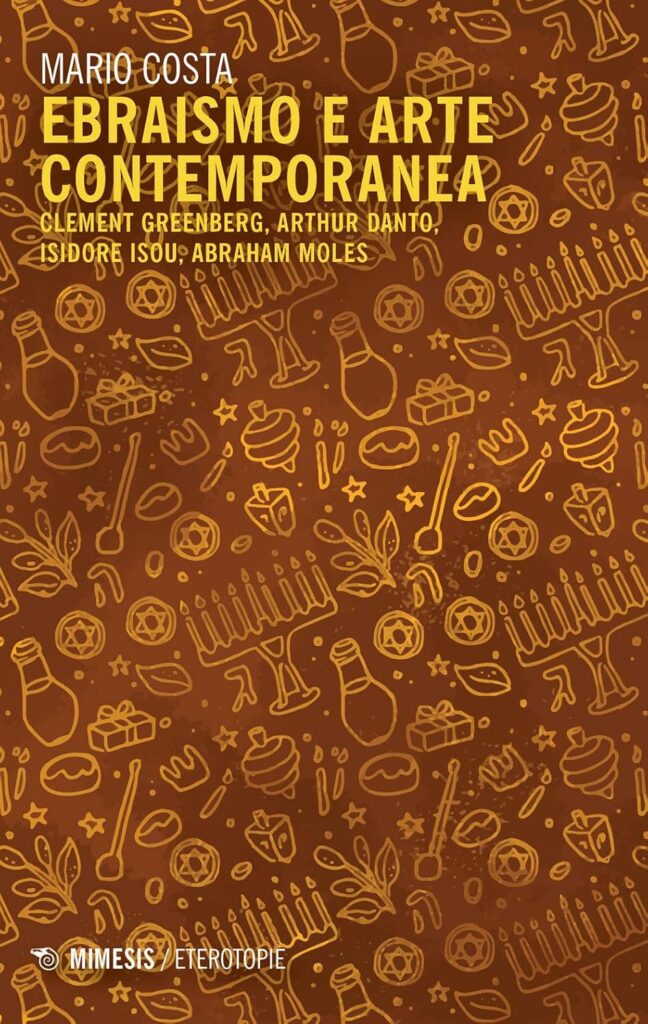
SINTESI DEL LIBRO:
All’indomani della seconda guerra mondiale, la questione fondamentale
per l’arte era ancora quella della sua sopravvivenza. Le avanguardie
l’avevano abbondantemente ridotta in macerie: Duchamp aveva esposto un
orinatoio, i dadaisti gridavano da tutte le parti che con l’arte bisognava farla
finita, i futuristi, oltre a voler “distruggere i musei, le biblioteche, le
accademie d’ogni specie”, non si capiva bene che cosa volessero, la pittura
non sapeva più a quale santo rivolgersi, in Russia qualcuno aveva già messo
mano a qualcosa che con l’arte non aveva più nulla a che fare.
L’arte, insomma, era ancora in pericolo di vita, ma l’arte, come la Misery
di un terribile film di Robert Reiner, non doveva morire. E allora, in sintesi,
si ricorse a una strategia che dura ancora oggi ed è sempre più efficace,
quella di far passare per arte la sua stessa consunzione e poi la sua fine. Ma
procediamo con ordine.
Bisognava, dunque, far finta di niente e ricominciare daccapo, a partire
proprio dalla pittura; essa, dopo gli impressionisti, era andata nella
direzione indicata da Maurice Denis nel 1890.
Denis, infatti, apre le sue Théories 1890-1910, pubblicate nel 1913, con la
celebre frase, o principio primo: “I – Ricordarsi che un quadro – prima di
essere un cavallo di battaglia, una donna nuda, o una qualunque altra
rappresentazione – è essenzialmente una superficie piana ricoperta di colori
messi assieme in un certo modo”
3
, e nella Prefazione alla seconda edizione
del libro, quella del 1920, qui seguita, commentando il successo ottenuto
dal libro, dice: “È la prima parte, e nella prima parte la prima frase, quella
che è stata più letta, più citata. La più commentata […] Essa tendeva, con
tutto
il
suo
dell’astrattismo”
contesto,
4
.
ad
orientare
la
pittura
nella
direzione
E così fu. Da Gauguin in poi e fino all’astrattismo, la pittura non fu altro
che una superficie ricoperta di colori messi assieme in un certo modo,
decorativo, fauve, lirico o variamente astratto e geometrico che fosse
5
.
Ricominciare dalla pittura significava ricominciare dal punto al quale la
pittura era arrivata.
L’action painting di Rosenberg (1952) e la colour field painting di
Greenberg, i due espressionismi astratti, ripartono da lì: la flatness di
Greenberg è la “superficie piana” di Denis senza “cavallo di battaglia” o
“donna nuda”.
La nuova estetizzazione della superficie non può più, insomma, essere in
alcun
6
,
modo ricavata dalla figurazione, pena il rinnegamento
dell’avanguardia
e della bellezza neanche a parlarne, riesumarla dopo le
avanguardie era impossibile, e allora che fare?
Ma, liquidata la “bellezza”, restava pur sempre l’“attrattiva”.
L’“attrattiva” è quella che immediatamente esercitano i materiali e i segni
per la loro stessa costituzione, la risonanza sensibile che essi provocano
indipendentemente dalla cultura, la loro immediata azione sul sistema
nervoso: il colore grigio non è un verde brillante, il zigzag di una linea non
è una circonferenza.
Per il colore, il test di Hermann Rorschach è troppo noto per doverne
parlare, basta dire che le reazioni emotive alla esposizione dei colori delle
dieci tavole costituiscono l’elemento più importante nella analisi degli stati
profondi della psiche. Il test ebbe, già negli anni ’40, una enorme diffusione
negli Stati Uniti e la sua esistenza era ben nota anche al di fuori degli
ambienti specialistici.
Rorschach morì nel 1922 a trentotto anni, un anno dopo aver pubblicato il
suo libro, e nel suo test il colore era soltanto uno degli elementi da
considerare e da analizzare. Nel 1949 un altro psichiatra svizzero, Max
Lüscher, mise a punto un altro test nel quale l’analisi della personalità era
interamente fondata sul solo colore, il suo “test dei colori” ebbe
immediatamente una diffusione mondiale, Stati Uniti inclusi. Il test si
fondava, nella sua versione ridotta e generalmente usata, su otto tavole
colorate tra le quali la persona analizzata doveva operare una serie di scelte
e di associazioni (preferenza, indifferenza, repulsione …). Dei colori si
delineava una vera “fisiologia”:
Il colore rosso vivo – ad esempio – ha un effetto stimolante sul sistema nervoso; aumenta la
tensione arteriosa, la frequenza respiratoria e cardiaca. Il rosso è, dunque, un ‘eccitante’ del
sistema nervoso, specialmente della frazione simpatica del sistema nervoso autonomo (SNA).
Esperimenti analoghi condotti con il colore blu scuro, hanno evidenziato, per questo colore, un
effetto contrario: la pressione arteriosa diminuisce, come pure la frequenza cardiaca e respiratoria.
Il blu scuro è dunque ‘calmante’ nei suoi effetti ed agisce principalmente attraverso la frazione
7
parasimpatica del SNA.
L’azione svolta sul sistema nervoso dai segni, per la loro immediata
configurazione fisica, è poi uno dei punti più convincenti dell’estetica di
Susan Langer: se su una superficie traccio una linea fatta in un certo modo,
le sensazioni e le sollecitazioni virtuali che da essa mi provengono sono
diverse da quelle che mi provengono da una linea fatta diversamente, e
questo perché le linee “esprimono vitalità in ciò che esse sembrano ‘fare’”
Anche a questo la Langer attribuisce una causa fisiologica:
8
.
La spiegazione degli effetti dinamici di quelli che sono, in fin dei conti, segni assolutamente
statici su uno sfondo, è che la loro possente ‘persuasione dell’occhio’ genera un vero e proprio
movimento di quell’organo e che la sensazione nei muscoli dell’occhio ci fa percepire
effettivamente il movimento.9
E non basta, la Langer sostiene che anche per il colore vale la stessa cosa,
e che questa struttura formale, fatta di linee e di colori messi in un certo
modo, precede e sottende ogni figurazione:
In realtà, io credo, uno studio comparativo dell’arte decorativa e dell’arte primitiva della
rappresentazione mostra inequivocabilmente che per prima si dà la forma, e che la funzione
rappresentativa si sovrappone ad essa.
10
Insomma la rappresentazione è secondaria e si sovrappone semplicemente
alle stimolazioni sensoriali provenienti dalle linee e dai colori in quanto tali,
vera e primaria causa di ogni effetto estetico.
E allora, la manovra dell’espressionismo astratto e dei suoi derivati per far
sopravvivere la pittura, è stata quella di far emergere in primo piano il
livello fisiologico e primitivo dei colori e delle linee di forza, di sopprimere
la rappresentazione e di ottenere da tutto questo un effetto ancora in qualche
modo estetico.
In linguaggio kantiano potremmo dire che l’espressionismo astratto ha
messo l’ “attrattiva” al posto della “bellezza”, si è servito cioè delle
sollecitazioni neuro-sensoriali provenienti dagli elementi materiali, il colore
e le linee, per mettere in opera un piacere puramente e solamente
sensibile
11, si capisce, virtualmente sensibile, che con la bellezza, ma più
specificamente, con l’arte, non ha più nulla a che fare. Su questo Kant ha le
idee ben chiare col suo sostenere che “Il puro giudizio di gusto è
indipendente da attrattive ed emozioni”
12; insomma, l’ “attrattiva” non deve
essere scambiata con la “bellezza”, l’una essendo connessa con la materia
del piacere l’altra con la forma:
Ogni interesse corrompe il giudizio di gusto […] i giudizi così modificati non possono avere
alcuna pretesa alla validità universale […] Il gusto resta sempre barbarico, quando abbia bisogno
di unire al piacere le attrattive e le emozioni, o di queste faccia anche il criterio del suo consenso.
Tuttavia le attrattive non solo sono spesso attribuite alla bellezza, come un contributo al piacere
estetico di validità universale, ma son date esse stesse come bellezze, e la materia del piacere viene
scambiata con la forma.
13
Ed è proprio quello che fa l’espressionismo astratto, esso scambia la
materia del piacere con la forma ed in esso il gusto resta pur sempre
barbarico.
Questa utilizzazione della materia del piacere come arte o, anzi, come la
più autentica delle arti, vale, con qualche anticipo sull’espressionismo
astratto, come principio di base del lavoro e delle teorie di Jean Dubuffet.
Quando Dubuffet, nel 1968, pubblicò il libro Asphyxiante Culture non era
per seguire la moda e, anzi, la sua insofferenza già sessantottesca verso
l’organizzazione globale della società si era manifestata molti anni prima,
già subito dopo la guerra mondiale, ed aveva, per questo, cominciato a
collezionare oggetti “artistici” che con l’arte occidentale non avevano nulla
a che fare: una alterità artistica radicale che individuava in artefatti, anche
fatti male, prodotti da carcerati, da folli, da artisti di strada, da bambini, da
popolazioni primitive.
Asphyxiante Culture è la summa delle sue convinzioni antisociali ed
anticulturali: “la cultura, contrariamente a quanto si crede, è restrittiva,
limitativa, oscurantista. Quello che manca alla cultura è il gusto della
germinazione anonima, innumerevole”
14, “non posso pensare al ministero
della cultura se non come alla polizia della cultura”
15, “I professori sono
scolari attardati che, lasciate le aule, sono usciti dalla scuola da una porta
per entrarvi dall’altra”
16, “La cultura, come un dio simbolico, non chiede
altro ai ministri del suo culto che delle cerimonie votive”
17, “La cultura è
essenzialmente selettiva e dunque impoverisce”
18, “Le produzioni che
avevano qualcosa di veramente sovversivo sono state sempre totalmente
screditate e non hanno mai avuto il minimo posto nella cultura”
19. La
cultura opera un condizionamento continuo, a cominciare dal linguaggio
che impone: “Il vocabolario […] è il nemico del pensiero”
20, e allora sono
necessari “istituti di deculturazione, specie di ginnasi nichilisti”
21. E in tutto
questo, l’arte è soltanto un aspetto particolare della falsificazione generale
operata dalla cultura: “un aspetto particolarmente importante della nostra
cultura è quello di stabilire dappertutto delle misure che corrispondono a
scale di valore”
22,
“l’idea di bello […] porta con sé l’intenzione
propriamente culturale di una priorità donata ad un certo tipo di opere su
tutte le altre […] dietro c’è il magister con la sua ferula e dietro di lui il
gendarme. Se è della bellezza che intendete produrre, siete dalla loro parte,
favorite la diffusione della loro merce, alimentate la loro predica”
insomma, questa idea di “un valore oggettivo di un’arte”
23,
24 è solo
un’impostura.
E dunque, se la cultura e la sua arte sono tutto questo, bisogna rivolgersi
altrove e, nella convinzione che “la barbarie […] è un valore che va
preservato”
25,
cercare appunto una art brut, tendenzialmente non
contaminata dalla cultura, là dove essa si trova e si nasconde.
Questa utilizzazione della materia del piacere per confezionare arte, nella
quale essenzialmente consiste l’ art brut di Dubuffet, coincide, in realtà,
con la strategia alla quale ricorre tutta la pittura, per sopravvivere, dal 1945
ai primi anni cinquanta, tanto in Europa quanto in America.
Il principio è lo stesso e va da lavori nei quali la figurazione è ancora in
qualche modo presente, come nel gruppo CO.BR.A., in Dubuffet o Fautrier,
e
in alcuni espressionisti astratti americani come de Kooning, fino
all’astrazione pura come in Franz Kline, Matherwell e, diversamente,
Rothko e Barnet Newmann.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :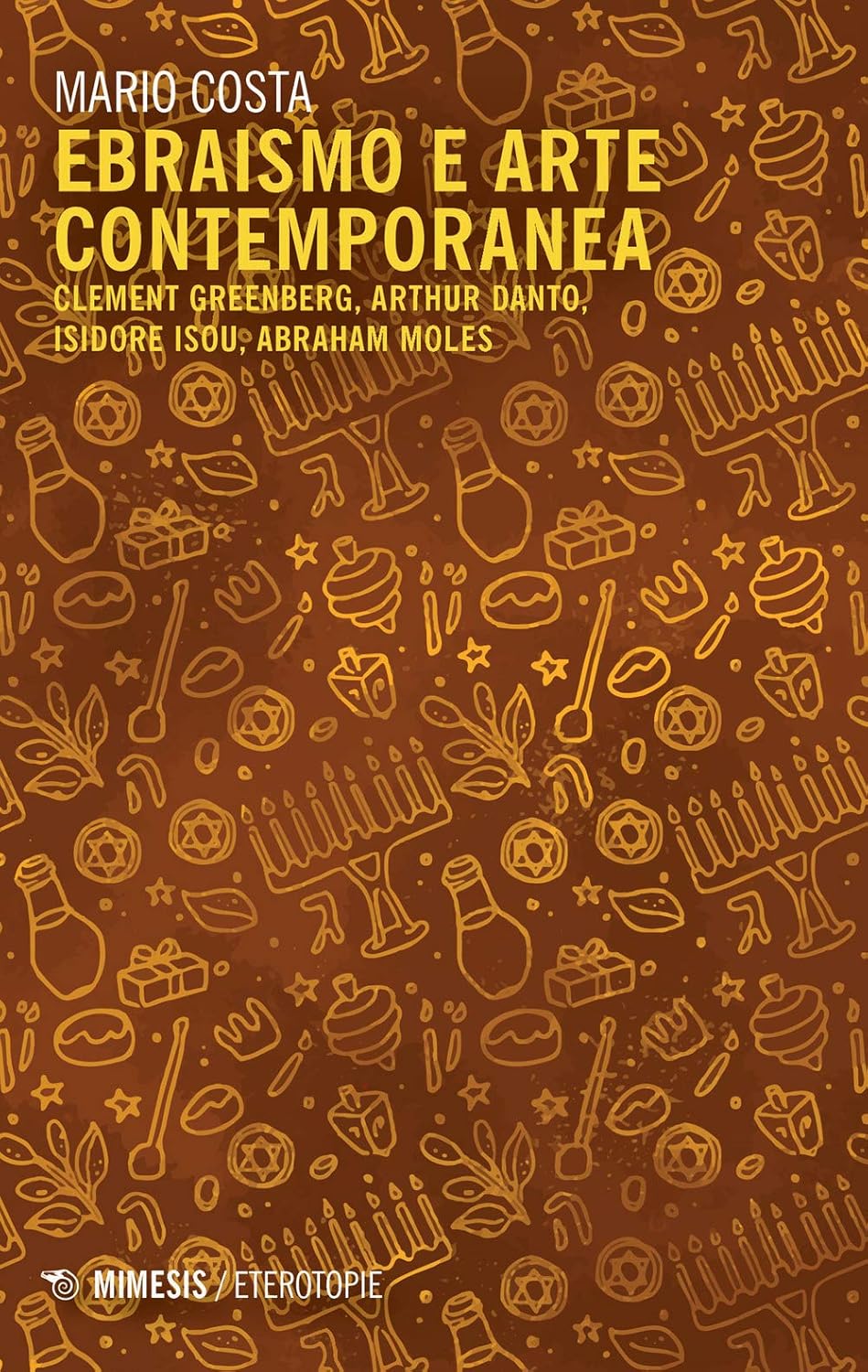






Commento all'articolo