Energia per l’Italia – Giovanni Caprara
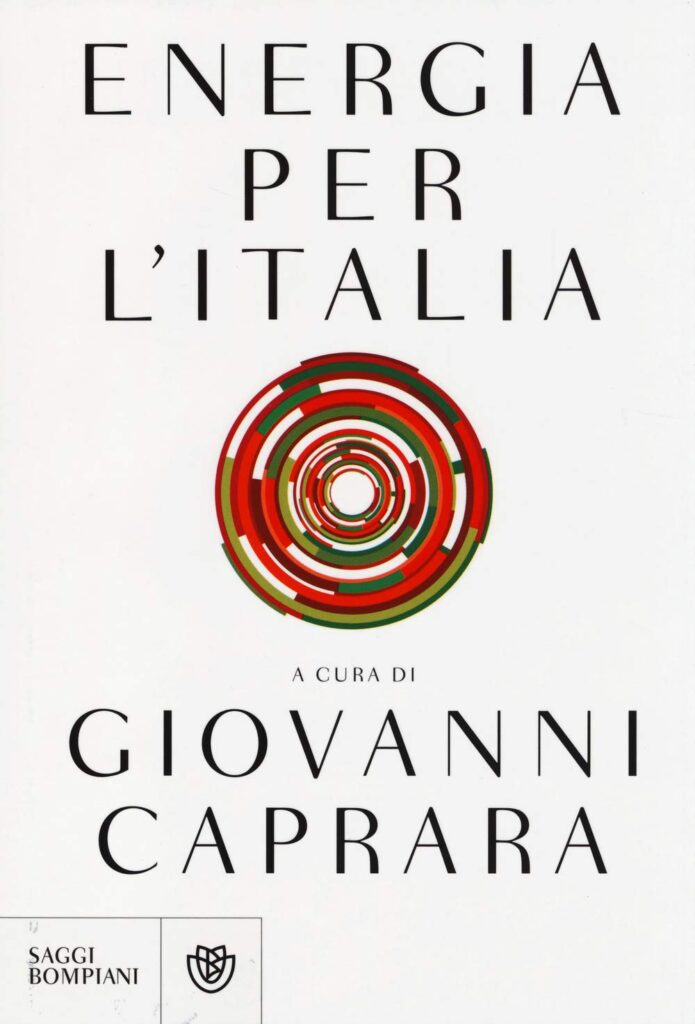
SINTESI DEL LIBRO:
La domanda di energia in Italia è cresciuta nel tempo, passando
da circa 143,3 MTEP (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) del
1981 a 197,8 MTEP del 2005, per poi decrescere lentamente a causa
della crisi dei consumi, arrivando così a circa 173,16 MTEP del 2013.
La copertura di questo fabbisogno è stata garantita in prevalenza dai
prodotti petroliferi, anche se il loro contributo è progressivamente
sceso, passando dal 66% del 1981 al 35% del 2013.
A questa progressiva contrazione dei prodotti petroliferi è
corrisposto un parallelo incremento della partecipazione alla
copertura del fabbisogno energetico da parte del gas naturale, la cui
domanda è passata da 22 MTEP del 1981 (pari a 26,4 miliardi di metri
cubi) a 57,36 MTEP del 2013 (pari a circa 70 miliardi di metri cubi)
coprendo così il 33% della domanda nazionale di energia.
Il contributo dei combustibili solidi è cresciuto leggermente, e cioè
da 12,5 MTEP del 1981 a 14,69 MTEP del 2013, mentre le fonti
rinnovabili hanno avuto, nel periodo in esame, un vero e proprio
“boom”, crescendo da 12 MTEP del 1981 a 30,97 MTEP del 2013,
sostenuto in gran parte dai forti incentivi concessi ai produttori.
Sul fronte degli impieghi finali la crescita più elevata è stata
registrata dal settore trasporti che, negli ultimi trent’anni, ha
registrato un incremento medio annuo del 2%, seguito dal
termoelettrico e dal settore civile.
Nel settore elettrico, che è cresciuto nel periodo in esame di oltre
il 60%, il peso dei prodotti petroliferi è progressivamente diminuito,
spiazzato dalla tecnologia a gas, più efficiente e a minor impatto
ambientale, mentre il nucleare, dopo la chiusura delle centrali nel
1995, non è stato più sviluppato, anche se qualche tentativo di
recupero è stato fatto.
Contraddizioni: esubero di capacità ma
importiamo
Unico Paese europeo, l’Italia importa energia elettrica dall’estero
per circa il 5,3% del proprio fabbisogno, e ciò nonostante vi sia un
esubero di capacità di produzione elettrica. Questa situazione
dipende dai prezzi più vantaggiosi che si ottengono sui mercati
limitrofi all’Italia, principalmente in Francia, Svizzera, Austria, dove la
componente nucleare rende il costo dell’energia elettrica più basso.
I consumi energetici del settore trasporti sono per il 90% coperti
dai prodotti petroliferi, a cui recentemente si è aggiunto il gas
naturale. I consumi energetici del settore civile e del settore terziario
sono soddisfatti prevalentemente da gas naturale.
La situazione italiana per quanto riguarda i consumi energetici
finali non è molto dissimile da quella degli altri Paesi europei.
I consumi nel settore trasporto variano dal 22% dell’Italia al 30%
della Spagna, mentre nel settore civile abbiamo un 21% in Spagna
contro un 28% in Germania, e per il settore elettrico un 35% in Italia
contro un 46% in Francia (dove c’è molto nucleare).
Tra le varie fonti energetiche, il carbone è molto utilizzato in
Germania e Regno Unito (poco in Italia), mentre il gas naturale è
utilizzato in Italia e Regno Unito.
In Italia la produzione nazionale di fonti energetiche è scarsa e
pertanto soddisfa una bassa percentuale dei consumi (circa il 12%).
Il
fabbisogno energetico è prevalentemente coperto peraltro dalle
importazioni, che rappresentano oggi circa l’88% della domanda.
La produzione nazionale è rappresentata da uno sviluppo in fase
decrescente dell’estrazione di idrocarburi (soprattutto gas) in alcune
zone della penisola (in prevalenza marine). La produzione di petrolio
si è attestata negli ultimi 10 anni intorno a 5 milioni di TEP, soprattutto
in Basilicata e poi in Sicilia, mentre quella di gas è in fase
decrescente arrivando a 7,7 miliardi di metri cubi del 2013 dai quasi
18 miliardi di metri cubi del 1991. La produzione di carbone è limitata
a poche centinaia di tonnellate dal Sulcis, poco utilizzate per l’alto
contenuto di zolfo che le rende difficilmente recuperabili dal punto di
vista ambientale ed economico.
Riserve abbondanti non utilizzate
Le riserve certe di petrolio e di gas sono peraltro abbondanti, ma
le
opposizioni locali hanno finora impedito di continuare la
perforazione e lo sviluppo dei giacimenti trovati in terra e in mare nel
corso degli ultimi dieci anni.
La maggior parte della domanda energetica in Italia è pertanto
soddisfatta dall’importazione (88%), che pesa enormemente nella
fattura energetica del nostro Paese che è stata pari a 56,1 miliardi di
euro nel 2013, inferiore di poco meno 9 miliardi rispetto all’anno
precedente per la riduzione della domanda.
I Paesi da cui l’Italia importa maggiormente sono quelli del Nord
Africa (Libia, Algeria, Egitto) per gli idrocarburi liquidi, dal Medio
Oriente, dalla Russia, Norvegia, Olanda per il gas e dal Sud Africa
per il carbone.
Le importazioni avvengono per mezzo di navi per il petrolio e a
mezzo gasdotti per il metano; peraltro in Italia esistono due impianti
di rigassificazione già operativi e un terzo vicino Livorno da poco
entrato in funzione.
L’Italia sta cercando di diversificare i suoi approvvigionamenti di
energia sia per fonte, sia per provenienza, per ridurre i rischi
geopolitici e minimizzare i costi, ma spesso a livello locale ci sono
forti opposizioni alla creazione di nuove infrastrutture come i
rigassificatori o i gasdotti.
Recentemente ad esempio la regione Puglia ha negato l’accesso
a un nuovo gasdotto che dovrebbe arrivare sulle sue coste, che
porterebbe gas dall’Azerbaijan in Italia.
Lo stesso avviene per nuovi rigassificatori che da tempo sono in
attesa delle autorizzazioni locali per essere costruiti.
Anche nel settore delle reti elettriche siamo in attesa da anni di
nuove linee per collegare zone meridionali con quelle dell’Italia
centro-settentrionale dove il costo del kWh è più basso per la
presenza di grandi centrali idro elettriche e a gas.
In Sicilia il prezzo del kWh è, infatti, generalmente superiore al
PUN (Prezzo unico nazionale) del 15-20% per la mancanza di reti.
Parlando di infrastrutture nei vari settori, dobbiamo anche
ricordare che il nostro settore della raffinazione, un tempo al centro
del Mediterraneo per la lavorazione di prodotti petroliferi da destinare
ai mercati occidentali, è in forte crisi con la chiusura di alcune
raffinerie e la vendita di altre.
Il tasso di utilizzo della capacità di raffinazione è pertanto sceso e
la maggior parte delle imprese private hanno ceduto quote importanti
(oppure la proprietà) a società russe.
La rete distributiva dei carburanti in Italia è inoltre una delle meno
efficienti in Europa, perché costituita da circa 23.000 punti vendita
(alcuni molto obsoleti) contro una media di punti di vendita in Europa
che va da 11.600 in Francia a 14.600 della Germania.
La razionalizzazione della rete, iniziata molti anni fa con un
accordo tra compagnie petrolifere e distributori, non solo non si è
mai completata ma, complici gli enti locali, è andata via via
espandendosi con migliaia di punti di vendita self-service che hanno
sostituito le stazioni di servizio, munite di tutti i comfort e con offerte
di prodotti alternativi.
Un altro elemento che costituisce una difficoltà del settore
petrolifero è l’elevato prezzo dei carburanti in Italia (uno dei più alti in
Europa), dovuto alla forte tassazione che lo stato riversa su tutti i
prodotti petroliferi, e in particolare sulla benzina.
A ragione di tutte queste disfunzioni e della crisi dei consumi, da
molti anni l’utilizzo di prodotti petroliferi nel nostro Paese è in forte
riduzione, accentuando così la crisi del settore.
Più corrente elettrica del necessario
Un ultimo importante tassello che riguarda il settore energetico
italiano è quello relativo al comparto elettrico, che non soffre più,
come alcuni anni fa, di mancanza di capacità di generazione ma, al
contrario, di eccesso di capacità dovuta alla crescita imponente e
inarrestabile delle fonti rinnovabili negli ultimi cinque anni.
Questa crescita, sostenuta da forti incentivi per tutte le fonti
rinnovabili, ha creato migliaia di impianti che si immettono in rete,
avendo anche la priorità di dispacciamento, creando in certe ore del
giorno (quelle centrali) un picco di offerta che mette in difficoltà gli
altri produttori che hanno i tradizionali impianti a ciclo combinato a
gas, ma anche la rete elettrica gestita da TERNA che fa fatica a
regolare il flusso di corrente nelle proprie linee.
Questo problema tipico nel nostro Paese, dove non c’è mai stata
una programmazione energetica, sta mettendo in ginocchio quasi
tutte le imprese elettriche, compreso molte utilities, che avevano
investito in cicli combinati a partire dagli anni duemila a seguito di
alcuni black-out e di facilitazioni per la costruzione di nuovi impianti
di generazione elettrica.
Sul piano ambientale, il nostro Paese deve tener conto degli
impegni assunti in sede europea sulle tematiche ambientali, che ci
ponevano degli obiettivi ambiziosi al 2012 e al 2020. Tuttavia, il
nostro Paese è riuscito a rispettare e a far meglio dell’obiettivo di
riduzione della CO2, posto a -6,5% nel 2012 rispetto ai valori rilevati
nel ’90. Nel 2012 le emissioni totali di gas serra, espresse in CO2
equivalenti, sono diminuite del 5,4% rispetto all’anno precedente e
dell’11,4% rispetto all’anno base (1990), a fronte di un impegno
istituzionale del 6,5% nel periodo 2008-2012. Le emissioni dei
principali gas serra, considerate nel Protocollo di Kyoto, sono
passate infatti da 519 milioni a 460 milioni di tonnellate di CO2
equivalenti, grazie alla riduzione prevalentemente della sola CO2 che
contribuisce all’84% del totale. Se si guarda l’andamento delle
emissioni di CO2 dagli anni novanta, si trova che l’incremento ha
seguito sostanzialmente quello dei consumi energetici, mentre nel
corso degli ultimi anni (e cioè dopo il 2008) si delinea un maggior
distacco tra le due curve, dovuto essenzialmente alla sostituzione di
combustibili a più alto contenuto di carbonio (petrolio, carbone) con il
gas naturale nella produzione di energia elettrica e nell’industria, e
all’aumento della produzione di fonti rinnovabili nel settore elettrico e
termico.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :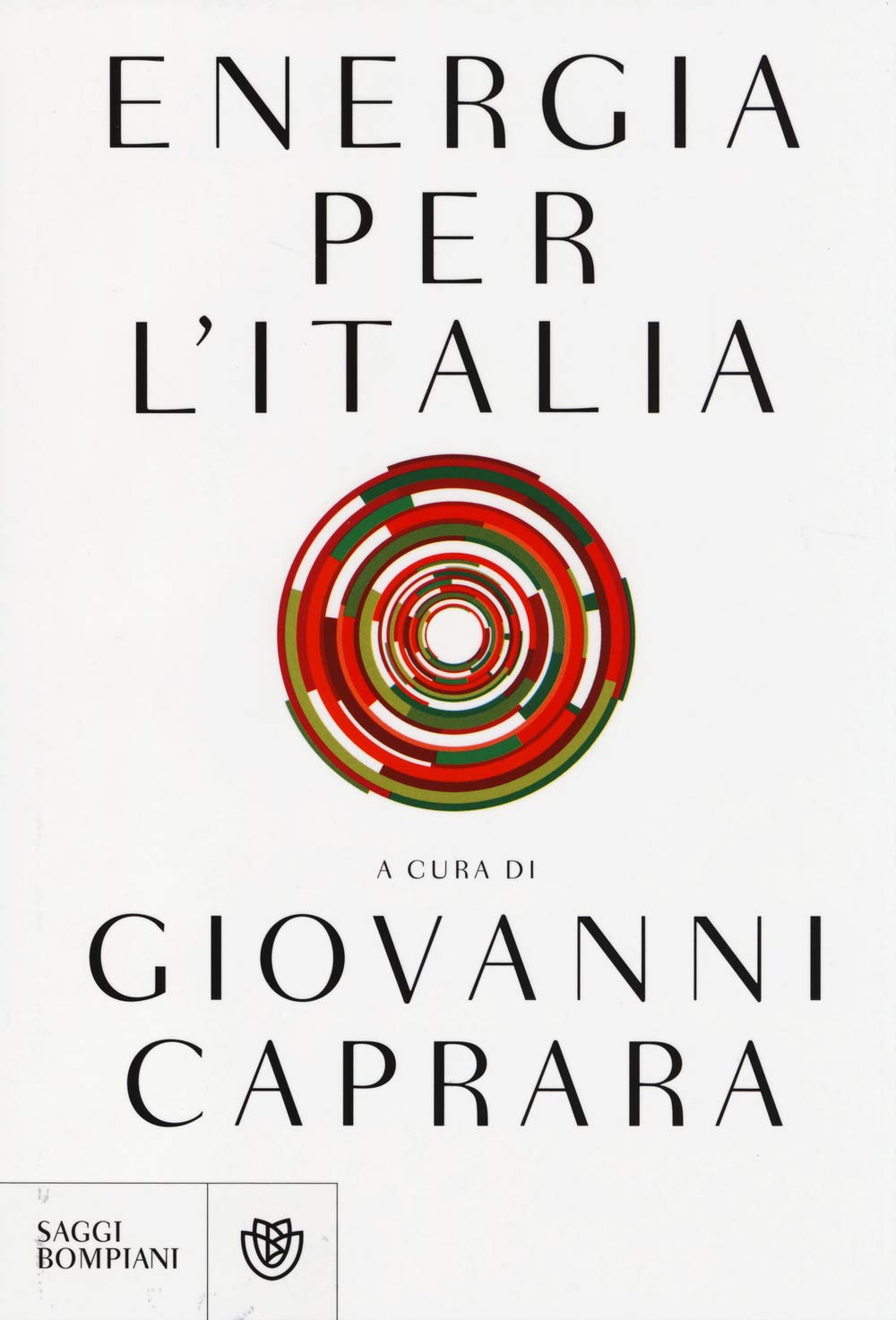





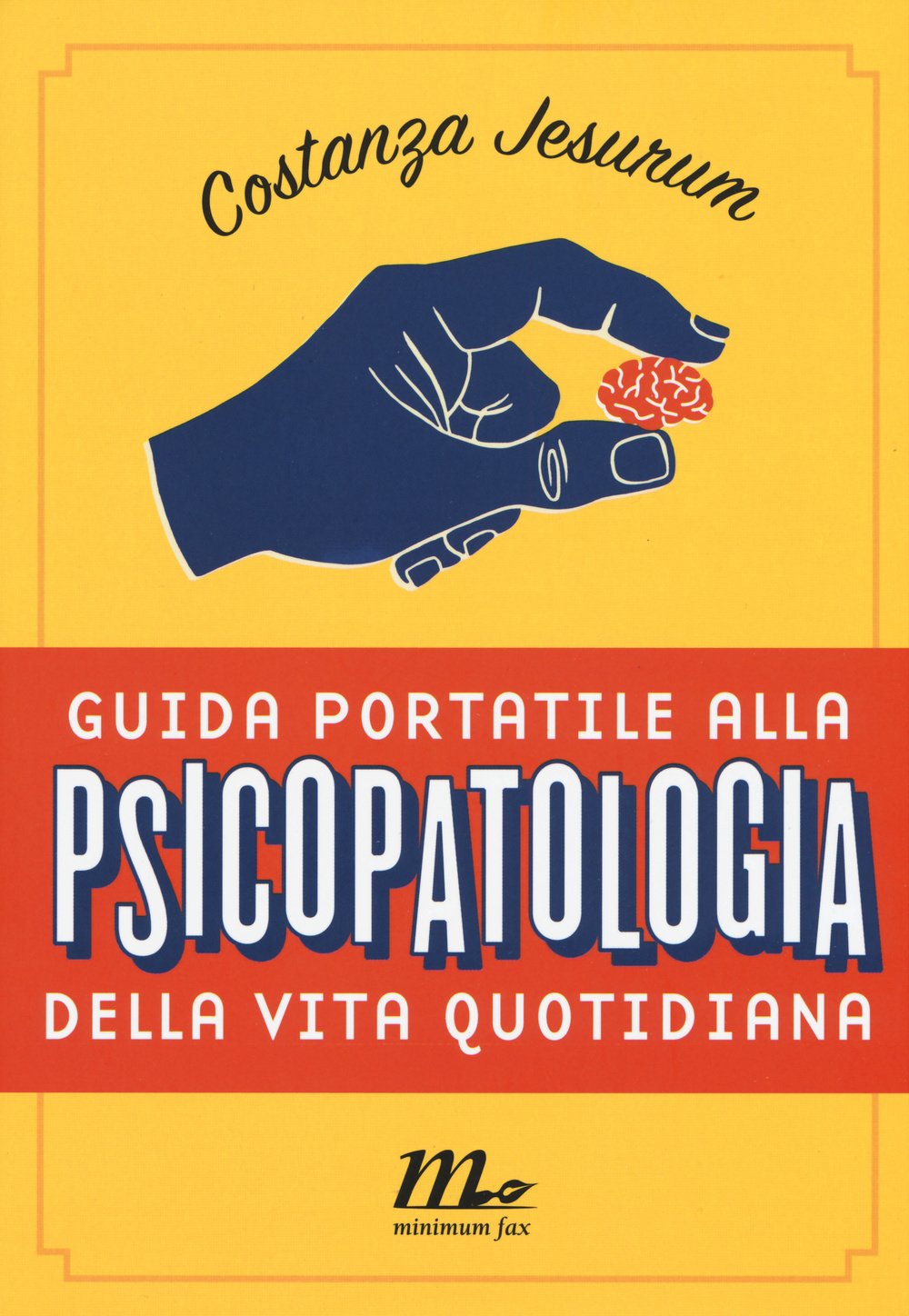
Commento all'articolo