Stella Gialla Ebrei E Pregiudizio – Donald Sassoon

SINTESI DEL LIBRO:
Nella cella di una prigione fascista a Turi, nell’Italia meridionale, nel 1930,
un anno dopo il crollo di Wall Street del 1929, otto anni dopo la marcia su
Roma di Mussolini, tre anni prima dell’avvento al potere di Hitler, il leader
del Partito comunista italiano Antonio Gramsci scrisse questa famosa
riflessione:
La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere:
in questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati. 1
Per descrivere la situazione attuale, a poco più di ottant’anni dalla sua
morte avvenuta nel 1937, sono ancora importanti queste sue parole? Non
siamo negli anni Trenta. Il fascismo non è alle porte. La democrazia liberale
vige in un numero di paesi maggiore che in qualsiasi altro periodo del
passato. La disoccupazione potrà anche essere aumentata se paragonata agli
anni d’oro del boom del dopoguerra, ma la recessione globale del 2007-2008,
per quanto seria, non è stata per nulla catastrofica come la grande depressione
del 1929, almeno finora. Gramsci spiegava che la crisi, quando il vecchio
muore e il nuovo non è ancora nato, consisteva in una «crisi di autorità»: le
classi dominanti stavano perdendo terreno, scemava il consenso che ne
sosteneva il potere e la presa ideologica sulle masse stava loro sfuggendo.
Queste masse, spiegava, non seguivano più le ideologie tradizionali, ma
stavano diventando progressivamente più ciniche e scettiche. Non credevano
più nelle élite. E questo le élite lo sapevano. Eppure il «nuovo» rimaneva
imprevedibile. Tradizionalmente i marxisti vedevano le crisi come
un’opportunità per un cambiamento radicale. Gramsci, più vicino a noi, è
meno ottimista. La congiuntura che descriveva era un «interregno» brulicante
di sintomi morbosi, non una situazione potenzialmente rivoluzionaria. Non
escludeva un ritorno al vecchio, benché sperasse (con quello che chiamava
«ottimismo della volontà», in contrasto con il «pessimismo
dell’intelligenza») che i sintomi morbosi potessero offrire un’opportunità di
progresso.
La principale caratteristica dell’interregno tra vecchio e nuovo è
l’incertezza. È come guadare un largo fiume. La vecchia sponda è alle spalle,
ma la nuova non si distingue ancora. Le correnti possono risospingerti
indietro. Potresti annegare. Incapaci di anticipare quel che succederà, si è
sopraffatti dalla paura, dall’ansia e dal panico.
Un critico di Gramsci potrebbe obiettare che, quando scrisse queste parole,
un indesiderato «nuovo» era già comparso: il fascismo italiano, di certo un
«sintomo morboso», ma anche una nuova forma di stato, che godeva di un
certo consenso popolare. Il vecchio stato liberale si era dissolto; le speranze
generate dalla Rivoluzione di ottobre si erano infrante e le attese rivoluzioni
in Occidente non si erano materializzate. In gran parte d’Europa, dopo la fine
della Grande guerra, i rivoluzionari che avevano sperato di ripetere le
conquiste dei bolscevichi erano stati completamente sconfitti. La rivoluzione
ungherese guidata da Béla Kun nel 1919 era stata repressa con la violenza. In
Austria i consigli dei soldati e dei lavoratori (i «Soviet»), guidati dai
comunisti, non riuscirono a distruggere la nascente repubblica borghese. In
Germania la rivoluzione spartachista del 1918-1919 era stata schiacciata nel
sangue dai Freikorps, un’organizzazione paramilitare di destra, sotto la
direzione del socialdemocratico Friedrich Ebert. I leader spartachisti Rosa
Luxemburg e Karl Liebknecht erano stati assassinati. In Italia l’occupazione
delle fabbriche e le proteste contadine degli anni 1919-1920, il cosiddetto
«biennio rosso», erano fallite. Mussolini fu nominato primo ministro mentre i
suoi seguaci marciavano su Roma (28 ottobre 1922). Qualche anno più tardi
s’instaurava la dittatura fascista.
Nulla di altrettanto radicale accadde in Francia, negli Stati Uniti o nel
Regno Unito. Nel 1920, in Gran Bretagna, i portuali si rifiutarono di caricare
le navi destinate a un intervento militare contro il regime bolscevico. Nel
1926 ci fu uno sciopero generale, ma durò soltanto nove giorni, mentre i
minatori continuarono le loro lotte per mesi. Poi, piegati dalla fame,
tornarono alle miniere. L’establishment britannico rimase solido come
sempre. In Francia la moneta si svalutò, i governi si alternarono, ma vi furono
poche proteste dopo l’ondata di scioperi del maggio 1920.
Nel 1921 in West Virginia, negli Stati Uniti, vi fu una delle più importanti
proteste operaie della storia americana, che coinvolse circa 10.000 minatori
armati (la battaglia di Blair Mountain). 2 L’intervento dell’esercito schiacciò
lo sciopero, uccidendo decine di minatori. Poi le cose tornarono all’abituale
violenza americana. In America pochi conoscono questo episodio che quasi
non è menzionato nei romanzi, nelle canzoni o nei film.
La sinistra era stata sconfitta ovunque, ma gran parte del «vecchio» – il
regime zarista, l’impero austro-ungarico, l’impero ottomano – era finito; e
c’era del «nuovo»: la nascita dell’Unione Sovietica, della Iugoslavia,
dell’Ungheria, dell’Austria, della Turchia.
Presto gli Stati Uniti si sarebbero imbarcati nel New Deal. In Cina il
governo nazionalista guidato da Chiang Kai-shek, dopo aver sconfitto vari
signori della guerra e ucciso, nel 1927, centinaia di comunisti (già suoi
alleati), riuscì a estendere il controllo su gran parte del paese.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
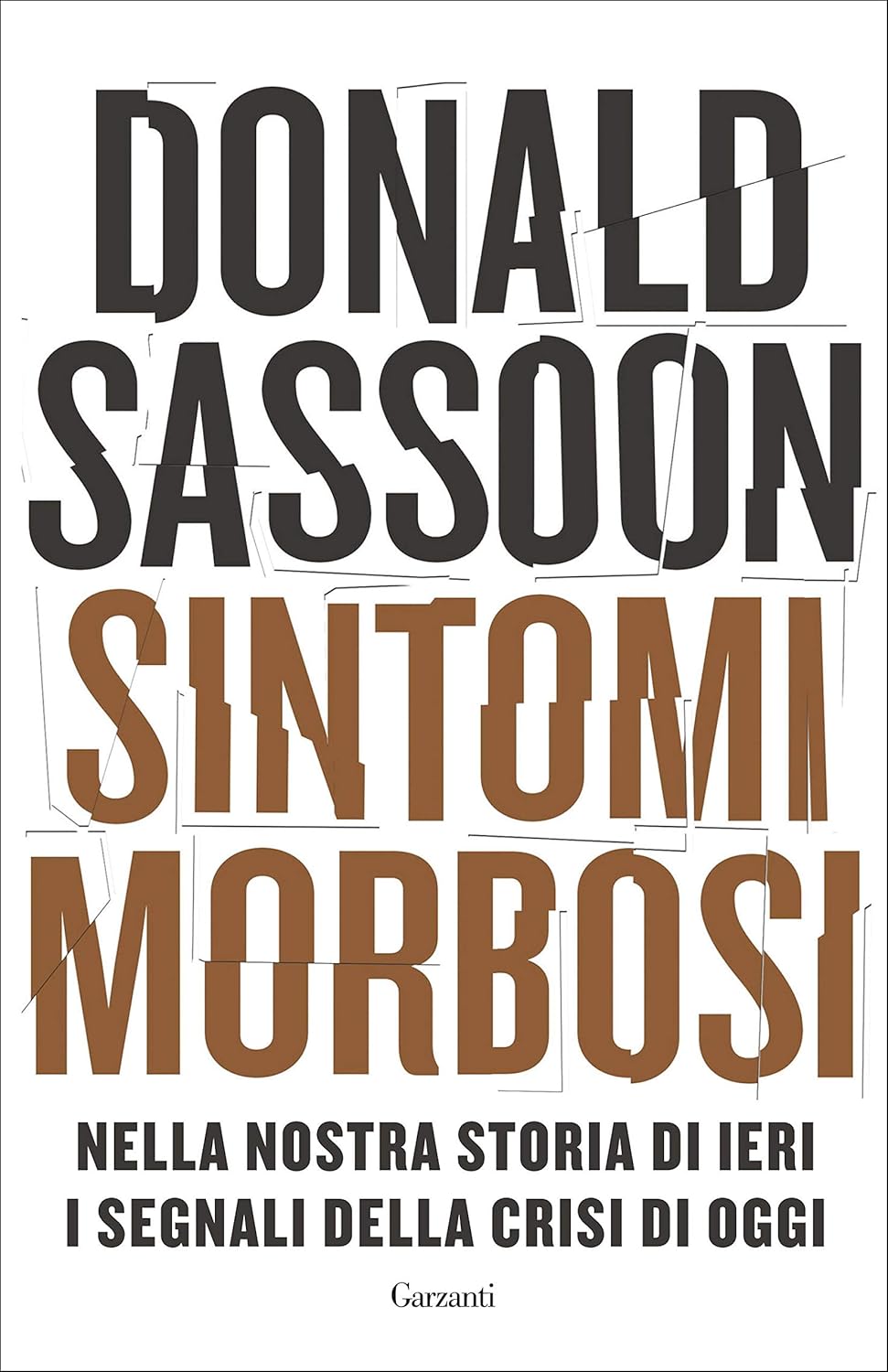






Commento all'articolo