Disobbedisco – Cinquecento giorni di rivoluzione- Fiume 1919-1920 – Giordano Bruno Guerri
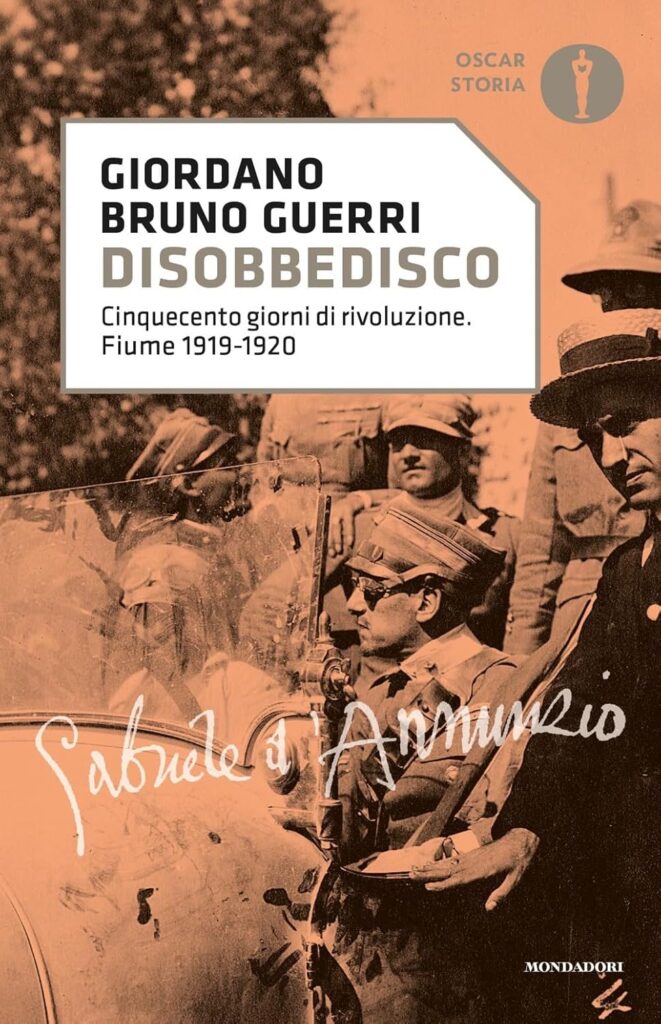
SINTESI DEL LIBRO:
Eccezione tra gli eccezionali, Keller era la vetta di un malessere diffuso
nella sua generazione, nell’intera Europa. «Ogni giorno è uguale
all’altro. Nessuna grande gioia e nessun grande dolore… è tutto così
noioso», scriveva sul diario il poeta tedesco ventenne Georg Heym.
Era il 1907 e esprimeva il malessere che accomunava i giovani europei.
Nel 1910, sebbene si trovasse nella dinamica Berlino, annotò: «Se
soltanto accadesse qualcosa… se soltanto s’innalzassero ancora una
volta le barricate». Molti ragazzi condividevano il desiderio di un
grande cataclisma che sconvolgesse la società della Belle Époque. Si
arrivò a guardare con nostalgia alle guerre degli avi, alle lotte per
l’indipendenza, alle spedizioni coloniali. Guerra e rivoluzione
apparivano come momenti mitici capaci d’infondere coraggio,
identità, cambiamento.
Il movimento futurista di Filippo Tommaso Marinetti riassunse e
rilanciò questa visione. Modernità e tecnologia dovevano innescare
una rivoluzione antropologica: la velocità delle macchine avrebbe
contagiato l’individuo e la vita della nazione, liberando finalmente la
forza primordiale e il genio creativo della comunità nazionale, la
«stirpe». E, secondo molti intellettuali formati in età risorgimentale,
non poteva esserci stirpe più forte, geniale e creativa di quella italiana.
A ridosso della guerra italo-turca e della Prima guerra mondiale, le
parole d’ordine del futurismo eccitarono l’amore per la guerra,
definita «sola igiene del mondo» e fecondo «gesto distruttore dei
libertari», contagiando un popolo. Erano concetti che animavano
anche l’Associazione Nazionalista fondata da Enrico Corradini,
sostenitore di uno Stato autoritario ma dinamico, governato dai
«produttori» e lanciato verso la competizione tra i popoli. Lo sviluppo
dell’Italia si sarebbe raggiunto abbattendo la vecchia classe politica e
mobilitando il paese in «una serie di grandi guerre fortunate».
Futuristi e nazionalisti non dovettero attendere a lungo: il 29
settembre del 1911 le truppe italiane sbarcarono in Libia per
strapparla all’Impero Ottomano assieme al Dodecaneso. Il conflitto
era auspicato da molti borghesi e dai rivoluzionari attirati dal mito di
una grande nazione «proletaria» – reso popolare da Giovanni Pascoli– che avrebbe riscattato debolezze secolari con le armi.
Comprendere questo sentimento diffuso aiuta a capire l’entusiasmo– oggi inconcepibile – che animò milioni di europei nell’estate del
1914, allo scoppio della Prima guerra mondiale. In Italia il mito della
rivolta generazionale e della conquista accompagnò la lotta per
l’intervento, e nel 1919 provocò la sollevazione che doveva culminare
con la rivoluzione di Fiume.
Il primo atto di guerra italiano fu compiuto addirittura quando
l’Italia non era ancora entrata nel conflitto. Nel 1914 duemila giovani
passarono il confine per arruolarsi nella Legione straniera francese; si
proclamavano diretti continuatori dell’Impresa dei Mille, e del resto i
loro capi erano nipoti dell’Eroe dei due mondi, Peppino, Bruno e
Costante Garibaldi. Anche un sedicenne bellissimo e speciale fuggì da
casa e raggiunse la legione garibaldina delle Argonne, stanziata a
Avignone, nel palazzo dei Papi. I garibaldini lo accolsero con
entusiasmo, vista l’età e il nome tedesco: Kurt Suckert, non ancora
Curzio Malaparte. Pallido, gracile e slanciato, elegante nei pantaloni
rossi, la giacca blu corta con bottoni d’oro e la cintura celeste
dell’uniforme, fu presto rimandato – o tornò – in Italia per finire
l’anno scolastico, da bravo ragazzo qual era: frequentava il Cicognini,
il collegio diventato celebre perché lì aveva studiato Gabriele
d’Annunzio. Ecco alcuni versi di una poesia che in quegli anni Kurt
dedicò ai legionari garibaldini:
Chi di voi non si sente,
oggi, simile ai falchi
e all’aquile rapaci?
[…]
Chi di voi non ha sete
di vento e di tempesta?
In trecento, compresi Bruno e Costante, morirono nelle battaglie del
Bois de Bolante e nelle Argonne. D’Annunzio scrisse: «Della prodezza
garibaldina l’azione compiuta dai legionari italiani nella foresta epica
dell’Argonna ha tutte le qualità tradizionali e quasi direi leggendarie:
la temerità giovenile, la rapidità fulminea, l’amore disperato del “ferro
freddo”, la bellezza istintiva del gesto nella morte, e quella specie di
ebbrezza lirica che segna il ritmo sapiente degli assalti». Era certo che
la fusione tra giovinezza, idealismo e sacrificio fosse l’inizio della
rinascita italiana.
La febbre del 1915
Prima del conflitto, l’Italia esigeva le terre «irredente» ancora sotto il
dominio austro-ungarico: il Trentino, la Venezia Giulia e la costa
orientale dell’Adriatico. Però – a differenza delle altre nazioni, che
entrarono in guerra rapidamente con il sostegno compatto della
popolazione – nel nostro paese se ne discusse per oltre dieci mesi in
Parlamento, sulla stampa e nelle piazze. L’Italia doveva decidere se
restare nella Triplice Alleanza con Germania e Austria-Ungheria o se
schierarsi con la Triplice Intesa anglo-franco-russa: il 26 aprile 1915
sottoscrisse a Londra un trattato, destinato a rimanere segreto, che in
caso di vittoria le garantiva Trento, il Trentino, il Tirolo meridionale
fino al Brennero, Trieste, l’Istria fino al golfo del Carnaro e la
Dalmazia settentrionale. Inoltre venivano promessi il porto di Valona
e il protettorato sull’Albania, la piena sovranità sulle isole del
Dodecaneso, il bacino di Adalia ai danni della futura Turchia e altri
compensi coloniali da definire in un secondo momento. Il 3 maggio il
capo del governo Antonio Salandra dichiarò di ritenersi libero da ogni
vincolo con le potenze della Triplice Alleanza, ma ciò non bastava a
rendere sicura l’entrata in guerra e a giustificarla di fronte alla
popolazione.
Mentre i partiti socialisti e progressisti d’Europa sposarono le
rispettive cause nazionali, il Partito socialista italiano si proclamò
fedele ai principi della Seconda Internazionale: i proletari dovevano
rifiutare l’inganno patriottico che li voleva gli uni contro gli altri. La
Chiesa poi, oltre a condannare fin dal principio l’«inutile strage»,
come l’avrebbe definita Benedetto XV, non avrebbe mai appoggiato
una guerra dell’Italia risorgimentale e laica – l’Italia di Porta Pia
contro l’Impero degli Asburgo, baluardo del cattolicesimo romano.
Anche il Parlamento era in maggioranza favorevole alla neutralità.
Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio per quattro mandati e forte
dell’appoggio di trecento deputati, proponeva di proseguire le
trattative con l’Austria: era convinto che l’Italia non avesse i mezzi
finanziari e la preparazione militare necessari per affrontare un
conflitto che prevedeva lungo e logorante. Era certo che si sarebbe
ottenuto molto anche senza combattere.
Sul fronte opposto e sempre più numeroso, oltre ai nazionalisti
l’idea che la lotta contro l’Austria-Ungheria affermerà una nuova
Europa di popoli liberi conquista anche carismatici sindacalisti
rivoluzionari e socialisti: alcuni lasciano il partito provocando una
scissione decisiva nella storia, non soltanto quella della sinistra:
Leonida Bissolati, fondatore del Partito socialista riformista, e il
direttore dell’«Avanti!», Benito Mussolini.
D’Annunzio voleva già dal 1914 che l’Italia intervenisse al fianco
della Francia, in nome di un «patto latino», contro l’imperialismo
germanico. Patriota e libertario, cultore del passato e celebratore della
modernità, seppe cogliere e comprendere la profonda ansia di
rinnovamento della nuova generazione. Sarà il protagonista della
campagna per l’intervento, il supereroe della guerra, il Comandante
dell’ultima avventura romantica e della prima rivolta generazionale
del Novecento.
Il Vate
Nel 1914 Gabriele – ammirato o deprecato – è uno degli italiani più
celebri nel mondo. Ha 51 anni e da trenta ha scalato le vette della
società. Ne aveva 16 quando pubblicò con successo la sua prima
raccolta poetica; sapendo che la seconda non avrebbe avuto altrettanta
attenzione, a volume appena stampato fece circolare la voce che la
giovane promessa della poesia aveva perso la vita in un incidente a
cavallo: fioccarono elogi e onori, che i critici credevano postumi.
L’anno dopo, conclusi gli studi al Cicognini, si iscrisse all’università, a
Roma, per non frequentare neppure una lezione. Non ne ha bisogno. I
giornali si contendono i suoi articoli, amabili e sensuali; Gabriele
scrive magistralmente di letteratura, musica, pittura, filosofia, arte,
moda, mondanità. Propone al pubblico uno sguardo diverso da quello
neoclassico o romantico della Roma di Goethe, Stendhal,
Chateaubriand e Carducci. Racconta la Roma che oggi chiamiamo
dannunziana, in cui il godimento di pochi diventa un simbolo di
modernità spregiudicata. Lo stesso affresco che passerà, immutabile,
da d’Annunzio a Moravia, da Fellini a Sorrentino.
Patrizi e intellettuali gareggiano per averlo nella loro cerchia, il
piccolo provinciale pescarese è diventato un dandy e presto sarà
arbiter elegantiarum. Il bello e il lusso gli sono necessari «come l’aria
che respiro», dunque impazza nei palazzi della nobiltà, e a 21 anni
sposa la duchessina Maria Hardouin Altemps di Gallese. Il padre,
sdegnato perché la figlia ha scelto quel poetastro borghese, non li
vorrà più vedere: quarant’anni dopo d’Annunzio, divenuto principe,
eleverà a principessa la duchessina.
Più che del rango, il suocero avrebbe dovuto preoccuparsi della
passione per le donne che animava il genero. Per lui, senza eros non
c’è nemmeno poesia, e in un’intervista del 1909 dichiara «la sensualità
condizione necessaria per l’arte dell’artista». I suoi molti amori, dalle
passioni leggendarie agli incontri più fugaci, ne edificano il mito di
amante favoloso. Donne colte, nobili, celebri persero la testa per lui
rovinando famiglie e carriere, spesso mantenendo la loro dedizione
anche a distanza di anni. Al centro del suo incantesimo ci sono artifici
retorici che ritorneranno nella seduzione delle masse. Isadora Duncan
scrisse che d’Annunzio era «un così grande amante che poteva
trasformare la donna più ordinaria e darle per un momento
l’apparenza di essere celeste». Ha sempre la spudoratezza di
promettersi anima e corpo, sa innalzare la donna sedotta a divinità
senza confronto, davanti a loro si fa specchio di quel che desiderano
essere.
È alle «leggitrici» che pensa quando scrive il primo romanzo,
intuendo che il suo pubblico sarà soprattutto femminile, sebbene – o
forse proprio per questo – plasmerà pure l’immaginario dei
contemporanei maschi. Il piacere esce nel 1889, quando ha 26 anni: il
successo è immenso e il libro, subito tradotto, viene apprezzato da
Hofmannsthal, James, Musil, Proust. È l’inizio di una serie di romanzi
che saranno alla base della sua fama. «L’Italia oggi è ascoltata»,
dichiarerà André Gide, perché d’Annunzio ha resuscitato la
letteratura italiana con la «moda così bella dei [suoi] romanzi».
L’innocente, Trionfo della morte, Le vergini delle rocce, Giovanni
Episcopo, Il fuoco, Forse che sì forse che no fondono autobiografia e
finzione, perizia narrativa e trattazione filosofica, schiudono dimore e
salotti patrizi dove fioriscono amori drammatici e tragedie
peccaminose. «Io non sono uno scrittore da scrittoio», precisa nel 1907
al suo editore. «Sono un artefice di vita assidua, congiunto alla intera
vita, accordato alla vita universa.» Mentre compone il ritratto
impietoso della prima borghesia italiana, con altrettanta sensibilità
antropologica esplora il mondo magico dell’Abruzzo contadino:
nascono così Le novelle della Pescara, La figlia di Iorio, La fiaccola sotto il
moggio.
«Bisogna che il mondo si persuada ch’io sono capace di tutto»,
aveva già dichiarato a Emilio Treves nel 1897. Nessuno tuttavia
poteva immaginare che – ultracinquantenne – sarebbe diventato un
eroe di guerra. Radici e segnali di ciò che sarà, a dire il vero, non
mancano. A 14 anni scrive a un insegnante, del quale di lì a poco
sedurrà la figlia: «Voi sapete quanto amo la nostra Italia, voi sapete
che darei tutto per essa, e, nel 1877, sapete anche che questi principi
me li avete infusi voi e mio padre»; poi, con un fraseggio da Cuore che
precede di nove anni De Amicis: «La mia prima missione su questa
terra è di insegnare al popolo ad amare il proprio paese e ad essere
onesti cittadini, la seconda è odiare a morte i nemici d’Italia e di
combatterli sempre. Oh se tutti gl’Italiani fossero come me, avrebbero
a pagar ben caro tutto il sangue che ci hanno levato colle viltà e coi
tradimenti».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :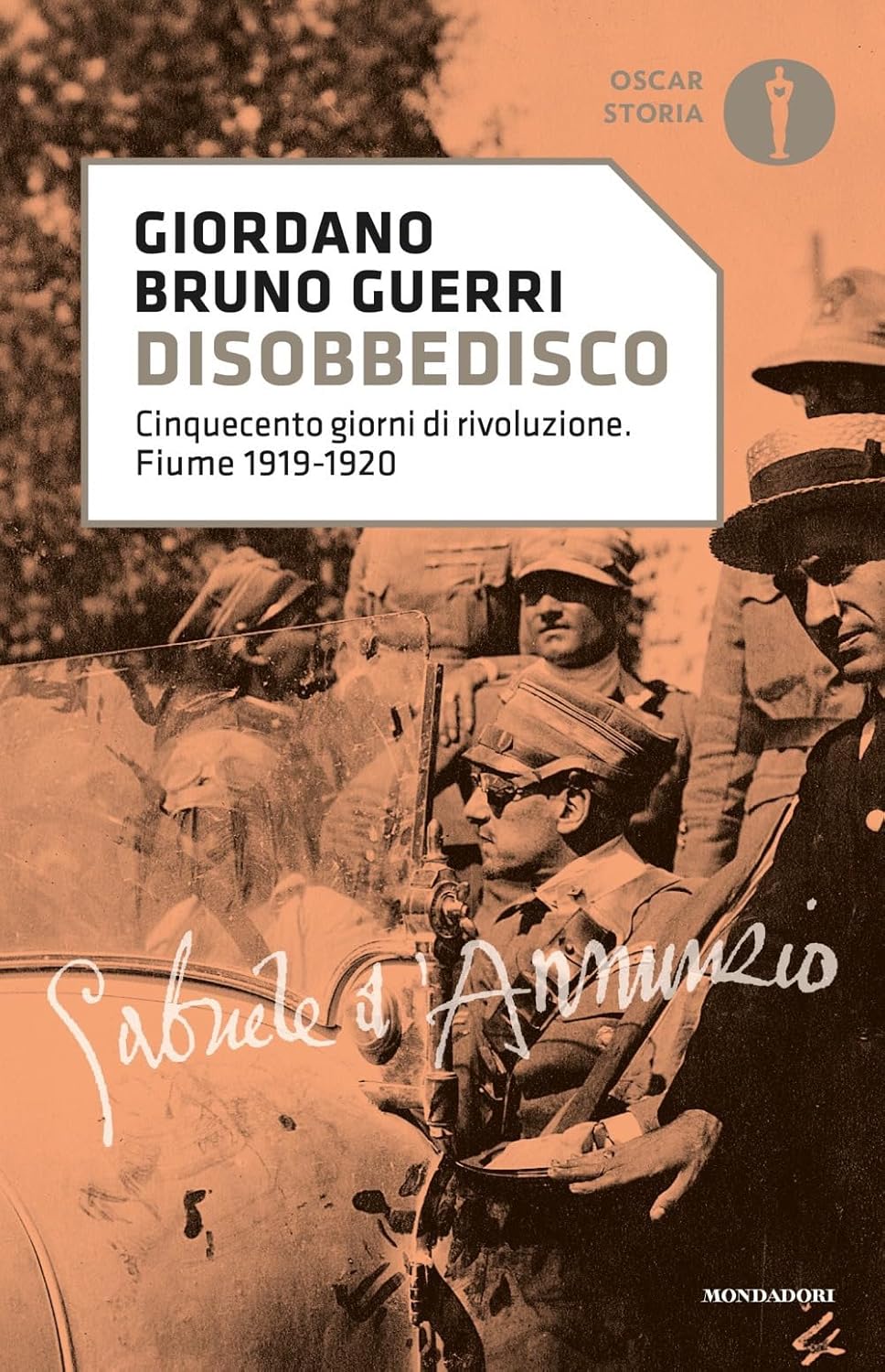






Commento all'articolo