Democratizzare la cura / Curare la democrazia – Giorgia Serughetti
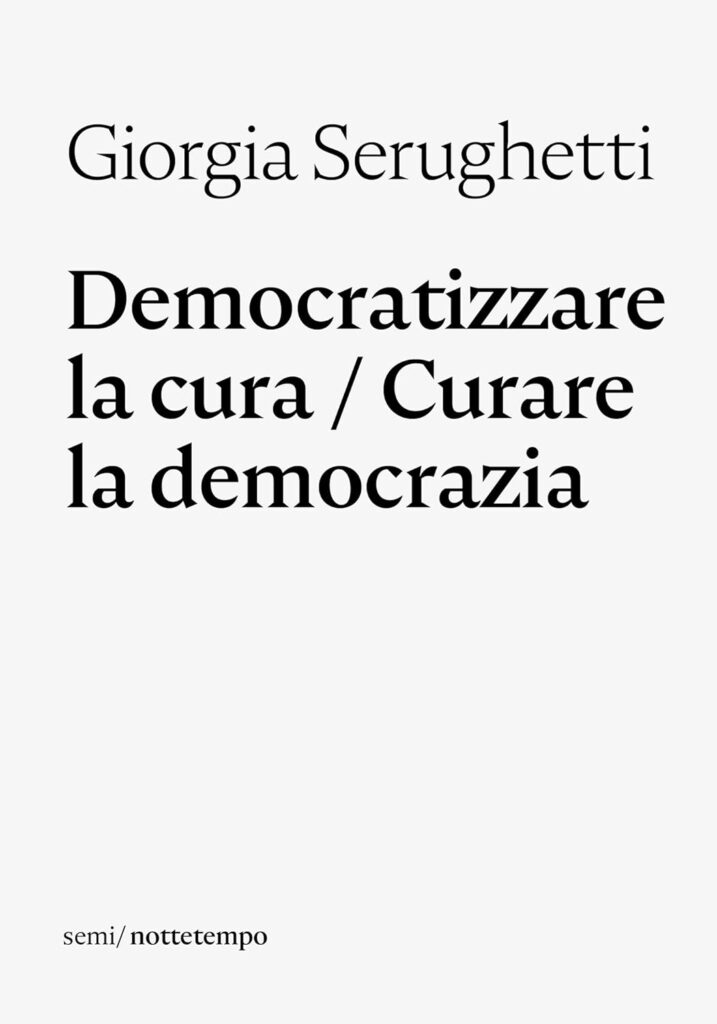
SINTESI DEL LIBRO:
Mentre scrivo queste pagine, la protesta #BlackLives-Matter, dopo
l’ultimo episodio di brutalità della polizia verso un cittadino
afroamericano, George Floyd, morto soffocato nel violento fermo
effettuato da un agente di Minneapolis, infiamma gli Stati Uniti. “I
can’t breathe”, non riesco a respirare, aveva ripetuto l’uomo. Non
riuscire a respirare: questo denunciano le proteste di minoranze
oppresse da secoli di razzismo che continuano a provocare
carcerazioni di massa, abusi, povertà.
Lo slogan I can’t breathe è stampato ed esibito dai manifestanti
sulle mascherine anti-Coronavirus. Perché mentre questo avviene,
gli Stati Uniti e il mondo intero, Italia inclusa, continuano a fare i conti
con un virus ad alta contagiosità e letalità, il Covid-19, che colpisce
la respirazione e ha già causato centinaia di migliaia di morti. Le
misure anti-contagio hanno inoltre fermato gran parte del pianeta,
costringendo le persone nelle case, chiudendo attività economiche,
e provocando una crisi occupazionale e sociale dagli effetti ancora
incalcolabili. A farne le spese, saranno in ogni parte del mondo le
persone piú colpite dalle diseguaglianze di genere, classe, razza,
età, abilità.
Se le vite umane, le vite di tutte e tutti, contano, la sfida epocale
che le nostre democrazie hanno di fronte è divenire capaci di
rispondere al bisogno delle persone di respirare: di vivere,
innanzitutto, ma anche di condurre una vita buona. E se vogliamo
che il tempo drammatico che stiamo affrontando, a partire
dall’esperienza fisica della malattia, del lutto, della paura, diventi
occasione di conoscenza e capacità di azione trasformativa,
occorrerà costruire un nuovo lessico per la politica.
Io credo che in questo lessico debba trovare uno spazio centrale
la parola “cura”, in un significato esteso e rinnovato. La pandemia di
Covid-19 ha messo a nudo a livello globale un gigantesco, diffuso
bisogno di cura. Un bisogno al quale nessun sistema pubblico, in
nessuna parte del mondo, si è trovato preparato a rispondere. Ora,
nella fase drammatica di ricostruzione dopo-Covid, le sirene del
ritorno alla “normalità” rischiano di riproporre o esasperare i problemi
venuti allo scoperto.
Questo quindi mi propongo: indicare una via per ricostruire le
nostre società come società che curano. Voglio sostenere che
democratizzare le attività di cura e l’accesso alla cura rappresenta la
condizione essenziale per realizzare in senso sostanziale, e non
solo formale, l’eguale libertà di cittadine e cittadini. Per questo, come
dirò, la cura deve essere posta al cuore del progetto politico che
chiamiamo democrazia.
Il peso dei corpi
Il
tempo della pandemia è stato un tempo di sovversione delle
priorità a livello pubblico e privato, un tempo di prevalenza del
collettivo sull’individuale, e del materiale sull’immateriale. Nel lungo
lockdown a cui ci hanno costretto le misure di prevenzione del
contagio, gran parte della popolazione ha sperimentato l’assenza di
fisicità e contatti, e la migrazione di molte attività su piattaforme
digitali. Eppure, l’epidemia ha avuto anche l’effetto opposto di
trascinare i corpi reali, in carne e ossa, fuori dal cono d’ombra a cui
parevano destinati dai processi socioeconomici di smaterializzazione
in corso negli ultimi decenni.
Fenomeni come l’informatizzazione, la finanziarizzazione, il trionfo
della produzione immateriale hanno fortemente ridotto, nella
percezione pubblica, il peso dei corpi al lavoro, mentre i lavori e le
attività relative al corpo, alla cura, al sostentamento e all’educazione
sono andati sempre piú incontro al deprezzamento sociale e alla
marginalizzazione culturale. Questo, anche senza considerare il
lavoro riproduttivo non retribuito, che non ha mai goduto della
necessaria considerazione. Nel generale sovvertimento delle priorità
causato dall’emergenza sanitaria, è invece divenuto chiaro che
senza corpi in salute e al lavoro, in casa o negli ospedali, in fabbrica
o nei campi, negli esercizi commerciali o nella ristorazione, nei teatri
o nelle tipografie, anche le produzioni immateriali perdono quasi ogni
valore.
Ciò che è accaduto è che in ogni paese in cui la principale misura
anti-epidemica disposta è stata quella del distanziamento fisico, in
cui gran parte della popolazione è stata colpita da un divieto quasi
assoluto di movimento, le attività piú svalutate e malpagate, quelle
che tengono letteralmente in vita le persone – non solo elargendo
cure dirette, ma anche, per esempio, producendo beni di prima
necessità, o recapitando il necessario a domicilio – sono diventate la
principale protezione contro la morte. “Essenziali”, sono state
definite: la dicitura forse piú idonea a ribaltare la visione di lavoratrici
e lavoratori come “risorse”, tra le altre, funzionali alla produzione di
profitto. Senza queste donne e questi uomini non c’è produzione né
ci sono servizi, non c’è sopravvivenza della società umana.
Può davvero il dopo-Covid tornare a ignorare i corpi nella loro
pesante e vulnerabile fisicità? Può chiudere gli occhi di fronte alle
condizioni disumane in cui lavora chi ha permesso ai raccolti agricoli
di arrivare nelle case? Può accettare il supersfruttamento che
subiscono categorie come i lavoratori della logistica e delle
piattaforme? Può continuare a negare pieni diritti alle lavoratrici
domestiche e alle assistenti familiari – spesso migranti, spesso
irregolari,
quasi
sempre sottopagate – che suppliscono
incessantemente alle carenze del sistema di welfare per minori e
anziani?
Certo che può, direte. Del resto, nel corso dell’epidemia le
categorie qui elencate sono state raramente ricordate nel discorso
pubblico. Molte lavoratrici e molti lavoratori hanno operato nelle
peggiori condizioni, con orari impossibili e senza adeguati dispositivi
di
protezione individuale. Molti sono rimasti esclusi per
“dimenticanza” da misure emergenziali come i divieti di
licenziamento e le indennità economiche. Molti non potranno
accedere alla regolarizzazione per stranieri senza permesso di
soggiorno. Non è quindi ragionevole guardare al prossimo futuro con
un facile ottimismo.
Ci sono del resto altri aspetti emersi nella crisi che hanno a che
fare con i corpi e i loro bisogni di cura, e che rischiano di essere
rapidamente occultati da un discorso politico ansioso di celebrare la
ripartenza. Penso agli effetti del costante de-finanziamento del
sistema sanitario nazionale, che si sono palesati nell’incapacità di
risposta all’epidemia; allo smantellamento dei presidi di salute
territoriale;
ai
rischi
evidenti
che derivano dal crescente
sbilanciamento tra pubblico e privato, quando una crisi sanitaria
richiede il dispiegamento di tutte le strutture, risorse e attrezzature di
cui dispone lo Stato.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :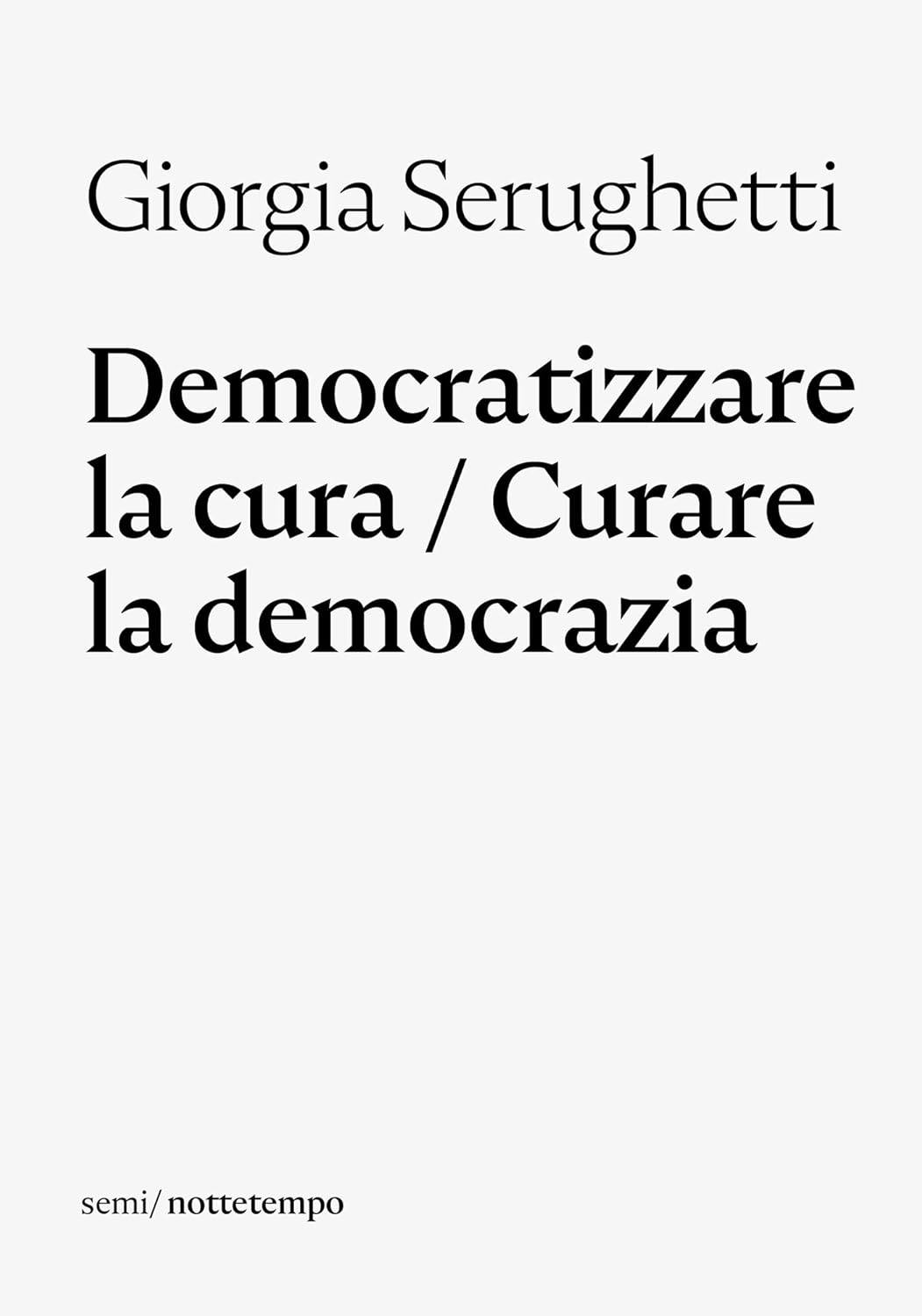






Commento all'articolo