Cosmo più servizi – Divagazioni su artisti, diorami, cimiteri e vecchie zie rimaste signorine – Antonio Riccardi
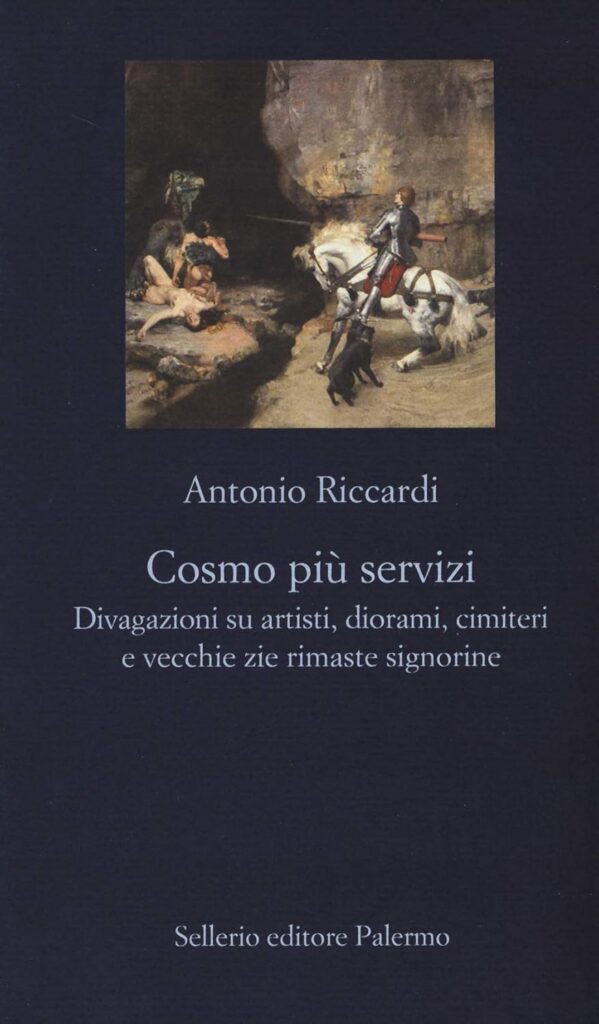
SINTESI DEL LIBRO:
L’inquietudine, importa cosa lascia e non perché viene. Ognuno in
cuor suo ha un’idea più o meno precisa del perché sia inquieto; e
conosce, o può conoscere dotandosi di strumenti, la fisionomia dei
propri fantasmi, anche dei più feroci. Non può annichilirli forse, ma
tenerli alla catena sì. Il campo dello scontro è tutto interno, nascosto
nella cassa del costato, tra le fibre muscolari, alla radice dei nervi o
chissà dove.
Quel che si vede è altro. La sensazione dell’inquietudine – per molti
un’autentica condanna –, quella che non molla mai, che non dà pace
e ci fa misurare la distanza tra i nostri desideri e la volontà di
realizzarli, ci forza a compiere delle azioni: una fuga, un atto creativo,
perfino un crimine. Ci rende visibili e allo stesso tempo deboli,
giudicabili. Così, quando siamo alla luce del sole e per un attimo
sentiamo placarsi il morso che ci ha spinto a fare qualcosa o ad
andare via, scopriamo di essere nudi davanti a tutti. La verità di quel
che abbiamo fatto è improvvisamente misurabile, ha i contorni di una
cosa, la consistenza di un’azione.
Ecco una piccola azione. Cattabiano, Appennini parmensi, un giorno
di giugno del 1886. Don Antonio Riccardi, vecchio sacerdote devoto e
tormentato, marca le voci inquietudine e inquieto sul Vocabolario
della lingua italiana del Tommaseo. «Molestia che opprime l’animo
quando è agitato da pensieri tristi, travaglio o passione», dice la
prima voce; «senza quiete, tribolato», dice la seconda. Don Antonio
sta morendo, manca poco. Lo sente e forse lo sa.
Molti anni prima, giovane e brillante seminarista destinato ad alti uffici
ecclesiastici, sul margine di un passo biblico aveva scritto: «Dio è
Spirito, l’anima tribolazione». Tribolata, ovvero inquieta.
Trascorsa una vita intera, sfumati gli onori, masticato dalle occasioni
in cui gli si è presentato il destino, ricorda a se stesso la verità, la sua
indole, la sua condanna. Sul limite della vita in un tratto di matita lega
la fine con l’inizio, la verità originaria con l’ultima consolazione e
mette in pari davvero il conto dei suoi giorni. D’altra parte, sa bene
che solo nella vita degli angeli non accade nulla. Solo gli angeli non
conoscono tribolazioni.
Forse niente va perso nella trasmissione genetica e da qualche parte
devo avere anch’io un frammento della tribolazione che ha segnato
l’esistenza di don Antonio, prozio di mio bisnonno paterno.
Una leggenda famigliare, solo in parte provata da documenti certi, lo
vuole verso il 1840 precettore e guida spirituale sugli Appennini, a
Neviano, presso una famiglia di possidenti terrieri; gente ricca in una
terra povera, fatta di pietre e di argilla. Essere ricchi lì vuol dire non
esserlo quasi più dove la collina va a zero e comincia la pianura,
pochi chilometri prima della città, prima che si apra la distesa verde
della bassa. In pianura chi ha la terra è ricco davvero e forse vede le
cose che cambiano da più vicino.
Don Antonio viene da una famiglia molto simile a quella dove presta
servizio: le stesse abitudini appartate, la stessa devozione venata di
cupezza, la stessa propensione all’originalità del carattere nei suoi
membri, nel capofamiglia specialmente. E poi i poderi, i contadini
stanziali e quelli stagionali; e ancora le bestie, i carri e gli arnesi, la
roba. Tutto uguale, chissà da quanto tempo, da una parte e dall’altra;
tutto a poca distanza in linea d’aria, ma lontano se ti devi mettere in
viaggio con il calesse nel su e giù delle colline, che qui cominciano a
diventare più aspre, meno rassicuranti. Per lui stare lassù è anche
come stare a casa, almeno un po’.
Don Antonio ha già compiuto trent’anni e la sua vita di sacerdote non
è sempre stata tranquilla. La Curia, a Parma, ha deciso di
allontanarlo dalla città, dal centro delle cose, forse per via del suo
temperamento inquieto, forse per via delle sue simpatie politiche, che
non nasconde e che lo porteranno, di lì a non molto, ad un sincero
patriottismo filo garibaldino.
A Neviano è lontano da tutto. Qui lui svolge un compito modesto per
le sue ambizioni e per quanto ha mostrato di poter fare. Nelle lettere
a casa, al padre Pier Giovanni e al fratello Domenico, non se ne
lamenta e parla d’altro. Scrive poesie, specie in occasione di
compleanni, matrimoni, lutti, nel solco dell’amato Metastasio,
irrimediabilmente fuori moda e stagione a leggerle in prospettiva. Di
tanto in tanto però, tra i versi sempre prevedibili, di ‘repertorio’ per
forma e per carattere, affiora una traccia debole ma vera di instabilità,
di tribolazione. Ha sempre scritto poesie, sin dagli anni del seminario,
e ne scriverà fino alla fine, come se la poesia fosse lo strumento
marcatore della propria sensibilità.
Sembra che la sua vita sia tutta qui: modesti uffici di sacerdozio,
piccole incombenze pratiche, buone e doverose letture. Invece, ad un
certo punto, non sappiamo quando, la sua vita gira nel buio.
«Le acque furtive sono dolci, il pane preso di nascosto è gustoso»,
segna sul libro biblico dei Proverbi. Lui è il precettore, lei la sua
allieva. I due scivolano in un amore nutrito di vergogna e di
pentimento. Lei forse aspetta un figlio da lui. Antonio certamente
maledice il proprio desiderio di libertà, l’insofferenza verso le regole,
la volontà inspiegabilmente debole. Lei è troppo giovane, lui troppo
sinceramente devoto. Entrambi, pur se in modo diverso, sono facile
preda del rimorso e dell’infelicità.
Quello che è successo dopo, nessuno lo ha mai saputo con
sicurezza. Di certo si sa che lei muore prima di partorire, cadendo da
una finestra.
Credo che una delle prime determinazioni filosofiche del termine
inquietudine si trovi in Locke (Uneasiness), come disagio suscitato
nell’individuo da un bisogno non appagato; e anche come movente
cruciale degli atti di volontà. In una pagina del Saggio sull’intelletto
umano lucidamente argomenta: «che cosa determina la volontà nei
riguardi delle nostre azioni? A pensarci bene, sono portato a credere
che non sia, come si suppone generalmente, il maggior bene che si
ha in vista; bensì un qualche disagio (e per lo più si tratta di quello più
pressante) dal quale un uomo è afflitto. Questo è ciò che di volta in
volta determina la volontà e ci muove verso le azioni che compiamo.
Possiamo chiamare questo disagio, così com’è, desiderio, che è un
disagio dello spirito per il bisogno di un bene assente».
Da qui la nota passa a Leibniz. Nel suo contrappunto al Saggio
lockiano, Leibniz, per bocca di Teofilo, il personaggio cui affida le
proprie teorie nel dialogo con Filalete, specifica che «nel desiderio in
se stesso c’è una disposizione o preparazione al dolore più che un
dolore effettivo»; e che l’inquietudine deriva dalla serie di
impercettibili stimoli che ci tengono continuamente in sospeso,
«determinazioni confuse per modo che spesso non sappiamo ciò che
ci manca, mentre nelle inclinazioni e nelle passioni sappiamo almeno
ciò che vogliamo, benché le percezioni confuse entrino anche nel loro
modo di agire e le passioni stesse provochino anche inquietudine e
insoddisfazione». Poco più avanti, con straordinaria presa retorica,
dice: «In tedesco si dice Unruhe, cioè inquietudine, il bilanciere
dell’orologio. Lo stesso può dirsi del nostro corpo, che non può
trovarsi del tutto a suo agio, perché anche se ciò si verificasse, subito
una nuova impressione degli oggetti, un piccolo mutamento negli
organi, nei vasi o nelle viscere, turberebbe di nuovo l’equilibrio,
obbligandolo ad un qualche piccolo sforzo per rimettersi nella
migliore condizione possibile»; e ciò porta ad una continua lotta in noi
stessi, all’inquietudine degli ‘orologi’ che siamo.
Il
termine così individuato passa poi nel Traité des sensations di
Condillac – che ne accentua la drammaticità in quanto tormento – e
si dispone a diventare uno snodo cruciale della sensibilità moderna,
una consuetudine del nostro intendere e sentire quotidiano.
Ma don Antonio non è un filosofo e non sa nulla di tutto questo. Per
lui l’inquietudine è tutt’al più uno stato d’animo; non è una condizione
rilevante dello spirito, forse nemmeno esiste. La vita esige sentimenti
più netti. Il rimorso, la paura, la disperazione, questo sì che è vero,
perfino la malinconia è vera. L’inquietudine invece...
Egli pensa, come si conviene al suo ruolo e per quanto ha appreso
durante la sua formazione intellettuale, che il mondo sia il terreno di
scontro tra il Bene e il Male, ovunque, in ogni angolo, nell’aria tra le
cose, nel cuore delle persone; ed è sicuro che il compito di un buon
cristiano, d’un sacerdote prima degli altri, sia quello di arginare il Male
con assoluta determinazione, secondo le regole della precettistica
devozionale. Legge e medita, impara da Loyola, da Segneri, da Carlo
Borromeo e da Vincenzo de’ Paoli, ma soprattutto da Alfonso de’
Liguori, il teologo fondatore della Congregazione dei Redentoristi, del
quale legge e rilegge la cospicua e cupissima produzione, a giudicare
dalla stratificazione delle glosse sui volumi della sua biblioteca che
sono giunti fino a me. Tra questi libri c’è l’Apparecchio alla morte, una
pressante esortazione alla conversione in vista dell’ultimo giorno sulla
terra...
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :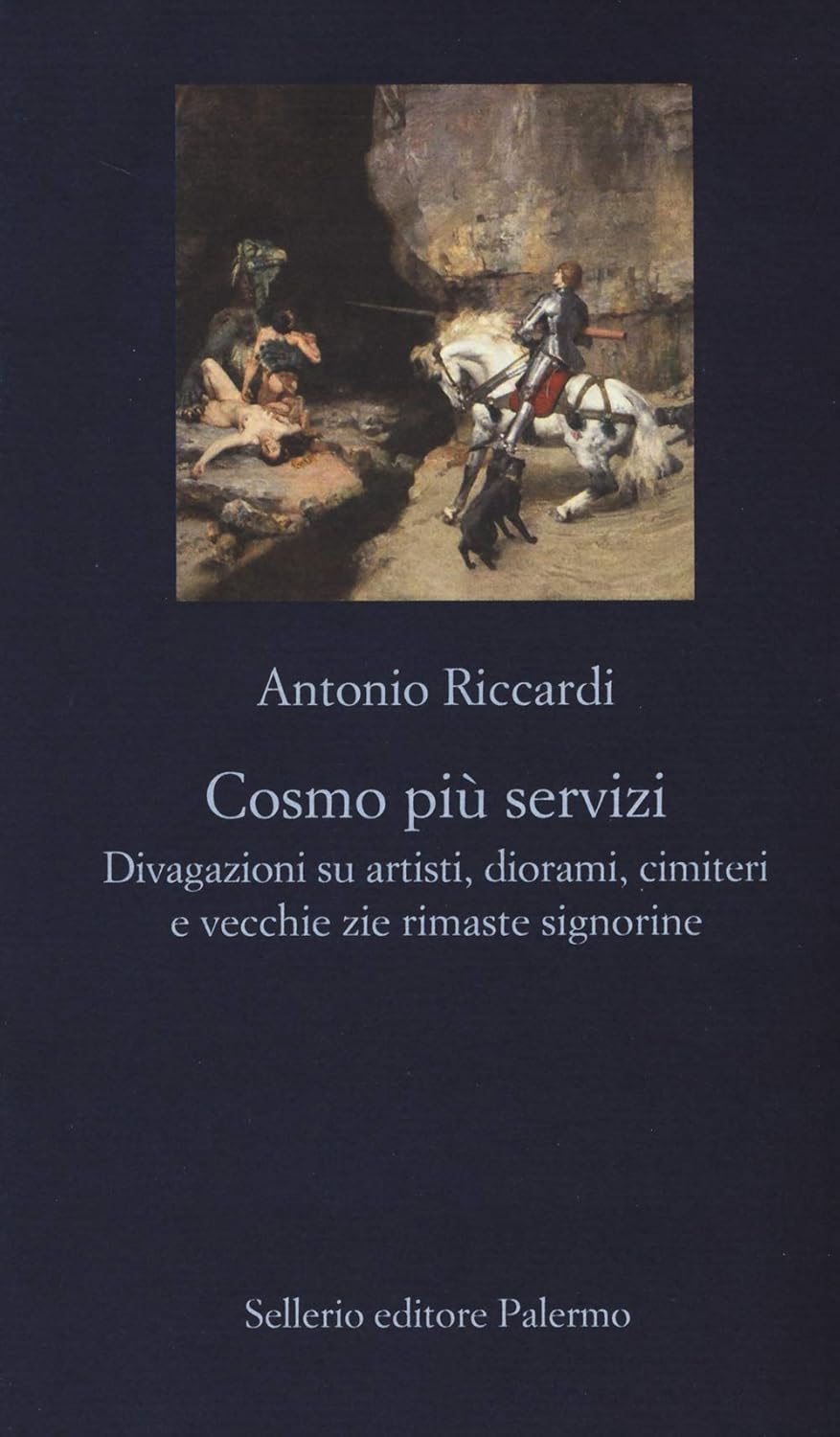






Commento all'articolo