Cronaca familiare – Vasco Pratolini
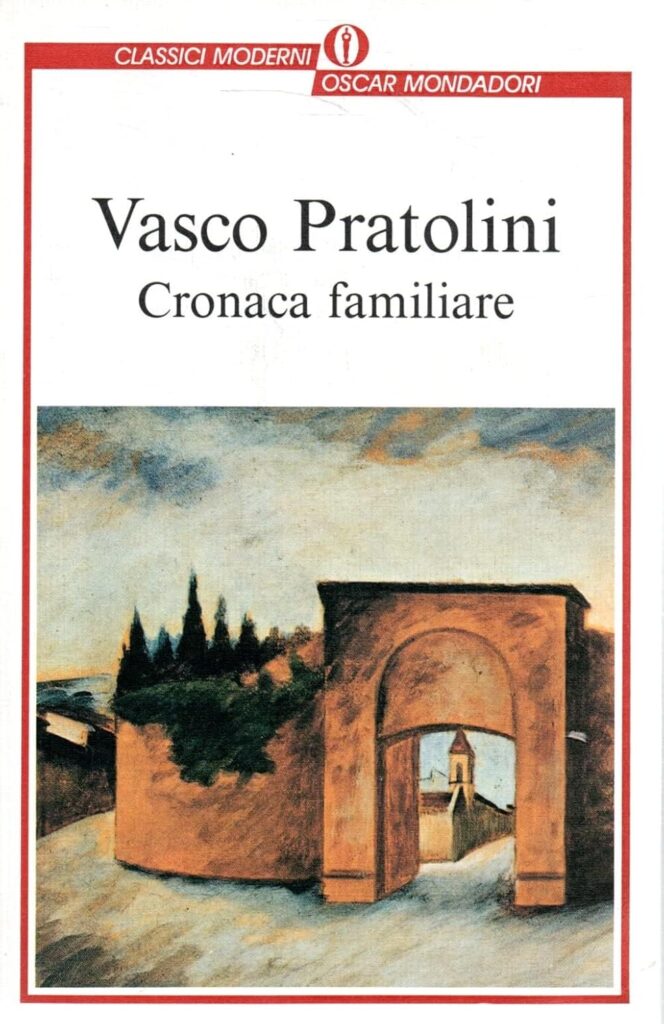
SINTESI DEL LIBRO:
Scritta di getto, in una settimana, nel dicembre 1945, pubblicata due
anni dopo nelle edizioni Vallecchi, la Cronaca familiare propone al
critico e al lettore in genere due ordini di problemi: il primo
riguardante l'ambito della cronologia, il secondo quello della
classificazione letteraria. Mi spiego meglio. Il 1945 rappresenta nella
vita di Vasco Pratolini un anno fondamentale: dopo la guerra e la
lotta partigiana, la ripresa della sua carriera di scrittore. Stende la
serie delle prose partigiane (poi raccolte ne II mio cuore a Ponte
Milvia), e soprattutto affida alle pagine della Cronaca familiare la
soluzione del rapporto tra memoria autobiografica e nuova
coscienza storica. Dunque una data da tener presente nella
cronologia pratoliniana come consuntivo del passato (Tappeto verde,
Via de' Magazzini, Il quartiere), ma anche e soprattutto come punto
di partenza per quel romanzo a cui pensa da tempo. Se le date
significano qualcosa - (e qualcuno ne è convinto) -, questa della
Cronaca è per molti aspetti da considerarsi decisiva nel grafico
dell'opera di Pratolini.
L'altro problema riguarda il " genere " a cui la Cronaca appartiene. Si
è molto discusso su questa questione, senza per altro approdare a
conclusioni convincenti. Cos'è, allora, la Cronaca? Diario,
autobiografia, prosa d'arte, racconto lungo, romanzo breve? Direi
che nessuna categoria soddisfa pienamente. Il libro presuppone e
ingloba l'intera classificazione, senza tuttavia costringersi in una
dimensione unitaria.
A conti fatti, parlerei di un'opera a più valenze, in grado di risolvere
quasi per miracolo, nella sua complessa e misteriosa articolazione,
tutta una serie di elementi strutturali e stilistici che apparentemente
sembrano contraddirsi. Forse, a questo punto, è bene forzare i
termini della questione ed affermare senza reticenze che già siamo
nello spazio della prosa di romanzo, che la Cronaca possiede
struttura e respiro di romanzo anche se romanzo non è, almeno in
senso tradizionale, anche se gli equilibri interni e la scansione
prosastica (il ritmo alterno del racconto) sembrano di volta in volta
mettere in crisi questa soluzione.
Fuor di dubbio che su questo aspetto particolare (che in parte spiega
la fortuna dell'opera) si dovrà tornare, ma intanto vorrei anticipare
qualche conclusione: la Cronaca familiare a mio parere costituisce
un unicum nel quadro della narrativa del dopoguerra, un modello di
misura espressiva che mi sembra abbia significato molto per
l'evoluzione del racconto e del romanzo contemporanei.
Alfonso Gatto nel tenere a battesimo nel 1960 l'edizione
mondadoriana della Cronaca ebbe a dire che il libro rappresentava «
un ostinato metter radici nella storia con un atto di fede ». E in effetti
quei due vocaboli (la fede e la storia) servivano egregiamente a
definire il registro espressivo che Pratolini aveva privilegiato. « era il
nostro - continuava Gatto - l'assurdo di un ideale negativo: il male
perseguito dal male stesso a nostra insaputa, pur nella notizia della
sua offesa [...] In questa tecnica impersonale della persona
colpevole anche del suo bene e della sua felicità [...] prese sempre
più corpo il crudele realismo dell'anima e fu la vera e unica
dimensione non crepuscolare del nostro lavoro. Quasi nello scrupolo
di non meritare la vita, vivendo tuttavia, fummo attenti (e distratti) a
volere la nostra mancanza di autorità su noi stessi, a riconoscerla, a
difenderla, nell'attesa di noi. Mai i sentimenti avrebbero congiurato a
trarre fuori dal diario il romanzesco della nostra avventura ». Così,
per i protagonisti di una generazione,
diario e romanzo saldavano le loro ragioni, stabilendo in tal modo lo
spazio operativo di questa Cronaca che resta appunto, e prima di
ogni altra cosa, « una vittoria del cuore umano, del nostro cuore di
allora ». Rimangono da stabilire i caratteri di questa "vittoria",
smontandone a tavolino gli ingranaggi e rivelandone la sapienza
costruttiva celata dietro l'apparente "innocenza".
Ma converrà prima farsi cronisti sommari di quella storia pubblica e
privata che sta alle spalle del libro. È evidente che i primi lineamenti
della scrittura di Pratolini (ampiamente rivelati dal suo primo
personaggio, "Sapienza") sono da collegarsi ad una solida tradizione
regionale, o meglio ad una provincia sublimata dalle inquietudini di
una memoria modernissima. Gli esempi del resto non gli
mancavano: se pensiamo a Palazzeschi narratore non sarà difficile
individuare il rapporto che lo collega alla prima attività pra-toliniana.
E insieme non sarà da trascurare anche una componente realistica
(ma di un realismo risolto in chiave intimistica), quale Pratolini
poteva aver mediato dalla lettura di Pratesi e di Tozzi. In seguito,
negli anni dal 1938 al 1940, con l'esperimento letterario di « Campo
di Marte », Pespe-rienza dello scrittore avrà modo di dilatarsi, ma
per ora, intorno al 1935, il suo lavoro tende prevalentemente a
risolvere in senso moderno le qualità memoriali della migliore
tradizione regionale. L'autobiografia, il tentativo consapevole di
raffigurare attimo per attimo, attraverso la propria esperienza, un
comune destino di sofferenza, lo porteranno lentamente dalla pagina
lirica alla scoperta del valore storico della memoria, ad un recupero
ciclico dell'infanzia "toscana" che da Via de' Magazzini conduce fino
al Quartiere. Un percorso in gran parte avvicinabile a quello di
Romano Bilenchi che in qualche modo cronologicamente gli
corrisponde. Ma Pratolini aveva iniziato con il Tappeto verde,
stampato da Vallecchi nel 1941, in cui un racconto - forse il più tipico
della sua prima maniera - risaliva addirittura al 1935/1936. Una
giornata memorabile può infatti già con
durre alla comprensione di quello che dovrà essere lo svolgimento
della "memoria" pratoliniana.
Qui la base di partenza è senz'altro la visione realistica della Firenze
1925, il mondo colorito e vivace del quartiere di Santa Croce,
rivissuto con l'occhio picaresco dei giovani protagonisti, figli di
operai, di piccoli artigiani, di poveri avventurieri della miseria
quotidiana. Ma al centro di questa atmosfera esiste fin da ora la
volontà di fare storia, di cogliere, oltre la scorza del "quartiere", la
vita autentica del popolo fiorentino, quella realtà amara che
condiziona il proletario fuor da ogni retorica, sgombrato il campo
dalle mitologie populistiche e alzato alfine il velo che copre il
compatto spessore della miseria. Così Pratolini giunge a dare un
volto e una voce alla via Pietrapiana, al vecchio cinema Garibaldi, a
colorire le mura consunte di Piazza Santa Croce ove rimbalzano le
grida- dei suoi ragazzi, dei suoi giovani "picari". Non più prototipi ma
uomini, creature sorprese nel loro fango quotidiano che è anche la
loro quotidiana redenzione, la scelta di una condizione e di un
destino. « Intanto imparavo a guardare più a fondo gli uomini e le
cose, almeno fino al fondo di me stesso, se non al fondo di esse
cose e di essi uomini... »: questa la situazione di Pratolini al tempo di
Una giornata memorabile, e questa, credo, la ragione del suo
narrare, recuperato al documento e alla vita dall'esilio della
"provincia".
Certo non tutte le pagine del Tappeto verde si muovevano in questa
direzione: talvolta il patetico sembrava prevalere, e spesso l'eco
dell'apprendistato letterario sembrava pericolosamente prevaricare
sull'autonomia del dettato prosastico. Ma intanto, col suo primo libro,
Pratolini aveva proposto all'ambiente letterario fiorentino e nazionale
una esperienza nuova e originale: aveva individuato un cammino
autonomo che puntava ad una "struttura" storica entro la quale
comporre quel disegno esistenziale imposto dai "sentimenti". Il
Tappeto verde proponeva così una serie di prose, un gruppo di
quadretti memorialistici che preludeva già
al rinnovamento della situazione letteraria della Firenze di quegli
anni. Proprio in questa prospettiva, a breve distanza, appariva Via
de } Magazzini che iniziava un nuovo ciclo e che poteva essere
considerato, per molti aspetti, la prima opera impegnativa dello
scrittore. Pubblicato nel 1942, edito da Vallecchi, ristampato più
tardi, nel 1949, da Bompiani, Via de' Magazzini si presentava come
un diario d'infanzia in cui emergeva la necessità di definire una
poetica sgorgata dalla coscienza di una comune situazione
d'infelicità e di miseria; nasceva il ritratto della piccola classe
proletaria fiorentina, tra operaia e artigiana, che Pratolini cercava di
raffigurare con estremo rigore morale e sentimentale.
Per comprendere veramente la complicata situazione della poetica
pratoliniana intorno al 1940, si dovrebbe a questo punto fare un
passo indietro per fare i conti con l'uomo pubblico, non più lo
scrittore alle prime armi quanto piuttosto con il suo impegno sociale
e politico. Solo in questa dimensione sarà possibile cogliere l'intima
struttura della " storia" di Pratolini, il disegno inquieto dell'anima di
chi pochi anni più tardi dovrà scrivere le pagine della Cronaca
familiare.
Dal 1935 al 1939 vengono rapidamente esaurite due capitali
esperienze: la collaborazione ad un settimanale politico, il « Bargello
», e la direzione con Alfonso Gatto di un giornale letterario di alto
impegno quale fu « Campo di Marte » nella sua brevissima
esistenza (1938-39). D'altra parte le due esperienze risultano
strettamente collegate poiché al momento politico-sociale venne
affidato un largo margine di prospettiva culturale (e sono questi gli
anni decisivi del contatto e dell'amicizia con Elio Vittorini), così come
al curriculum letterario dette sostanza e mordente proprio quella
problematica sociale maturata nella collaborazione all'organo della
federazione fascista fiorentina.
Certo il seme di autonomia sociale e culturale che si annida in questi
anni nella terza pagina del « Bargello » è assai pericoloso, se vi
fanno le ossa giovani intellettuali come
Romano Bilenchi (sul « Bargello » pubblica la Storia dei socialisti di
Colle ^e alcuni interventi di evidente impostazione sociale: Per una
coscienza politica ai contadini, Visita al vecchio politicante, Tempo di
revisione, ecc.) ed Elio Vittorini (suoi gli articoli più impegnativi dal
punto di vista politico: Letteratura e fini sociali. Le quattro grandi
forze storiche, Lavoro manuale e lavoro intellettuale, Unificazione
della cultura, ecc.). Soprattutto intorno a Vittorini, dopo il 1935 e i
gravi contraccolpi internazionali, si raccolgono e fanno gruppo i più
giovani intellettuali che puntano con decisione al recupero della
libertà e della piena autonomia della cultura.
D'altra parte quel che conta è sapere che da qui muove la
contrapposizione tra i giovani intellettuali del gruppo fiorentino e le
vecchie strutture propagandistiche del regime. È chiaro che i giovani
si muovono con grande difficoltà. Convinti dell'inutilità dell'azione
politica, si rifugiano nello spazio della cultura militante. Nelle ultime
annate, quelle caratterizzate dalla presenza di Pratolini e di Gatto, le
posizioni d'inquietudine culturale e di crisi sociale si fanno sempre
più frequenti. E intanto Pratolini consolida la dimensione sociale del
suo lavoro culturale, configurando quella coscienza proletaria che
progressivamente le conduce all'aperta polemica e all'opposizione.
Proprio in questo periodo (ed è il momento della guerra di Spagna)
lo scrittore scopre che la sua vocazione al mondo del "quartiere" e
del proletariato cittadino può avere una sua piattaforma teorica, un
suo fondamento politico-culturale. Si legga ad esempio UItalia
proletaria nell'impero dove è chiaramente testimoniata l'origine
antiborghese e anarcoide della sua contestazione. Si prospetta così
il limite borghese dell'azione fascista sul piano sociale e la distanza
che separa i miti della rivoluzione dalla realtà presente: « Per noi,
per me l'antiborghesismo non era una posa ma una radicata
convinzione, una fede - smentita dai fatti - che ci è potuta costare
rinuncie e umiliazioni, se i piccoli uomini potessero impressionarci.
Ma il nostro metro
misura troppo in altezza e forse, in tali concetti, noi, popolo del
popolo, si tradiva il popolo o i libri, e i ricorsi storici avevano
succhiato il midollo della nostra materia popolana... ».
Evidentemente queste parole del 1936 trovavano conferma in una
serie di interventi dedicati al proletariato Nella serie II soldato torna
contadino si polemizza apertamente contro il tentativo di trasformare
in speculazione quello che era stato un autentico impegno popolare,
caratterizzando Tanti tesi tra interesse privato e interesse di classe
con implicazioni che già rivelano elementi marxisti. E ancora in
Tempo culturale della politica si sciolgono gli ultimi dubbi e si chiede
una definitiva compromissione nei confronti del mondo operaio [« Ad
ogni modo si deve inoculare nell'operaio (e in chiunque) una
possibilità superiore, cioè sempre più chiara e definita, di coscienza
sociale e rivoluzionaria »]. La scelta è ormai fatta. Ma intanto, circa
nella stessa epoca, in Necessità della dottrina, Pratolini tornerà alla
valutazione dei grandi fenomeni rivoluzionari di massa e alla piena
coscienza della grande crisi europea, espungendo ogni
considerazione di gretto nazionalismo. Non soltanto si delinea la
grande antitesi delle forze europee, ma si tenta un pericoloso salto
nel buio quando si afferma che per fascismo si deve intendere
unicamente uno spazio sociale ancora da conquistare. Al di là di
queste posizioni illusorie e mistificanti esiste, d'altra parte, uno stato
latente d'incertezza e d'inquietudine che appanna di "sentimento" la
prosa politica di Pratolini: lentamente si è fatto strada il tarlo del
dubbio,
la
consapevolezza che il mito rivoluzionario è
definitivamente tramontato. Nasce in questo spazio la scelta
consapevole dei temi proletari dei primi racconti e la carica
ideologica delle prime prove narrative dello scrittore.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :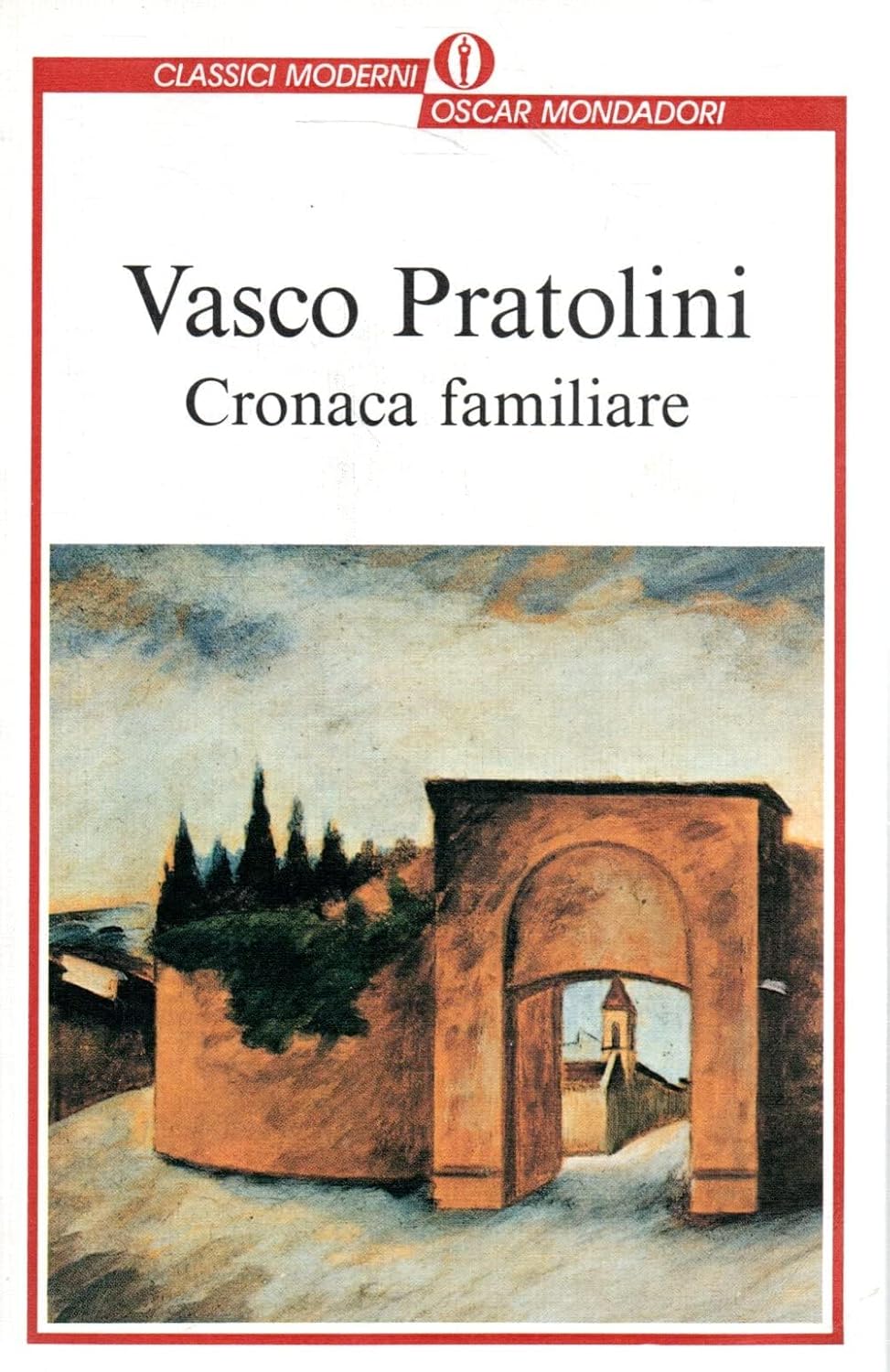






Commento all'articolo