Cos’è per te l’Europa? – Virginia Volpi
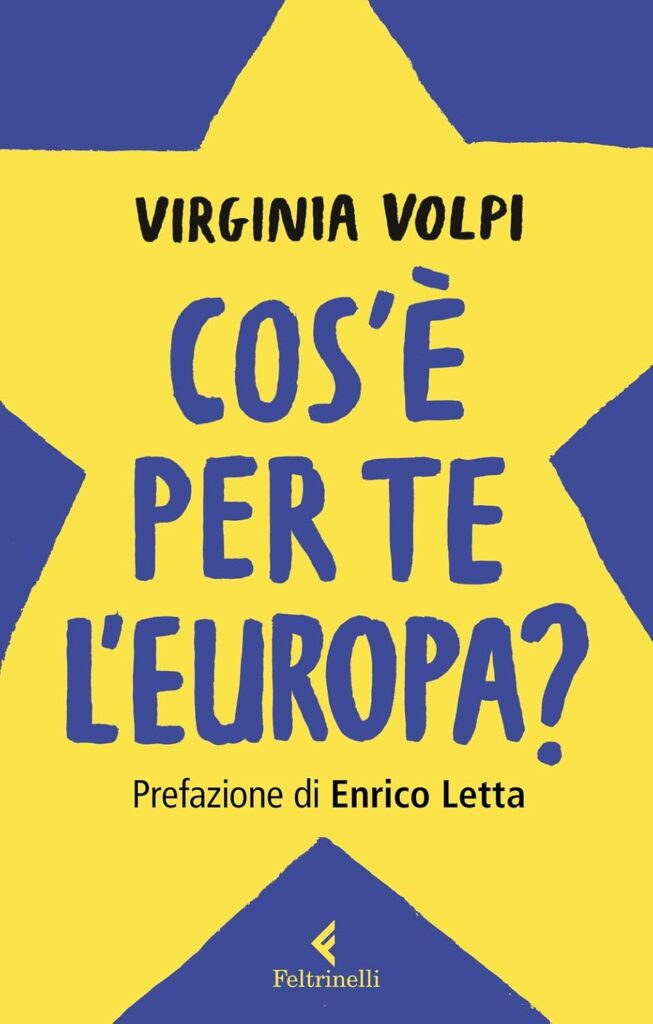
SINTESI DEL LIBRO:
Alla conclusione di ogni conflitto, si cerca di stabilizzare la
situazione geopolitica per impedire il ripetersi di eventi catastrofici e
dolorosi.
Collaborare per scongiurare i conflitti: questa è l’idea originaria e il
filo che si dipana, si intreccia e a volte corre spedito per cucire
l’Europa e il suo futuro.
Era il 1648 e con la Pace di Vestfalia si chiudeva la Guerra dei
Trent’anni, che aveva dilaniato il suolo europeo. Da scontro di
religione tra cattolici e protestanti era diventata conflitto militare e
politico.
Dunque, nei trattati di pace si prevedeva anche il primo sistema di
sicurezza collettiva: lo stato vittima di un attacco non scattava lancia
in resta in controffensiva, ma concedeva alla fazione opposta un
periodo di ripensamento prima di procedere al contrattacco insieme
agli altri stati.
Questo sistema non ebbe mai attuazione, ma un nuovo ordine
internazionale era nato: i grandi imperi arretravano e gli stati moderni
facevano la loro comparsa.
A grandi falcate lungo il corso della storia, arriviamo al 1815.
Siamo nello sfarzoso castello di Schönbrunn, dove è in corso il
Congresso di Vienna, evento che segnerà l’inizio della
Restaurazione.
La Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche avevano travolto
ogni equilibrio europeo. Ora nel palazzo imperiale le potenze
europee si mettevano a tavolino per ristabilire l’ordine perduto.
Volevano ripristinare l’Ancien régime e far tornare ogni cosa al suo
posto: i sovrani come i confini.
C’era, però, una novità: il Concerto d’Europa. Non era fatto di
archi, percussioni o fiati, ma di una dichiarazione di princìpi, di
un’alleanza militare e di un’embrionale diplomazia, costituita da
incontri periodici fra i regnanti per discutere e prevenire i conflitti.
Dai giardini della maestosa residenza estiva degli Asburgo, fece il
suo ingresso anche il conte Claude-Henri de Saint-Simon. Acuto
filosofo e intellettuale illuminato, teneva sotto il braccio a mo’ di
baguette il suo pamphlet De la réorganisation de la société
européenne. Un titolo straordinariamente moderno per un libretto
visionario, in cui l’autore ipotizzava la realizzazione di un Parlamento
generale, superiore a quelli nazionali.
Ancora un balzo e giungiamo così al Novecento, “il secolo breve”
secondo Eric Hobsbawm, iniziato con la Prima guerra mondiale e
finito con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991.
All’indomani della Prima guerra mondiale, dell’Europa rimanevano
macerie. Proprio su quelle macerie venne fondata la Società delle
Nazioni, la prima organizzazione internazionale che aveva come
obiettivo la pace.
Costruire la pace
Era il 1919, e nella galleria degli specchi di Versailles, un corridoio
rococò che collega il Salone della Guerra al Salone della Pace, i
delegati di 44 stati siglavano la nascita della Società delle Nazioni,
con la firma del Trattato di Versailles.
Purtroppo, gli Stati Uniti non entrarono mai a farne parte.
Dieci anni più tardi, proprio di fronte alla Società delle Nazioni, il
ministro degli Esteri francese Aristide Briand avrebbe lanciato con
queste parole l’idea di una federazione europea: “Io penso che tra
popoli geograficamente raggruppati, come i popoli d’Europa, debba
esistere una sorta di linea federale”.
Ma “nessun trattato di pace deve essere ritenuto tale se stipulato
con la tacita riserva di argomenti per una guerra futura” scriveva a
fine Settecento Immanuel Kant nell’opera Per la pace perpetua, e il
Trattato di Versailles presentava giusto questo difetto: ogni stato
conservava il monopolio della forza militare.
Lo scoppio del Secondo conflitto mondiale vanificò la missione di
pace della Società delle Nazioni. Dalle sue rovine, però, il 24 ottobre
1945 nacque l’organizzazione delle Nazioni Unite, l’Onu. Con il
medesimo scopo ma con un sistema di sicurezza collettiva più
incisivo: l’Onu non solo vieta l’uso della forza armata, ma anche la
minaccia. Ogni intervento armato è possibile solo dopo
l’approvazione del Consiglio di sicurezza. Un enorme passo in
avanti.
Dell’Onu oggi fanno parte 193 stati, tra cui finalmente gli Stati Uniti.
Dopo due guerre mondiali, l’Europa era un continente distrutto su
ogni fronte: sociale, politico ed economico. Così, nel 1948, il
congresso degli Stati Uniti varò lo European Recovery Program,
noto come Piano Marshall. In esso si stabiliva che, se fosse iniziato
un processo di integrazione tra i paesi europei, ispirato al modello
federale americano, gli Usa avrebbero destinato alla ricostruzione
circa 14 miliardi di dollari in tre anni. Non era solo beneficenza: c’era
anche la volontà di attrarre gli stati europei nell’orbita d’influenza
americana, per realizzare una politica di contenimento del
comunismo sovietico.
Ecco che l’ufo, ancora lontanissimo, pian piano sta acquistando
una configurazione più definita.
Era il 1946 e dall’Università di Zurigo il già primo ministro inglese
Winston Churchill incoraggiava alla riconciliazione franco-tedesca,
per creare “una specie di Stati Uniti d’Europa”.
Oggi, in tempi di Brexit, che sia stato un britannico, e parlando
dalla Svizzera (sempre neutrale!), a spingere per l’unificazione
europea sembra uno scherzo. Ironia della storia!
Ma intanto l’idea dell’unità come pace e della pace come unità si
stava diffondendo rapidamente sul suolo europeo.
Nel 1949, il disegno di Churchill si concretizzava nel Consiglio
d’Europa: un’organizzazione internazionale volta a garantire pace e
democrazia.
Erano dieci paesi europei a farne parte e volevano “una più stretta
unità […] al fine di salvaguardare e attuare gli ideali e i princìpi che
costituiscono il patrimonio comune, nonché facilitare il progresso
economico e sociale”.
La sede veniva simbolicamente posta a Strasburgo: città al confine
tra la Francia e la Germania, da tempo immemore contesa fra le due
potenze. Ancora oggi, basta appisolarsi sul tram e dalla Francia ci si
sveglia in Germania, a Kehl, collegata a Strasburgo dal Ponte
d’Europa.
Il Consiglio d’Europa non ebbe il successo sperato: troppi obiettivi
con pochi poteri, ma fu un formidabile punto di partenza.
Due somari cocciuti
“Monnet e io stiamo tirando la carretta come due somari cocciuti,
lui nella speranza di ottenere dai governi una nuova iniziativa, io
nella speranza di ottenere dal movimento un nuovo slancio. […]
Entrambi convinti che dobbiamo aiutarci.” È Altiero Spinelli a
scriverlo nel suo diario. Parla di sé, di Jean Monnet e della loro idea
differente di unione europea, che tuttavia aveva un obiettivo
comune: evitare a ogni costo una nuova guerra.
Altiero Spinelli è stato il capostipite della linea federalista, Jean
Monnet della scuola funzionalista.
Vediamo di capirci qualcosa in più.
Spinelli,
padre del Movimento federalista europeo, non
apparteneva a un partito ma a una missione: quella dell’Europa
unita. Durante il ventennio fascista era stato arrestato come
oppositore politico: dieci anni di carcere e sei di confino. Si racconta
che in quegli anni avesse preso l’abitudine di camminare tre passi
avanti e tre indietro, come se fosse in gabbia. Ma anche così
duramente messo alla prova, nel 1941, insieme al compagno e
amico Ernesto Rossi, scriveva il saggio Per un’Europa libera e unita.
Progetto d’un Manifesto.
Spinelli e Rossi erano in esilio nell’isola di Ventotene, un fazzoletto
di terra nel Mar Tirreno, e da lì immaginavano la libertà. Sognavano?
Sicuramente, ma conservavano la lucidità per elaborare proposte.
Il
e
loro progetto prevedeva che le sovranità nazionali fossero
limitate
bilanciate
all’interno
di
una comunità politica
sovranazionale. Un’assemblea costituente europea, diciamo un
gruppo di legislatori, avrebbe dovuto porre le basi politiche e
istituzionali di una vera e propria unione.
Mentre da un lato i federalisti volevano partire dalla condivisione
politica per arrivare a quella economica, dall’altro i funzionalisti
procedevano al contrario: bisognava cominciare dalla condivisione
economica, mettendo in comune alcuni interessi essenziali per poi
arrivare alla condivisione politica. Sarebbe stata la necessità a
creare l’istituzione, grazie a un débordement, uno straripamento, una
sorta di disciplinabile assestamento.
Padri nobili della scuola funzionalista erano il già citato Jean
Monnet e Robert Schuman.
Monnet, promotore e vicesegretario generale della Società delle
Nazioni, uomo d’affari, progettò un’unione franco-britannica per
mettere in comune la capacità produttiva e la politica dei due paesi.
“Non ci sarà pace,” affermò, “se gli stati verranno ricostruiti sulla
base della sovranità nazionale”.
Schuman, nato in Lussemburgo, si era trasferito a Metz, città che
come Strasburgo era passata in mano alla Francia. Prima deputato
francese, poi ministro, coronò una carriera politica prestigiosa
diventando presidente del Consiglio.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :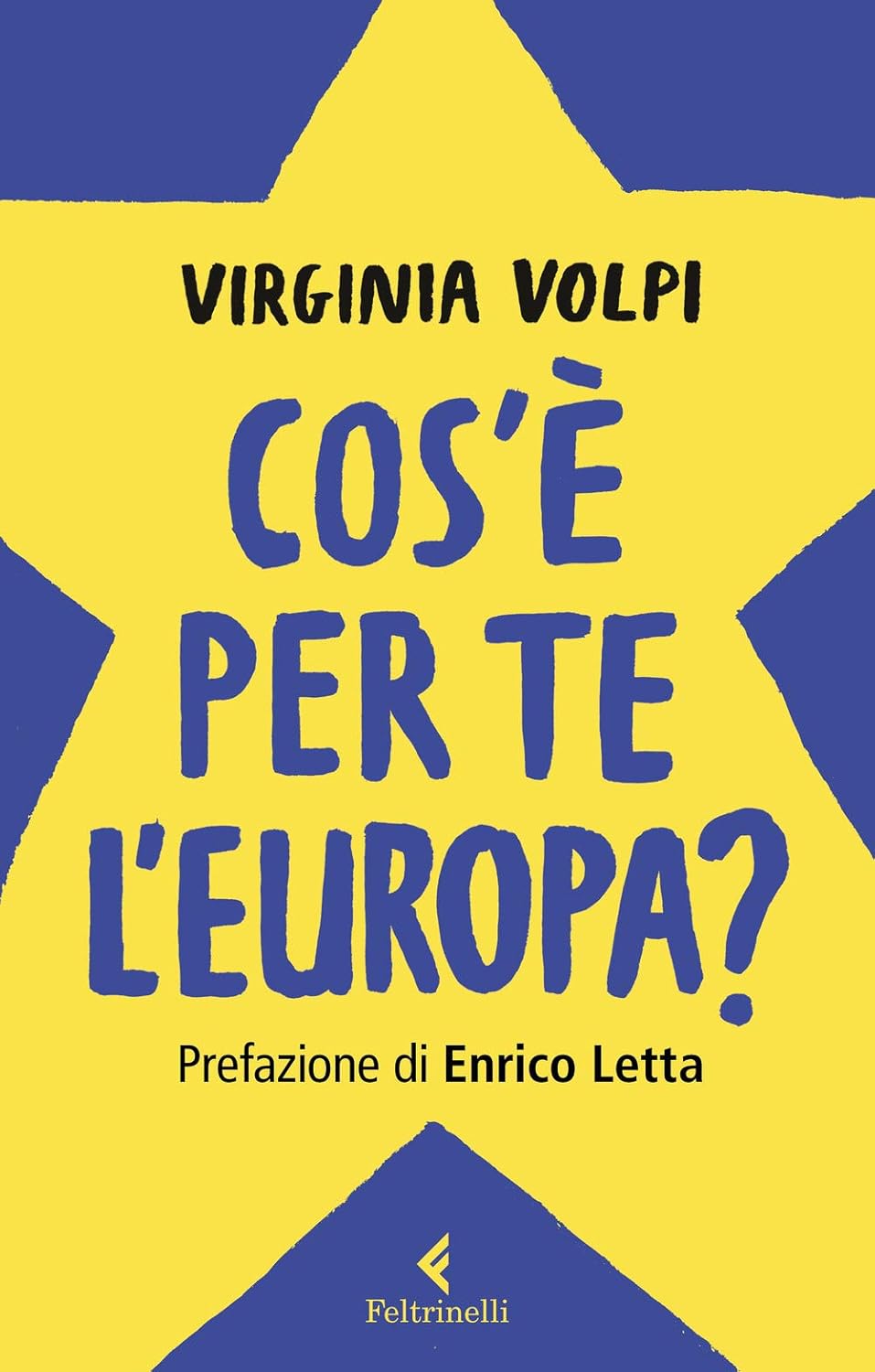






Commento all'articolo