Contagio e libertà – Piero Ignazi & Nadia Urbinati
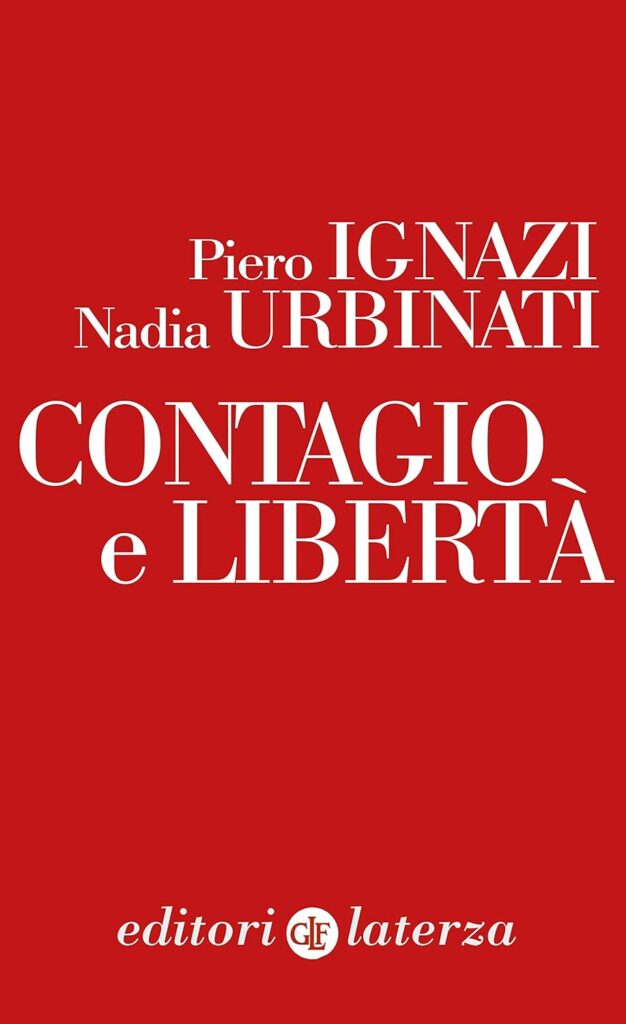
SINTESI DEL LIBRO:
E fu questa pestilenza di maggior forza per ciò che essa dagli infermi di quella per lo
comunicare insieme s’avventava a’ sani, non altramenti che faccia il fuoco alle cose secche
o unte quando molto gli sono avvicinate. E più avanti ancora ebbe di male: ché non
solamente il parlare e l’usare cogli infermi dava a’ sani infermità o cagione di comune
morte, ma ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa da quegli infermi stata tocca o
adoperata pareva seco quella cotale infermità nel toccator transportare
[1].
A secoli di distanza dalla sua stesura, il Decameron fotografa con
precisione la condizione che dall’inizio del 2020 accomuna molti
degli abitanti del pianeta. «Vicinanza» («il parlare» e «il toccare») e
«contagio» stanno in relazione causale, rendono fragile l’equilibrio
tra «comunicazione» e «immunità» e creano un «comune» destino
di rischio (e paura) di «infermità» e «morte». La pandemia da Covid
19 ha riacceso l’attenzione verso problemi che dalla sconfitta dei
totalitarismi sembravano risolti. In particolare, in Italia ha promosso
una lettura delle decisioni sul contenimento sociale che ha fatto
perno sulle implicazioni patologiche per la libertà che possono avere
la paura del contagio e la volontà di raggiungere una immunità totale
dai rischi di «infermità» e «morte», con risvolti a tratti schizofrenici
sulla percezione dei rapporti sociali, piegati da un lato alla volontà di
espungere radicalmente rischio e conflitto e dall’altro al desiderio di
affermare una libertà individuale disancorata dalla responsabilità. Si
tratta di una tensione che fa parte della democrazia stessa la quale,
Elmer E. Schattschneider scrisse nel 1960, prova quanto il conflitto
politico sia positivamente «contagioso» qualora inneschi tra le parti
una dialettica di permanente aggiustamento della «distanza» tra
interessi privati e interesse pubblico
[2].
Calzante è l’analogia con il paradigma machiavelliano secondo il
quale il dinamismo della libertà è generato dal conflitto tra le parti,
cosicché il rischio di disarticolazione della comunità crea le
condizioni per nuove riconfigurazioni di potere (l’immaginario del
conflitto violento modera e orienta le relazioni politiche). Si potrebbe
dire che comunità e immunità non sono mai in una lotta a somma
zero. Dal momento che la comunità non è un’unione armoniosa di
soggetti identici, voler imporre un ordine assoluto che la immunizzi
totalmente è tanto inumano quanto utopistico e, alla fine,
fallimentare.
Il
limite tra comunità e immunità, e quindi il bilanciamento tra
paura e reazione alla paura, ha negli ordini repubblicani – oggi
diremmo democratici – la sua più riuscita realizzazione. Tali ordini
sono fondati sull’assunto che il rischio sia ciò che anima una vita
pubblica libera: le cosiddette «regole del gioco» sono possibili
perché il rischio non è soppresso ma bene ordinato così da
infondere dinamismo all’intero sistema. Mettere giusti argini al corso
di un fiume, sosteneva Machiavelli, serve a contenere i rischi di
straripamento e a sfruttare le potenzialità benefiche delle acque. Al
contrario, una politica di totale immunizzazione sarebbe come
l’autosoppressione della società e della libertà.
Su questa logica sono fondate le costituzioni scritte. Documenti di
libertà politica e civile, esse sono state redatte prevedendo il conflitto
e il dissenso (e sagge nella misura in cui lo sanno regolare e
sfruttare al meglio), come meccanismi congegnati allo scopo di
regolare l’istituzionalizzazione di una società che è sempre esposta
alla tentazione di radicalizzare la strategia della distanza per reagire
alla paura: un impulso che, portato alle estreme conseguenze,
comporterebbe secedere dalla comunità, come si legge nel
Decameron.
È possibile distinguere due forme radicali, identiche e opposte, di
immunizzazione: una che può coincidere con l’abolizione della
libertà, e una che può coincidere con l’interruzione dei vincoli civili
tra i cittadini. Alla prima appartiene il dispotismo, alla seconda un
individualismo atomistico. A mettere a rischio il vivere civile può
essere dunque sia una libertà assoluta sia un’autorità assoluta.
Nell’isola disabitata, Robinson Crusoe è libero dal contagio e dalla
società insieme; quella libertà è anche l’obiettivo che si prefigge il
regime dispotico, che per sradicare la paura della paura impone
l’isolamento, non per espulsione ma per assorbimento dell’individuo
nella popolazione.
Nel corso delle dispute che hanno accompagnato l’adozione da
parte dei governi democratici delle misure di contenimento della
pandemia, il paradigma atomistico ha ispirato quindi due desiderata
uguali e contrari: a) il rifiuto robinsoniano di rispondere al rischio per
via di istituzionalizzazione nel nome del principio «ciascuno faccia
come vuole e goda dell’assoluta libertà di scelta di fronte al rischio»
(una forma di secessione dalla responsabilità verso gli altri); e b) la
resa al rischio mediante la totale istituzionalizzazione in modo da
rispondere alla paura con l’isolamento all’interno della società,
affidandosi a uno Stato che per proteggere la società si prende la
libertà di «fare come vuole». Brasile e Cina hanno esemplificato
questi opposti paradigmi anti-sociali e atomistici: un totale
individualismo (anarco-liberismo) nel primo caso e una totale
istituzionalizzazione (autoritarismo e dispotismo) nel secondo.
Tenersi
fuori,
stare
isolati
dentro:
benché simili nella
fenomenologia – l’isolamento in entrambi i casi – si tratta tuttavia di
due strade diverse nelle implicazioni e nella logica che le guida. La
prima ha come obiettivo l’affermazione assoluta della libertà del
singolo, senza compromessi. La seconda ha come obiettivo la
protezione totale della collettività, senza compromessi.
Ancora diverso da questi due identici/opposti è il paradigma che
modella il governo della distanza: quello della libertà civile. In questo
caso, il rischio non viene espunto e la libertà non significa
secessione: cade, infine, l’utopia della sicurezza assoluta, della
totale immunizzazione. Intuitivamente, sembrerebbe più difficile da
praticare della strada anarco-liberista e di quella autoritaria, ma così
non è. Infatti, quando esercitata in società, la libertà deve poter
contare sul rispetto delle norme di contenimento da parte di tutti per
essere efficace: per essere al sicuro, chi «fa come vuole» deve
presumere che altri non facciano come lui, ché se tutti fossero free
rider o anarco-liberisti nessuno potrebbe essere certo di riuscire a
proteggere se stesso. All’opposto, se ci affidassimo alla totale
espulsione del rischio sospendendo la nostra responsabilità nello
Stato probabilmente ci salveremmo, ma quella salvata sarebbe la
vita biologica soltanto, muta e silenziosa.
Se la pandemia da Covid-19 ha lasciato qualche cosa di buono,
questo è senz’altro una rinnovata riflessione sulla libertà e i suoi
limiti e sulle forme di autorità.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :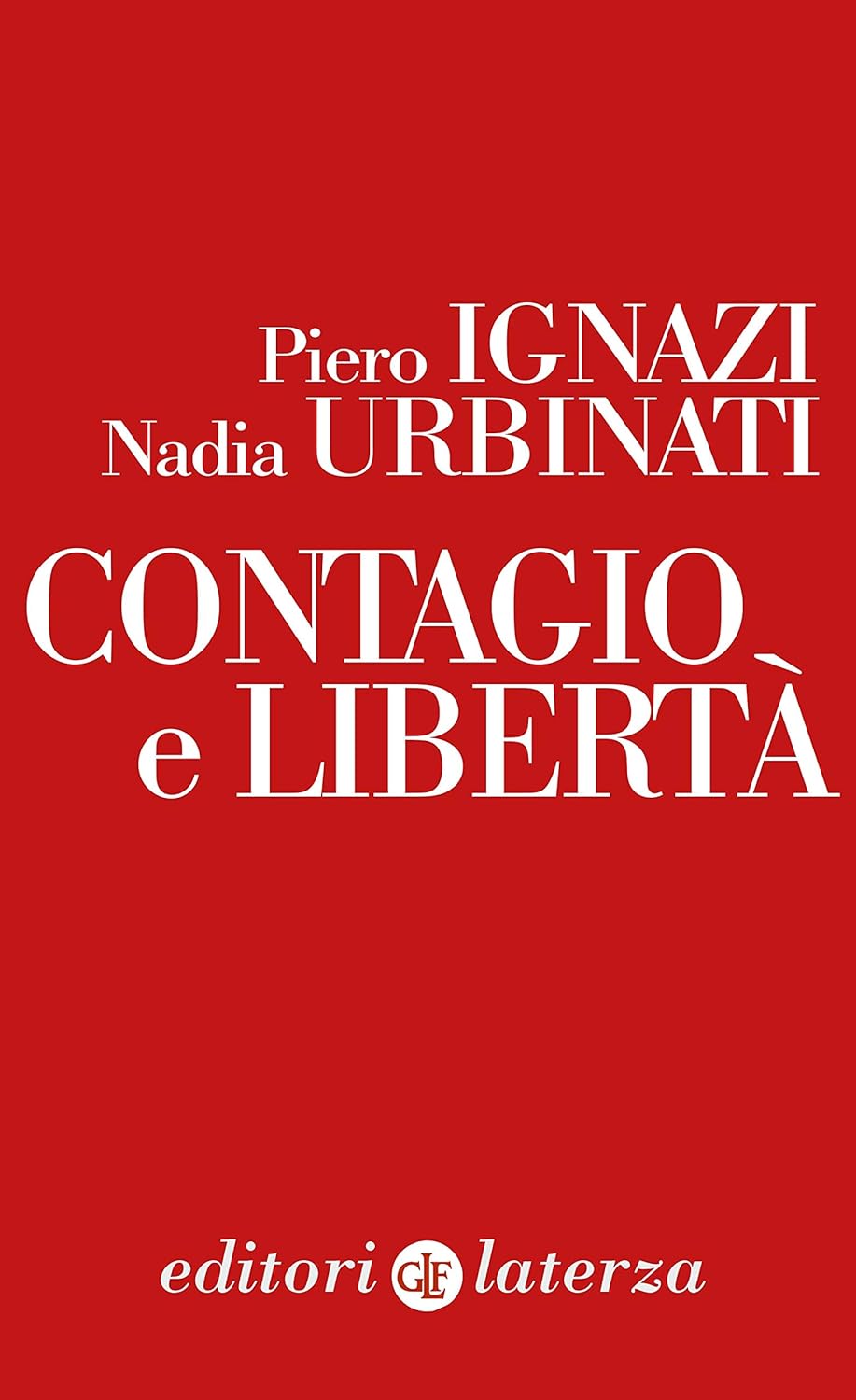






Commento all'articolo