Solidarietà. Un’utopia necessaria – Stefano Rodotà

SINTESI DEL LIBRO:
La solidarietà: virtù dei tempi difficili o sentimento
repubblicano?
Parole che sembravano perdute tornano nel discorso pubblico, e gli
imprimono nuova forza. «Solidarietà» è tra queste e, pur immersa nel
presente, non è immemore del passato e impone di contemplare il futuro
1
.
Era divenuta parola proscritta. Di essa, infatti, ci si voleva liberare
2 o se ne
cancellava ogni senso positivo, capovolgendola nel suo opposto. Non più
tratto che lega benevolmente le persone, ma delitto: delitto, appunto, di
solidarietà
3
, quando i comportamenti di accettazione dell’altro,
dell’immigrato irregolare ad esempio, vengono considerati illegittimi e si
prevedono addirittura sanzioni penali per chi vuol garantirgli diritti
fondamentali, come la salute o l’istruzione. Il fatto che oggi quella parola si
pronunci con intensità, dunque, non può velare le continue rotture della
solidarietà, non scioglie le ambiguità che possono accompagnarla, e
l’hanno accompagnata, quando la solidarietà viene invocata per chiudersi
in cerchie ristrette, alimentando rifiuti, esclusione di ogni estraneo, con
una vicenda che l’avvicina, e sovente la sovrappone, a quella di una identità
che si fa «ossessione identitaria»
4
, custode d’una logica che separa
l’individuo o il gruppo, opponendoli al resto del mondo. Ma la ragione che
consente di andare oltre queste ostilità risiede nel suo essere un principio
volto proprio a scardinare barriere, a congiungere, a esigere quasi il
riconoscimento reciproco, e così a permettere la costruzione di legami
sociali nella dimensione propria dell’universalismo. Di legami, si può
aggiungere, fraterni, poiché la solidarietà si congiunge con la fraternità, in
un gioco di rinvii linguistici che spinge verso radici comuni. Nei tempi
difficili è la forza delle cose a far avvertire come un bisogno ineliminabile il
riferimento a principi che consentano di sottrarsi alla contingenza e alla
nuda logica del potere, riscoprendo una radice profonda della solidarietà
«come segnale di non aggressione tra gli uomini»
5
.
La cancellazione del principio di solidarietà come guida dell’azione
pubblica e privata e criterio di valutazione dei comportamenti si presenta
inoltre come un atto d’arbitrio, una amputazione indebita dell’ordine
giuridico. Esso, infatti, è nominato in molte costituzioni e in documenti
internazionali, compare in più di un punto del Trattato europeo di
Lisbona, soprattutto dà il titolo a uno dei capitoli della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea
6
. Viene invocato come regola nei
rapporti sociali, alla quale devono attenersi pure gli Stati, soprattutto quelli
tra i quali esistono vincoli formali di cooperazione, quali sono, ad esempio,
i membri dell’Unione europea
7
. Si dilata così al di là dei confini nazionali,
si colloca in una dimensione dove sono appunto i principi, e non le regole
minute, a essere la fonte alla quale attingere per trarne le indicazioni
riguardanti i comportamenti individuali e collettivi, privati e pubblici,
nazionali e globali.
Di tutto questo non ci si può liberare registrando con una certa passività
le molte politiche che, nell’ultima fase e nell’Unione europea soprattutto,
hanno imposto una riduzione dei diritti sociali in nome di un indiscutibile
primato della logica economica, giungendo fino a certificare «la morte
dello Stato sociale» – conclusione drastica di un autorevole esponente delle
istituzioni europee, che suona come pubblica dichiarazione della
legittimità di politiche che degradano i diritti sociali, rendendoli irrilevanti.
Il realismo impone certamente di prendere atto di come nell’Unione
europea sia stata capovolta quella linea di riforma «costituzionale» che aveva
portato alla Carta dei diritti fondamentali e a qualche significativa novità
nel Trattato di Lisbona. È stata messa a punto una sorta di
«controcostituzione», che ha il suo più forte pilastro nel cosiddetto Fiscal
Compact
8 e di cui può essere ricostruita una più risalente genealogia che,
tuttavia, rimanda a una storia che aveva mantenuto una forte
consapevolezza della necessità non solo di contrastare le tendenze
neoliberiste, ma di dare all’Unione una più forte legittimità, fondata
proprio sui diritti, com’è scritto nella delibera del Consiglio europeo del
giugno del 1999, che avviava, appunto, la scrittura della Carta dei diritti
fondamentali. Potremmo quasi dire che nell’Unione convivono ormai due
«costituzioni», che incarnano un conflitto dal quale dipende il futuro
dell’Europa. Se oggi la costituzione economica appare come quella
prevalente nella soluzione dei conflitti, la permanente presenza di principi
e diritti costituisce un riferimento non soltanto formale per concludere che
non siamo di fronte a una questione ormai definitivamente risolta a
vantaggio di quella impostazione.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
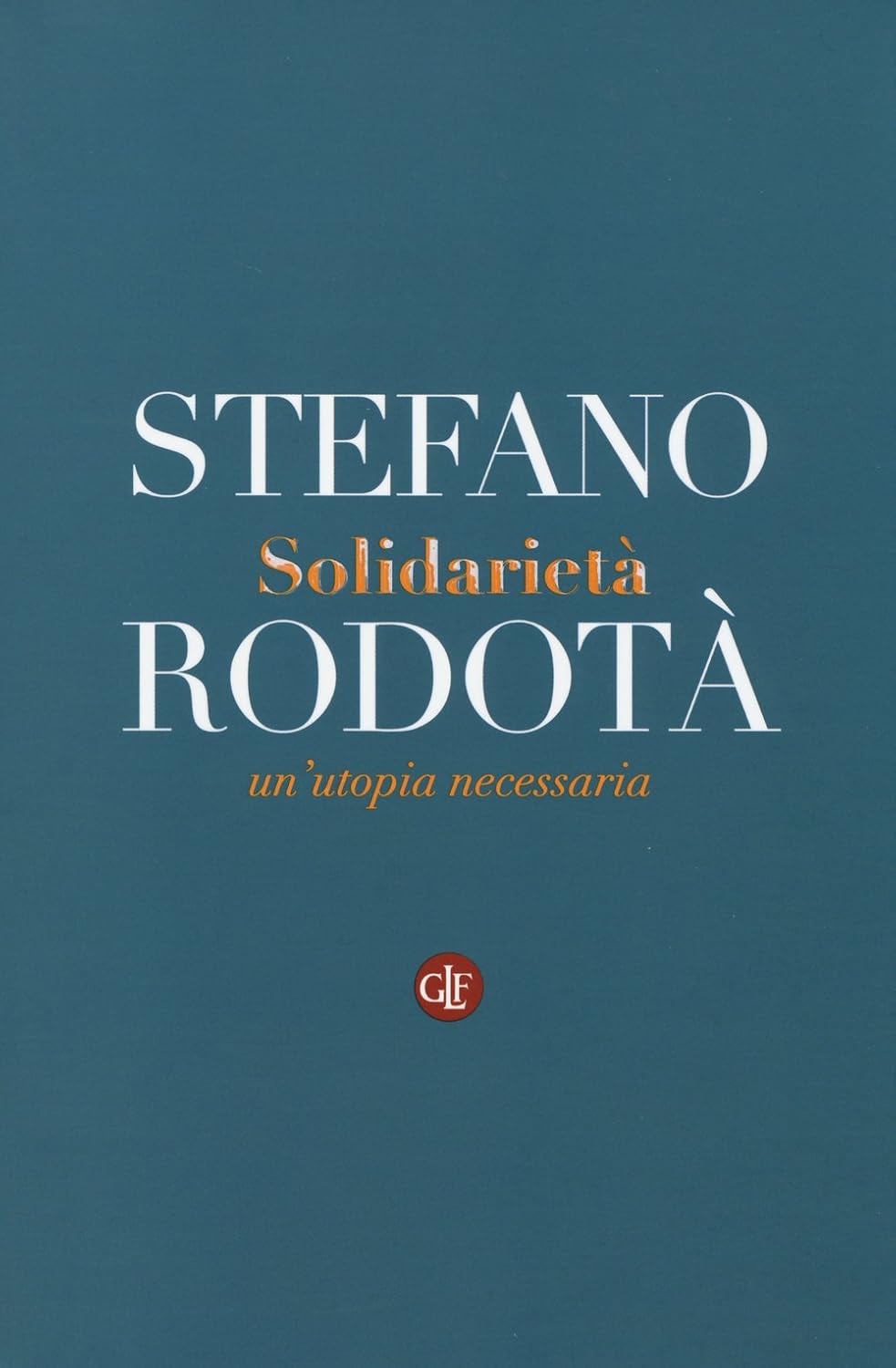






Commento all'articolo