Camminare può cambiarci la vita – Shane O’Mara
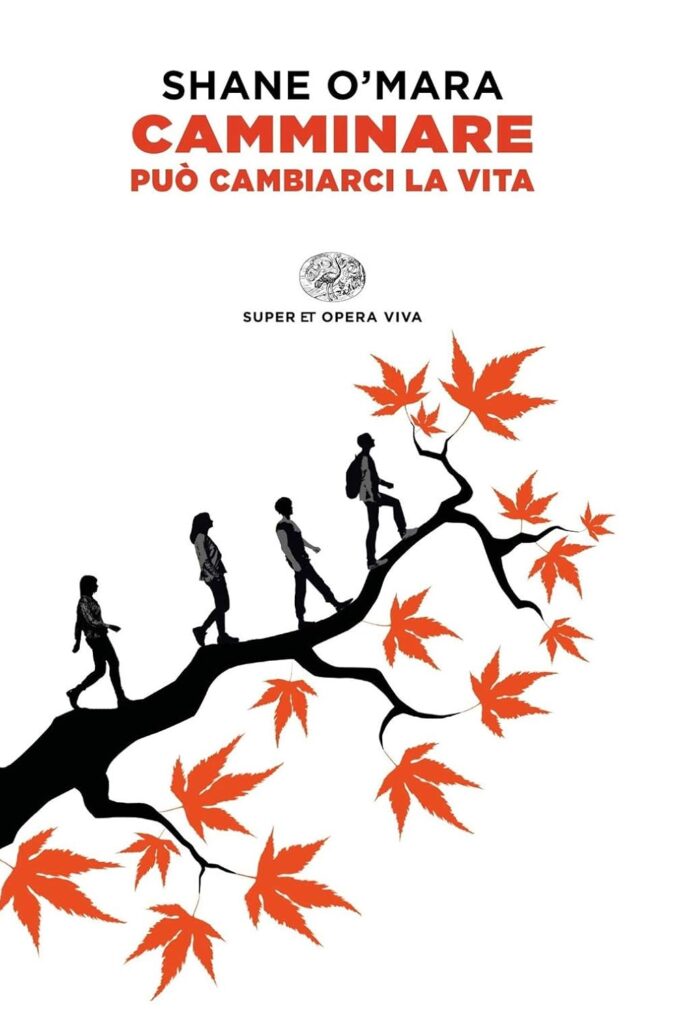
SINTESI DEL LIBRO:
Trascuriamo a nostro rischio e pericolo i vantaggi per la salute,
l’umore e la lucidità mentale che possiamo ottenere camminando.
Ormai molti di noi vivono in ambienti estremamente innaturali e
passano gran parte della giornata seduti con gli occhi fissi su uno
schermo posizionato a mezzo metro di distanza. Quando ci alziamo,
ci sgranchiamo e ci muoviamo, la nostra postura cambia: il torso e la
colonna vertebrale si spostano su un singolo asse verticale che
parte dalla testa, passa per la schiena e arriva a terra attraverso le
gambe e i piedi. Quando stiamo seduti, invece, il peso del tronco si
concentra principalmente sulla zona lombare e, in particolare, sul
coccige, un gruppetto di ossa che comprende i resti della coda1. Al
coccige è ancorato un notevole reticolo di tendini e muscoli che si
estendono lungo la spina dorsale e soprattutto nella parte alta delle
gambe, ad esempio i glutei, che sono essenziali per camminare.
Non stupisce che il dolore alla bassa schiena sia uno dei disturbi piú
diffusi nel mondo sviluppato.
Quanto è assurdo, dunque, che la soluzione – alzarsi dalla sedia
con regolarità e gironzolare – sia presa cosí poco in considerazione.
Lunghi periodi di immobilità hanno effetti sui muscoli, che sviluppano
al loro interno depositi di grasso e con gli anni vanno incontro a una
riduzione della massa (sarcopenia). E non solo: incidono anche sulla
pressione sanguigna e il tasso metabolico (il tasso a cui
consumiamo energia). Ma appena ci alziamo la situazione muta a
livello sia fisico sia mentale: diventiamo «cognitivamente mobili», la
testa gira a destra e a sinistra, gli occhi sfrecciano da una parte
all’altra. L’attività cerebrale si modifica e compaiono ritmi elettrici
prima quiescenti. Siamo piú vigili, la respirazione accelera, cervello e
corpo sono pronti all’azione. Non è un caso che il filosofo francese
Jean-Jacques Rousseau abbia scritto nelle sue Confessioni: «Non
riesco a meditare se non camminando. Appena mi fermo, non penso
piú, e la testa se ne va in sincronia coi miei piedi» 2.
Io, invece, racconterò a questo proposito una storiella. Sono a
una conferenza studentesca a Belfast durante i tetri e
apparentemente infiniti anni Ottanta. Prendo Malone Road, andando
in direzione nord, oltrepasso la Queen’s University e arrivo in centro.
Supero diversi posti di blocco. Giovani soldati forniti di mitra
pattugliano la città e controllano le sporte in cerca di bombe e armi
da fuoco, parlando nervosamente tra di loro con accenti inglesi.
L’aria è carica di tensione. Sullo sfondo c’è la campagna contro
l’accordo anglo-irlandese condotta dal politico lealista Ian Paisley,
cosí come le terribili atrocità, i tanti omicidi e gli attentati dinamitardi.
La città, però, è viva. Una città è difficile da uccidere.
Quando torno con la mente a questa passeggiata durante il mio
primo viaggio a Belfast, ricordo di essere passato davanti all’Europa
Hotel, famoso in quanto teatro di numerose esplosioni. Poi ho girato
a est, puntando verso Botanic Avenue, e sono tornato indietro
facendo un giro largo e risbucando alle spalle dell’hotel. Perché
questo percorso? Semplicemente perché potevo: sta qui il bello dello
spostarsi a piedi. È sabato, di primo pomeriggio; il tempo è grigio e
minaccia pioggia. Vagabondando, capito per caso in Sandy Row,
l’epicentro lealista di Belfast. I murales sono straordinari, e un po’
inquietanti per una persona che viene dal tranquillo e pacifico sud.
Proseguo in fretta, imboccando poi Lisburn Road, e alla fine ritrovo il
posto su Malone Road in cui alloggio insieme agli altri studenti. A
Belfast una passeggiata è un tour in un passato che è tuttora
presente.
Condensati in questo piccolo aneddoto privato, ci sono molti degli
elementi che, anche se non sembra, contraddistinguono il
camminare: il viaggio nel tempo, i ricordi del giro fatto, la capacità di
orientarsi e cavarsela in un ambiente urbano sconosciuto, il piccolo
brivido di paura che ancora mi viene al pensiero dei posti di blocco e
dei murales. Ora sappiamo che i sistemi cerebrali relativi a tutte
queste funzioni sono in comunicazione costante e si sostengono a
vicenda. E, aspetto cruciale, non sono perfetti. La mia memoria
infatti mi ha ingannato leggermente. Ha semplificato il tragitto e
dimenticato particolari significativi. Nella mia testa Botanic Avenue in
pratica era davanti all’Europa Hotel. Non è cosí, come noto dando
un’occhiata alla cartina: rispetto alla facciata, è disposta ad angolo
acuto e si collega a Great Victoria Street, la strada su cui sorge
l’albergo, molto piú in basso. Strano, ma ho eliminato il grosso dei
dati sulla posizione relativa di Sandy Row e dell’Europa Hotel.
Sempre nella mia testa Sandy Row era direttamente dietro l’albergo
o quasi. Ma invece si trova piú a sud. A restarmi è un’idea sfumata
dell’essenza di luoghi e cose; nascosta da qualche parte nel cervello
non ho una fedele registrazione video di quel giro di tanti anni fa.
È questa la caratteristica chiave dei ricordi episodici e personali:
sono imprecisi, ridotti all’osso, si concentrano sul significato
serbando i punti salienti e ignorando il resto3. Intorno a noi ci sono
piú informazioni di quante possiamo coglierne, e anche piú di quante
ce ne servano. Come ci muoviamo, cosa guardiamo, con chi
parliamo, cosa proviamo camminando: sono componenti centrali di
ogni esperienza. Capita spesso che entrino nella nostra memoria
lasciando tracce. Non siamo cervelli disincarnati che viaggiano nello
spazio e nel tempo: sentiamo il terreno sotto i piedi, la pioggia in
faccia; forse scrutiamo nell’ignoto, ma cosí facendo ampliamo la
nostra conoscenza di questo mondo complesso. E nel frattempo
creiamo in silenzio ricordi riguardo ai luoghi che abbiamo visitato e
disegniamo mappe degli spazi attraverso cui siamo passati.
Alzarsi e camminare ha un’influenza sul nostro cervello e lo
possiamo dimostrare. Esiste un semplice esperimento ideato dallo
psicologo americano John Ridley Stroop, chiamato «test di Stroop»,
che serve a valutare il «controllo cognitivo»: in altre parole la facilità
con cui una persona riesce a indirizzare e controllare l’attenzione e il
pensiero4. In sostanza è un test in cui si devono riconoscere colori e
parole, ma con un trabocchetto. Guardando liste di nomi di colori
(«rosso», «verde», «blu», «nero», ecc.) stampati o nel colore
corrispondente («rosso» scritto in rosso) o in un colore diverso
(«rosso» scritto in verde), i partecipanti devono dire il colore della
parola piú in fretta che possono. In genere, quando la parola e il
colore da questa indicato sono congruenti, i tempi di reazione sono
rapidi e le risposte accurate. Quando invece sono incongruenti, i
tempi di reazione sono molto piú lenti. E se si svolge
contemporaneamente un altro compito la prestazione risulta
compromessa. Ad esempio, un partecipante può trovarsi a dover
dire il colore e intanto ascoltare con gli auricolari delle frasi
registrate, tenendosi pronto a premere un pulsante nel momento in
cui sente una determinata parola o espressione. L’effetto Stroop è
molto regolare e facile da osservare; secondo la spiegazione
classica, il test richiede che si presti attenzione selettiva a certi
aspetti dello stimolo visivo, sopprimendo attivamente l’attenzione
verso il resto (i suoi aspetti automatici, appariscenti, preminenti), per
poi selezionare e dare la risposta appropriata.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :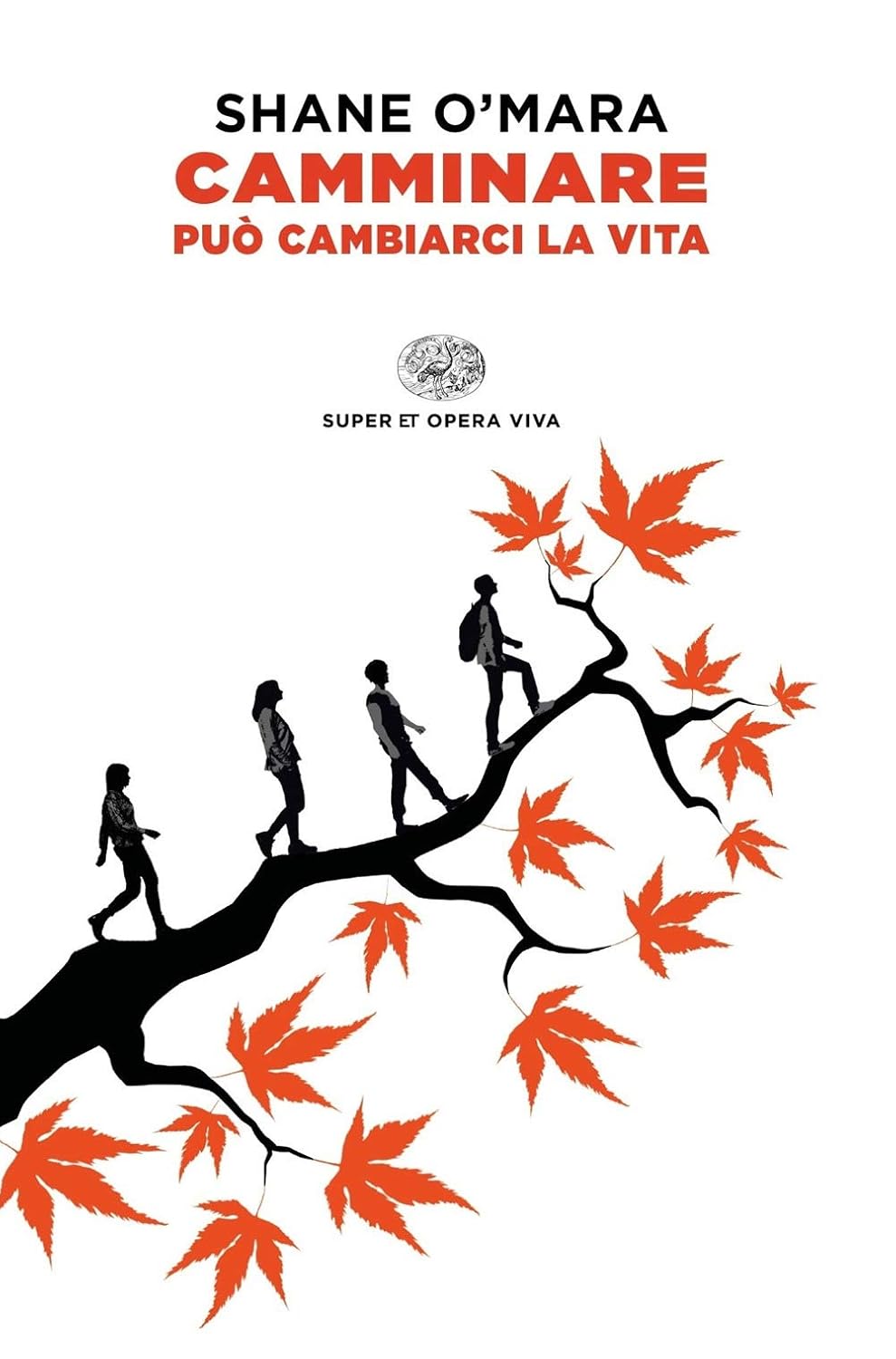






Commento all'articolo