1960 – L’Italia sull’orlo della guerra civile – Mimmo Franzinelli
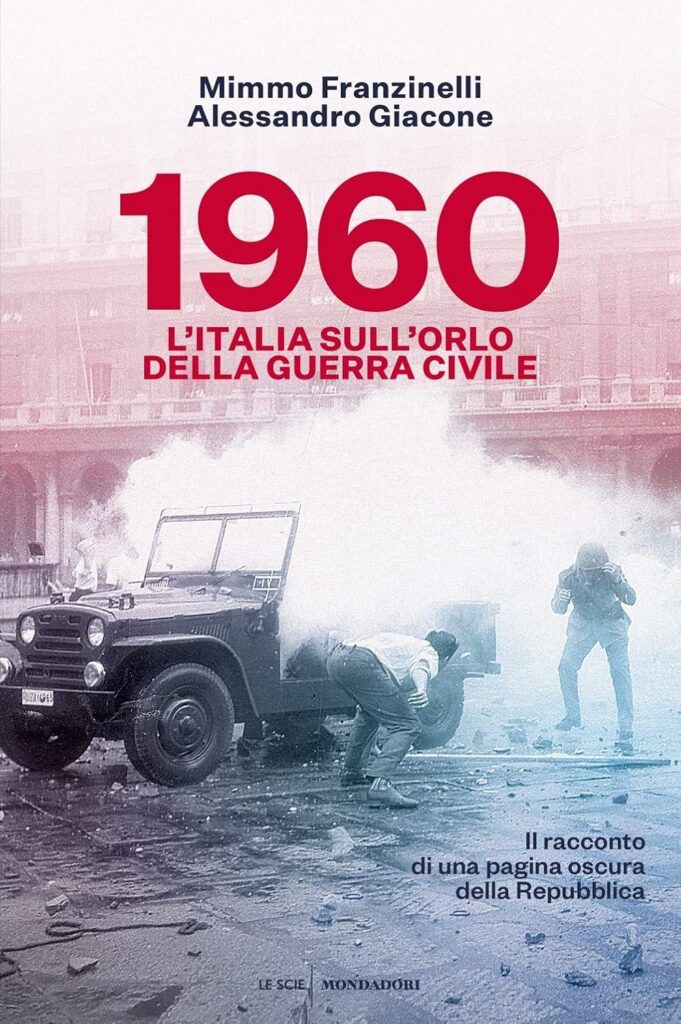
SINTESI DEL LIBRO:
Dal Partito popolare al fascismo
Fernando Tambroni Armaroli nasce il 25 novembre 1901 ad Ascoli
Piceno, in una famiglia aristocratica di tradizione ca olica (suo
padre Arturo, ultimo di quindici figli, dirige un istituto di
rieducazione giovanile). Studente liceale ad Ancona, presiede il
comitato studentesco «La Giovane Italia» di Ascoli, impegnato dopo
la disfa a di Capore o in iniziative solidaristiche per i «fanciulli
profughi dal Veneto». Nel marzo 1919 è tra gli organizzatori di una
manifestazione patrio ica nella sua ci à natale, in onore di un
gruppo di studenti profughi dalla Dalmazia. Contestualmente,
aderisce al Partito popolare italiano (PPI), fondato il 18 gennaio 1919
da don Luigi Sturzo, per affermare i prece i sociali della Chiesa.
Tambroni diviene segretario provinciale di Macerata, ci à in cui
frequenta la facoltà di Giurisprudenza. Nelle Marche, gli avversari
dire i dei popolari sono i socialisti, e nella fa ispecie Francesco
Quarantini, ele o deputato nel novembre 1919 nella circoscrizione
Macerata-Ascoli Piceno; personaggio violento e di dubbia moralità
(l’anno successivo dovrà ritirarsi dalla politica, perché isolato dai
suoi stessi compagni), durante un contraddi orio col giovane
Tambroni – trovatosi a corto di argomenti – lo aggredisce revolver
alla mano. Trasferitosi all’università di Roma, nel 1923 Tambroni
diventa vicepresidente nazionale della Federazione universitaria
ca olica italiana (FUCI), presieduta da Giuseppe Spataro (di lì a
trentase e anni, sarà suo ministro dell’Interno). Dentro il Partito
popolare, si schiera con l’ala di sinistra e contrasta le posizioni
moderate dell’onorevole Umberto Tupini.
Laureatosi in quello stesso anno, svolge il praticantato nello
studio legale Giardini, il più a sinistra tra quelli esistenti ad Ancona,
sebbene frequentato da clienti facoltosi (poveri e nullatenenti
o engono peraltro il patrocinio gratuito).1
So o la guida di Augusto Giardini, il giovane Tambroni si
specializza nel campo penale e insieme al suo maestro difende i
«sovversivi» coinvolti nella rivolta antimilitarista di Ancona del
giugno 1920. In questa fase, militanza politica e impostazione
professionale sono in rapporto armonico. Tambroni mantiene
l’impegno politico anche dopo l’involuzione di atoriale del gennaio
1925, quando Mussolini – superata la crisi provocata dal deli o
Ma eo i – colpisce duramente le opposizioni con misure di polizia.
La sera del 31 o obre 1926, verso la fine della visita a Bologna di
Mussolini, il quindicenne Anteo Zamboni lo sfiora con una
revolverata. La reazione fascista è terribile: il ragazzo viene linciato
sul posto e si scatena nel Paese la più estesa e selvaggia violenza
contro gli avversari del regime.2
A Cagliari, quella stessa no e, centinaia di esagitati assediano
l’abitazione del deputato del Partito sardo d’Azione Emilio Lussu,
urlando «A morte Lussu!»; quando tentano di irrompere dalle
f
inestre, il primo assalitore a me er piede sul balcone viene freddato
da una revolverata e i suoi camerati fuggono precipitosamente
(Lussu verrà arrestato per omicidio: prosciolto dalla magistratura
con il riconoscimento della legi ima difesa, sarà assegnato al
confino).3
Per alcuni giorni, migliaia di oppositori – considerati complici
morali degli a entatori del duce – vengono insultati, malmenati e
sequestrati dalle Camicie nere. A raverso intimidazioni e soprusi si
pretendono la so oscrizione di omaggi al duce e umilianti
so omissioni al regime. In un clima cupo e minaccioso, viene meno
ogni spazio di dissenso politico.
è
Fernando Tambroni, in quanto segretario provinciale di Macerata,
tra i potenziali bersagli. Scorrendo il principale quotidiano
marchigiano, s’intuisce il profilarsi e poi lo scatenamento della
tempesta che presto lo colpirà: sulla prima pagina del numero del 3
novembre, campeggia su sei colonne il titolo Il popolo italiano deve
p gg
p p
pretendere dal Governo fascista l’istituzione della pena di morte e la formale
promessa al Duce di non esporre troppo facilmente la sua vita al pericolo.
Il 5 novembre il ministro della Giustizia Alfredo Rocco presenta
un disegno di legge con misure liberticide: l’istituzione di un
tribunale politico composto dai comandanti della Milizia fascista, lo
scioglimento di tu i i partiti a eccezione del Partito nazionale
fascista, la chiusura dei giornali «che esplicano azione contraria al
regime», gravi sanzioni per gli espatri clandestini, l’invio dei
dissidenti al confino di polizia.
Tre giorni più tardi – in violazione dell’immunità parlamentare
vengono arrestati Antonio Gramsci e gli altri deputati del PCI.
L’indomani, 9 novembre, la Camera in seduta straordinaria dichiara
(con 332 voti contro 10) la decadenza dei 124 deputati delle
opposizioni e approva i «Provvedimenti per la difesa dello Stato»,
con la reintroduzione della pena di morte e l’istituzione del
Tribunale speciale.
L’approvazione delle «leggi fascistissime» non fa cessare le
violenze, che dalle principali ci à si estendono alle località di
provincia e anche alle borgate fuori mano, dove gli antifascisti più
noti cercano scampo. Comunisti, socialisti, popolari, repubblicani e
anarchici restano a lungo nell’occhio del ciclone.
Anche il PPI, che pure aveva aderito al primo governo Mussolini
(fino al congresso di Torino, nell’aprile 1923, quando venne deciso il
disimpegno), viene sciolto e i dirigenti perseguitati. Alcide De
Gasperi, ex segretario nazionale, rifugiatosi a Borgo Valsugana, suo
paese natale, a inizio novembre deve allontanarsene furtivamente col
fratello Augusto; i due fuggiaschi sono sequestrati a Bassano e
condo i a Vicenza, dove vengono «interrogati» su questioni
politiche e poi rilasciati. Da Milano, il 7 novembre Alcide scrive ai
famigliari: «Sono avventure che non si dimenticano. Non so cosa
stamperanno i giornali, ma ho la coscienza di non aver mancato alla
dignità e alla verità».4 Resoconti tendenziosi vengono diramati
dall’Agenzia Stefani e dai giornali fascisti, incluso il quotidiano
mussoliniano «Il Popolo d’Italia», per avvalorare la so omissione di
De Gasperi al regime, ma sopra u o per squalificare moralmente un
avversario tra i più autorevoli:
L’onorevole De Gasperi definì l’onorevole Mussolini uomo necessario alla vita e
alla grandezza della Nazione, fece l’elogio del Regime per la indipendenza
economica che riuscirà di supremo vantaggio al Paese, disse che l’a entato
contro il Primo Ministro era un deli o verso la Patria e l’ordine sociale, infine
fece calde lodi della politica religiosa del Governo Fascista chiamandola per la
sua concezione moralmente superiore a quella di tu i i precedenti Governi. 5
Nella speranza di smontare l’abile mistificazione, De Gasperi
invia l’11 novembre una re ifica a numerosi giornali: «Accanto al
riconoscimento di alcuni aspe i della vita politica fascista e alla
condanna degli a entati dal punto di vista morale e politico, esposi
con perfe a lealtà le linee fondamentali di dissenso, quale l’ho
sempre pensato».6 Disposizioni censorie vietano la pubblicazione
della re ifica e pertanto De Gasperi spedisce la sua le era a una
quarantina di personalità politiche: dal ca olico Filippo Meda al
socialista Filippo Turati.
Di analoghi soprusi – a uati in tu o il Paese, con maggiore
durezza nell’Italia centrose entrionale, contro i più noti esponenti
dei partiti d’opposizione – è vi ima il 12 novembre Fernando
Tambroni, ca urato e percosso dalle Camicie nere all’indomani del
fallito a entato bolognese. Nel suo studio di avvocato – preso
d’assalto e vandalizzato – viene sequestrato l’archivio della
Segreteria provinciale del PPI, materiale che dimostra la sua
contrarietà al fascismo, come pure le foto di due «martiri» della
violenza squadrista: il sacerdote ravennate don Giovanni Minzoni e
il deputato socialista Giacomo Ma eo i (rispe ivamente assassinati
il 23 agosto 1923 e il 10 giugno 1924). Su due piedi, gli s’impone la
scelta tra l’adesione al regime e ulteriori violenze. Aonito e
scoraggiato, firma la le era presentatagli dal federale fascista di
Ancona, Giuseppe Avenanti, e da questi fa a pubblicare il 13
novembre sul quotidiano di Ancona «Corriere Adriatico», per
squalificare moralmente l’ex dirigente del PPI e far risaltare la forza
del fascismo anconitano:
L’Ufficio Stampa della Federazione Provinciale Fascista comunica:
L’avv. Fernando Tambroni, già Segretario Provinciale del Partito Popolare, ha
oggi rilasciato nelle mani del Triumviro Federale rag. Avenanti la seguente
dichiarazione:
Il so oscri o dichiara sul suo onore di ci adino e di Italiano di abiurare la sua fede
politica nel disciolto Partito Popolare e di disinteressarsi di ogni e qualsiasi forma di
a ività che sia comunque in contrasto col volere e il pensiero del Regime Fascista che
rappresenta oggi la Nazione risorta nella coscienza di sé stessa.
Quanto oggi il so oscri o afferma è la conclusione logica del suo a eggiamento
politico da più di un anno a questa parte, a eggiamento alieno da ogni a ività di
pensiero e di opera, pubblicamente e privatamente esplicato ed espresso.
Dichiara inoltre che i de ami del Regime i quali hanno riconosciuto come forza
spirituale ed elevatrice del popolo Italiano la Religione Ca olica, identificano il suo
passato e il suo presente di ca olico ai futuri destini della Patria.
Riconosce in S.E. Benito Mussolini il restauratore della Patria Italiana, l’uomo
designato dalla Provvidenza di Dio a forgiare la grandezza di un popolo, al cospe o del
mondo.
Avv. Fernando Tambroni 7
Sebbene estorto con l’intimidazione, quel documento macchia in
maniera indelebile la biografia del politico marchigiano: nel secondo
dopoguerra i suoi avversari lo citeranno – decontestualizzato e con
interpolazioni – per nuocergli e infangarne l’immagine.
Curiosa, nella chiusa del documento, l’espressione «Mussolini
uomo della Provvidenza», destinata a diventare celeberrima dal 13
febbraio 1929, quando Pio XI omaggerà l’artefice dei Pa i
Lateranensi, nell’udienza a docenti e studenti dell’Università
ca olica del Sacro Cuore, con queste parole: «E forse ci voleva anche
un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fa o incontrare; un
uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale, per gli
uomini della quale tu e quelle leggi, tu i quegli ordinamenti, o
piu osto disordinamenti, tu e quelle leggi, diciamo, e tu i quei
regolamenti erano altre anti feticci e, proprio come i feticci, tanto
più intangibili e venerandi quanto più bru i e deformi».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :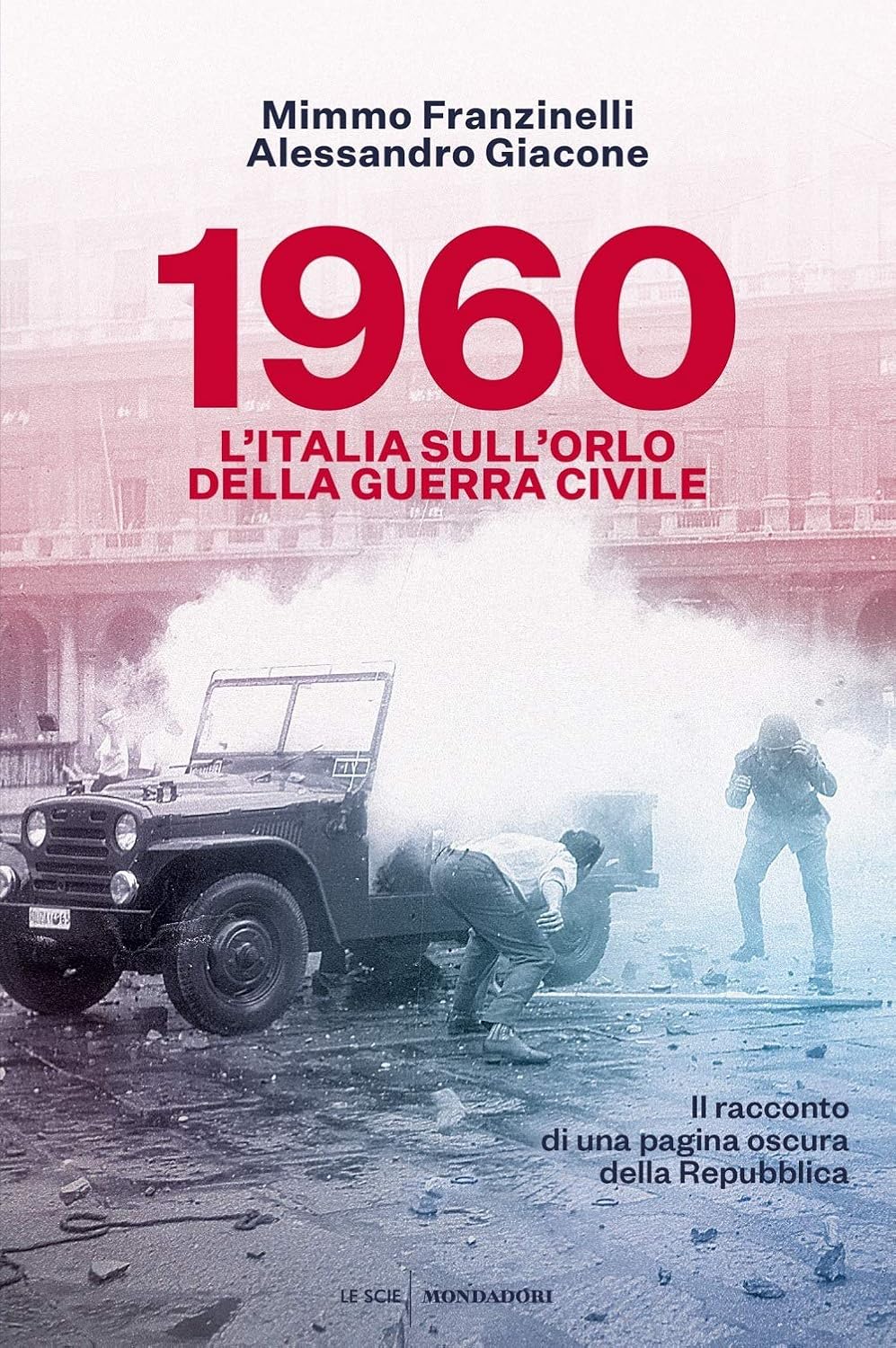






Commento all'articolo