Una strage semplice – Nando Dalla Chiesa
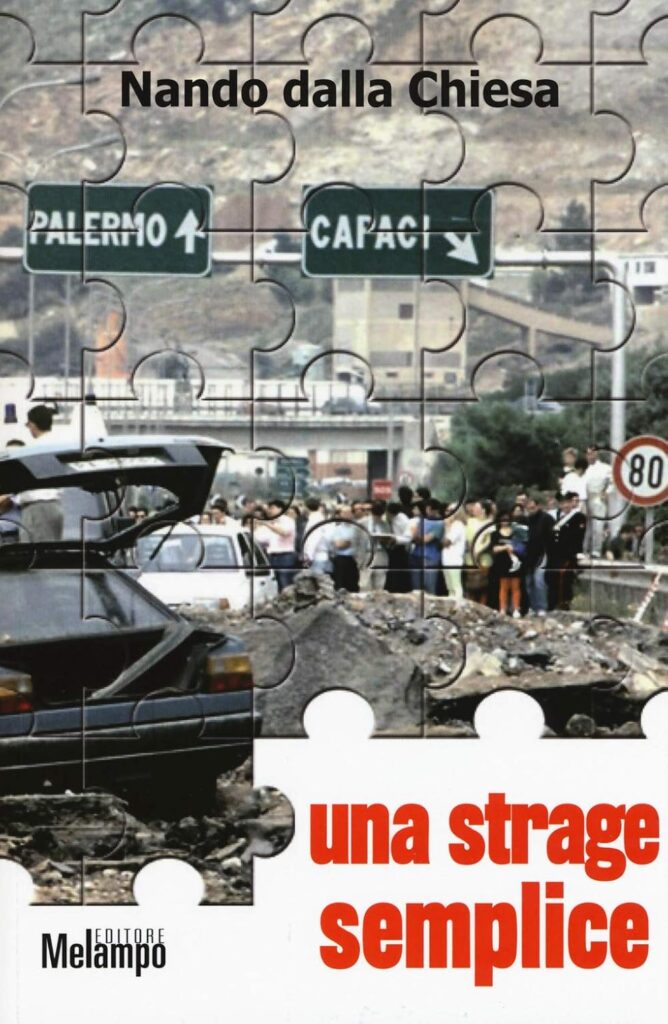
SINTESI DEL LIBRO:
Ma che cosa accadde in quei giorni impazziti e mai prima vissuti?
Quando la legge prometteva le sue rivincite a Milano ma sembrò, tra
spaventose immagini di guerra, che non avesse diritto di esistere in Sicilia?
Lì il palazzo di giustizia di “Mani Pulite”, dei trionfi e delle confessioni, qui
il palazzo di giustizia dei veleni e dei lutti mai dimenticati. Due scenari in
apparenza così lontani, l'uno l'opposto dell'altro, e invece, come vedremo,
così assurdamente e segretamente vicini. Come mai? Che cosa precipitò una
città nella disperazione e un Paese intero nello sgomento? Furono due stragi
o una strage sola? In queste pagine si sceglierà la seconda risposta. E si
cercherà di spiegarne le ragioni. Attraverso una ricostruzione diversa di
quello che già si sa: perché non fu solo la consueta combinazione di mafia,
politica e servizi segreti.
Una strage può essere infatti raccontata in tanti modi. Imbalsamandola
nella retorica. Facendone una storia senza memoria. Avviene spesso.
Oppure, e avviene altrettanto spesso, inseguendo i misteri insoluti che
restano dietro gli autori materiali, se questi sono stati scoperti. Formulando
e poi allineando interrogativi, progressivamente amplificati e allungati dalle
dietrologie che si specializzano nel tempo. Nella convinzione che in fondo a
un interrogativo, ogni volta diverso, possa alla fine comparire la “vera
verità” che altri non hanno visto.
Con la strage in due atti di Palermo 1992 sono accadute e accadono
entrambe le cose. Tutte e due comprensibili. La prima per l'amore che si
porta alle immagini dei due giudici, che quasi assorbe il dovere della
memoria. La seconda per un bisogno insoddisfatto di sapere e di capire, che
porta a moltiplicare gli interrogativi. I quali però, in simmetria con la
retorica, hanno finito per far velo alla verità di fondo, quella che
storicamente importa, impedendole di emergere nella sua potenza.
Potremmo ad esempio discutere a lungo, e senza mai venirne a capo, di
quale fosse il “vero” ordine dato agli assassini di Giacomo Matteotti nel
1924. Di quali dinamiche “vere” siano intercorse tra il suo rapimento e il
ritrovamento del suo corpo. C'è però una verità storica che ha una sua
indiscussa solarità, e che tutto sovrasta: Matteotti fu ucciso dal regime
fascista per la sua azione di denuncia in parlamento.
La strage di Capaci del 23 maggio del 1992 ha anch'essa una sua logica
chiara e indiscutibile, purché la si voglia inserire dentro la lunga storia in
cui avvenne. E purché di questa storia si sappiano cogliere e ordinare i fatti,
talora i dettagli, che contano. Quella che portò a morte Giovanni Falcone fu
una strage semplice. Che non fermò la sua logica a Capaci, ma la spinse
fino a via D'Amelio. Per portare a morte anche Paolo Borsellino.
Avvicinandosi un passo dopo l'altro, senza fermarsi mai, in anni che
alternarono senza fine risveglio e sgomento, speranza e dolore. Una strage
che avanzò grazie alle sconfitte e grazie alle vittorie, indifferentemente,
delle sue vittime designate. Con una linearità che ebbe qualcosa di epico e
implacabile, dentro una grande recita corale. I misteri successivi, l'agenda
rossa, gli uffici dei servizi segreti a monte Pellegrino, gli incontri tra
esponenti dello Stato e ambasciatori di Cosa Nostra, fanno parte di un
grande e sconfinato scenario secondario: quello che riguarda il “chi
precisamente” e il “come”. Ma il quando, il perché, il chi “grande”, sono a
nostra disposizione. E non sempre, anzi quasi mai, ce ne rendiamo conto.
Questo libro vuole ricostruirlo e ricordarlo. Sulla spinta di una complicata
combinazione di sentimenti e di bisogno di testimonianza civile. Procede
per sintetici riferimenti storici, seleziona per abitudine mentale i principali
elementi di contesto (un contesto insostenibile, talvolta impietoso) e prova a
coordinarli tra loro chiedendo più volte aiuto alla memoria; una memoria,
anche visiva, resa viva dalla partecipazione intensa, a vario titolo, agli
avvenimenti di quegli anni e ai duri conflitti che li segnarono. Cerca di tirar
fuori la doppia strage di Palermo-Italia 1992 sia dalla retorica sia dal
mistero. Per consegnare a chi non c'era la storia che tutti potettero vedere. E
per ricordare a chi c'era che l'inarrestabile destino fu in realtà il frutto di una
lunga opera collettiva. Nella convinzione che a questi due obiettivi non si
possa rinunciare.
Italia
“Chistu si metterà l'Italia nelle mani”. Così sibilò Salvo Lima ad Angelo
Siino, commentando la chiamata del giudice Giovanni Falcone alla guida
della Direzione Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia, retto dal
ministro Claudio Martelli. Sette parole. Una profezia sinistra. In cui stava
tutto il senso della storia luminosa e terribile che racconteremo. Quella
nomina, giunta come un fulmine nell'anno del Signore 1991, avrebbe
scompigliato le carte con cui un intero sistema di potere, da Palermo a
Milano, si era abituato a giocare.1 Il dialogo di cui stiamo parlando avvenne
una sera d'inverno al decimo piano di un grattacielo nel centro di Palermo.
Uno di fronte all'altro due protagonisti della zona di libero scambio tra
mafia e politica. Salvo Lima era il dominus della Democrazia Cristiana in
Sicilia, rappresentante per antonomasia di Giulio Andreotti, l'uomo politico
più potente nella storia della Repubblica. Conosceva bene il mondo e le
dinamiche profonde della mafia, tra le quali era riuscito a navigare con
sapienza, militando nella corrente fanfaniana e poi in quella andreottiana.
Era uscito indenne dal conflitto che aveva portato, nella sua Palermo, allo
sterminio della vecchia mafia agli inizi degli anni ottanta. Si era procurato
un salvacondotto di prestigio con l'approdo, nel '79, al parlamento europeo,
sospinto da una valanga di voti. Negli anni precedenti era arrivato ai gradi
di sottosegretario alle Finanze e di sottosegretario al Bilancio, ministeri
chiave per amministrare le regole del potere. Nonostante gli attacchi subiti
da parte dell'opposizione comunista, che ne aveva inciso a forza il nome
negli atti della Commissione parlamentare antimafia,2 era stato perfino
protagonista, come il suo leader nazionale, di aperture verso il Pci del
compromesso storico e anche negli anni successivi.3 Forse non fu mafioso,
Lima. Ma certo fu amico e massimo referente politico della mafia siciliana.
Nonché grande teorico della corruzione, e del consenso che ne derivava.
“Chi non mangia non fa briciole” era il suo motto.
A sua volta Angelo Siino, l'uomo al quale egli rassegnò quella breve e
preoccupata, ma anche minacciosa, profezia su Falcone, esercitava in Cosa
Nostra una funzione davvero speciale: quella di “ministro dei lavori
pubblici”. Anche Siino aveva fiuto politico e alle spalle una lunga militanza
democristiana; e anch'egli era riuscito a trovare nei tempi del terrore e della
mattanza i giusti punti di equilibrio nell'universo mafioso.4 Pure lui
conosceva il potere nazionale, o almeno il suo versante economico e
imprenditoriale, avendovi acquisito una certa dimestichezza nell'esercizio
del proprio mandato, che lo metteva ripetutamente in contatto non solo con
le maggiori imprese siciliane ma anche con i grandi gruppi del Nord.
Testimone di quel dialogo segreto fu un terzo personaggio. Si chiamava
Ignazio Salvo e, come vedremo, anche lui ricopriva un ruolo di primissimo
piano nell'universo mafioso. Ma per capire perché Lima vivesse con tanta
preoccupazione la chiamata al ministero di un giudice che fino a quel
momento aveva dovuto muoversi all'interno della sua giurisdizione
palermitana, occorre riavvolgere all'indietro il film della storia. E tornare
agli anni di confine tra il decennio settanta e il decennio ottanta. A quando
in Italia prese forma il regime della corruzione, poi imploso nel '92 con il
nome di Tangentopoli. Occorre cioè sapere il contesto grande in cui tutto
successe e che rende anzi possibile la nostra storia.
Di esso si occupò la grande letteratura prima ancora dei tribunali. Fu
infatti nel 1980 che Italo Calvino scrisse su “Repubblica” il suo celebre
Apologo sull'onestà. Narrando che cosa fosse diventata l'Italia della
modernizzazione industriale e delle grandi conquiste civili:
“C'era un paese che si reggeva sull'illecito. Non che mancassero le leggi,
né che il sistema politico non fosse basato su principi che tutti più o meno
dicevano di condividere. Ma questo sistema, articolato su un gran numero
di centri di potere, aveva bisogno di mezzi finanziari smisurati (ne aveva
bisogno perché quando ci si abitua a disporre di molti soldi non si è più
capaci di concepire la vita in altro modo) e questi mezzi si potevano avere
solo illecitamente cioè chiedendoli a chi li aveva, in cambio di favori
illeciti. Ossia, chi poteva dar soldi in cambio di favori in genere già aveva
fatto questi soldi mediante favori ottenuti in precedenza; per cui ne risultava
un sistema economico in qualche modo circolare e non privo d'una sua
armonia.”5
Rileggere oggi quello sfondo sociale, spiegare che cosa fosse accaduto e
che cosa stesse accadendo, non è semplice, tale fu il groviglio. Il paese che
si
reggeva sull'illecito era figlio di fatti tra loro diversi. A volte
sotterraneamente imparentati. Altre volte incommensurabili per natura. Ma
la cui somma generò sulla nazione un effetto profondo, quasi una
inavvertita svolta del suo stato politico.6 Li richiameremo perciò per rapide
pennellate. Il terrorismo, anzitutto. L'offensiva scatenata dalle sigle della
lotta armata e in particolare dalle Brigate Rosse aveva prodotto, oltre il
risultato più tragico (le centinaia di delitti e di lutti), anche risultati “di
sistema” a tutti evidenti. Il moto di partecipazione politica e la domanda
democratica della prima parte degli anni settanta avevano subito una gelata,
assottigliando di fatto gli spazi della critica politica. Stringersi intorno allo
Stato e alle sue istituzioni era stata la reazione naturale dei cittadini, tanto
più nel clima di pacificazione politica creato dalla strategia del
compromesso storico tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista.7 La
scommessa del cosiddetto Partito armato su un allargamento e una
acutizzazione del conflitto sociale aveva perso senza appello. Gli scandali
dei primi anni settanta vennero così dimenticati. Da quello dei petroli8 fino
a quelli che avevano toccato l'Iri, l'Istituto per la ricostruzione industriale, e
perfino, con la vicenda delle tangenti Lockheed (per acquisto di aerei
militari), il presidente della Repubblica Giovanni Leone.9 Al riparo delle
immagini di apertura di giornali e tivù, traboccanti ogni giorno di morti e
feriti di terrorismo, il Palazzo pasoliniano andò sperimentando nuove strade
e strategie per sistemare i conti con gli scossoni ricevuti dagli anni della
grande contestazione. Le stragi neofasciste suggerite e protette dalle celebri
“istituzioni deviate” non erano bastate. Nacque così, a ricacciare indietro
l'onda lunga del cambiamento, un sistema di potere occulto, quello della
loggia massonica P2, teso a riorganizzare gli assetti dello Stato e della
società civile. Che trovò velocemente una sua naturale consonanza con altri
poteri occulti e illegali puntando diritto alla conquista delle istituzioni.10 In
un breve grumo di anni, sui quali si impresse, sopra tutti, il marchio
drammatico del delitto Moro, l'Italia si trovò trasferita su un altro versante
della propria storia.11 I raccordi tra i vertici istituzionali e l'intrico dei
mondi illegali si manifestarono nella storia esemplare dell'assassinio di
Giorgio Ambrosoli, l'avvocato liquidatore, per conto della Banca d'Italia,
della Banca Privata Italiana del finanziere siculo-milanese Michele
Sindona, legato sia alla mafia sia alla P2. Ambrosoli fu forse la prima
vittima del regime della corruzione, il primo corpo estraneo immolatosi sul
fronte della legalità. Avvenuto nel luglio del 1979, il delitto suggellò una
lunga attività di accerchiamento e di intimidazione nei confronti
dell'avvocato, condotta da Cosa Nostra per conto dello stesso Sindona (il
“salvatore della lira” nella indimenticabile definizione di Giulio Andreotti),
e durante la quale il capo del governo del compromesso storico e della lotta
al terrorismo – Andreotti, appunto – aveva mantenuto rapporti complici con
il finanziere, latitante negli Stati Uniti.12 L'Italia si ritrovò letteralmente in
una morsa. Finanza sporca, P2, mafia, pezzi di governo ufficiale, intrecciati
da una parte. E terrorismo dall'altra parte. Vinse faticosamente la sfida con
quest'ultimo. Non vinse la sfida con l'altro fronte, nonostante l'esplosione
dello scandalo della P2, innescato nel 1981 da una ispezione condotta dai
giudici istruttori milanesi Gherardo Colombo e Giuliano Turone nella
residenza di Licio Gelli, nell'ambito dell'inchiesta su Sindona.
Già questo grumo di anni sarebbe dovuto bastare perché nel Paese si
imponesse una svolta radicale dei costumi pubblici. Ma l'illegalità si stava
facendo metastasi. Subito dopo quello di Sindona giunse un altro caso
esemplare degli intrecci criminali in corso nel Palazzo. Ne fu protagonista
Roberto Calvi, alla guida del Banco Ambrosiano e vicepresidente della
Bocconi, fiduciario a un tempo della finanza laica e della finanza cattolica,
grazie ai rapporti privilegiati con lo Ior, l'istituto di credito del Vaticano.
Soprannominato “il banchiere di Dio” e piduista anch'egli, Calvi venne
indagato sempre dai giudici Colombo e Turone per il clamoroso crack del
Banco. La sua provvisoria carcerazione a Lodi, seguita da un tentativo di
suicidio, provocò una durissima reazione in parlamento.
Il discorso tenuto in sua difesa nell'aula di Montecitorio da Bettino Craxi,
carismatico leader del Partito Socialista, fu un vero attacco ai giudici della
Repubblica. “Il tentato suicidio del banchiere Calvi ripropone con forza il
problema di un clima inquietante, di lotte di potere condotte con
spregiudicatezza e violenza intimidatoria […] Quando si mettono le
manette a finanzieri che rappresentano in modo diretto o indiretto gruppi
che contano per quasi metà del listino di Borsa, è difficile non prevedere
incontrollabili reazioni psicologiche e varchi aperti per le correnti
speculative”.13 La legge come forza eversiva: fu forse lì che per la prima
volta si materializzò ufficialmente quell'idea. Lì che prese forma il conflitto,
che non si sarebbe più richiuso, tra il sistema di potere e il principio
costituzionale dell'indipendenza della magistratura. Da un lato il potere
politico, per definizione quintessenza della democrazia, e il potere
economico, garante di sviluppo e occupazione, dall'altro i giudici
“comunisti”, secondo l'accusa già lanciata da Sindona da oltreatlantico.
Calvi, una volta libero, concluse i suoi giorni, come è noto, nel giugno
dell'82, “suicida” sotto il Ponte dei frati neri a Londra. Verosimilmente
punito da Cosa Nostra per avere raggirato (sottovalutandoli) quei mafiosi
con la seconda elementare che gli avevano affidato una montagna di capitali
freschi di eroina.14
La legalità, i giudici come nemici. Non era dunque un pensiero esclusivo
di Salvo Lima, Ignazio Salvo o Angelo Siino, ecco l'importanza di sapere il
contesto. Era un pensiero ampio. Esprimeva in fondo la rottura definitiva
del binomio tipico di ogni democrazia borghese: Law and Order. La legge,
ora, si collocava su un versante, l'ordine sociopolitico sull'altro. E non
avveniva solo di fronte alla P2 o alla finanza spericolata. Avveniva anche
nella normale amministrazione politica. Al Sud come al Nord. Qui
esplosero insieme due scandali rivelatori.
Il primo fu nella Torino della Fiat, dove nel 1983 proprio sulla legalità si
consumò una memorabile rottura tra il sindaco comunista Diego Novelli e il
Partito Socialista. Quest'ultimo uscì polemicamente dalla giunta di sinistra
protestando contro la decisione del sindaco di indirizzare alla magistratura
un imprenditore che denunciava un giro di tangenti riguardante alcuni
assessori socialisti. Il sindaco fu accusato da Craxi, ma anche da una parte
del suo partito a Roma, di non avere risolto la questione “per via politica”.
Sembravano saltare i riferimenti morali della vita pubblica. Uno degli
assessori coinvolti si avventurò perfino nei campi arditi della teoria
ribattezzando
libera
democrazia conflittuale quella in cui si
contrapponessero i codici e le scelte politiche.
Il secondo caso fu a Savona, dove un giovane giudice napoletano,
Michele Del Gaudio, incriminò di diversi reati, tra cui il neonato 416 bis
(associazione mafiosa), il presidente socialista della Regione Liguria Mario
Teardo, soprannominato dai suoi fedelissimi “Padre santo”, ormai a un
passo dall'elezione in parlamento. Teardo fu poi scagionato dall'accusa di
associazione mafiosa. Ma emerse una lunga vicenda amministrativa
costellata da episodi di corruzione, di intimidazione e di scoraggiamento
della concorrenza, anche attraverso l'uso classico e ripetuto degli incendi
nei cantieri. Ai carabinieri che lo arrestarono all'alba Teardo rimproverò di
applicare i metodi di Pinochet.15 Il fatto è che, come aveva denunciato
Calvino, la corruzione travalicava ormai la dimensione episodica e andava
organizzandosi in sistema senza accompagnarsi a sensi di colpa. Anzi,
com'egli notava, con una certa “armonia”, assorbendo nella sua orbita i
partiti di governo ma anche i partiti di opposizione, grazie a meccanismi di
ripartizione “democratica” (ossia secondo le percentuali dei partiti) dei
propri benefici. E più i partiti si accordavano sulla violazione delle leggi,
più sui “moralisti” di ogni schieramento incombeva il ricatto di “fare il
gioco” dell'avversario. Fu anche per rompere questa cappa soffocante che
nel 1985 nacque a Milano a opera di centouno personalità cittadine il
circolo “Società Civile”: spazio autofinanziato di denuncia nella ormai ex
capitale morale, dove l'organizzazione scientifica della tangente avrebbe di
lì a poco generato il fenomeno della “dazione ambientale
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :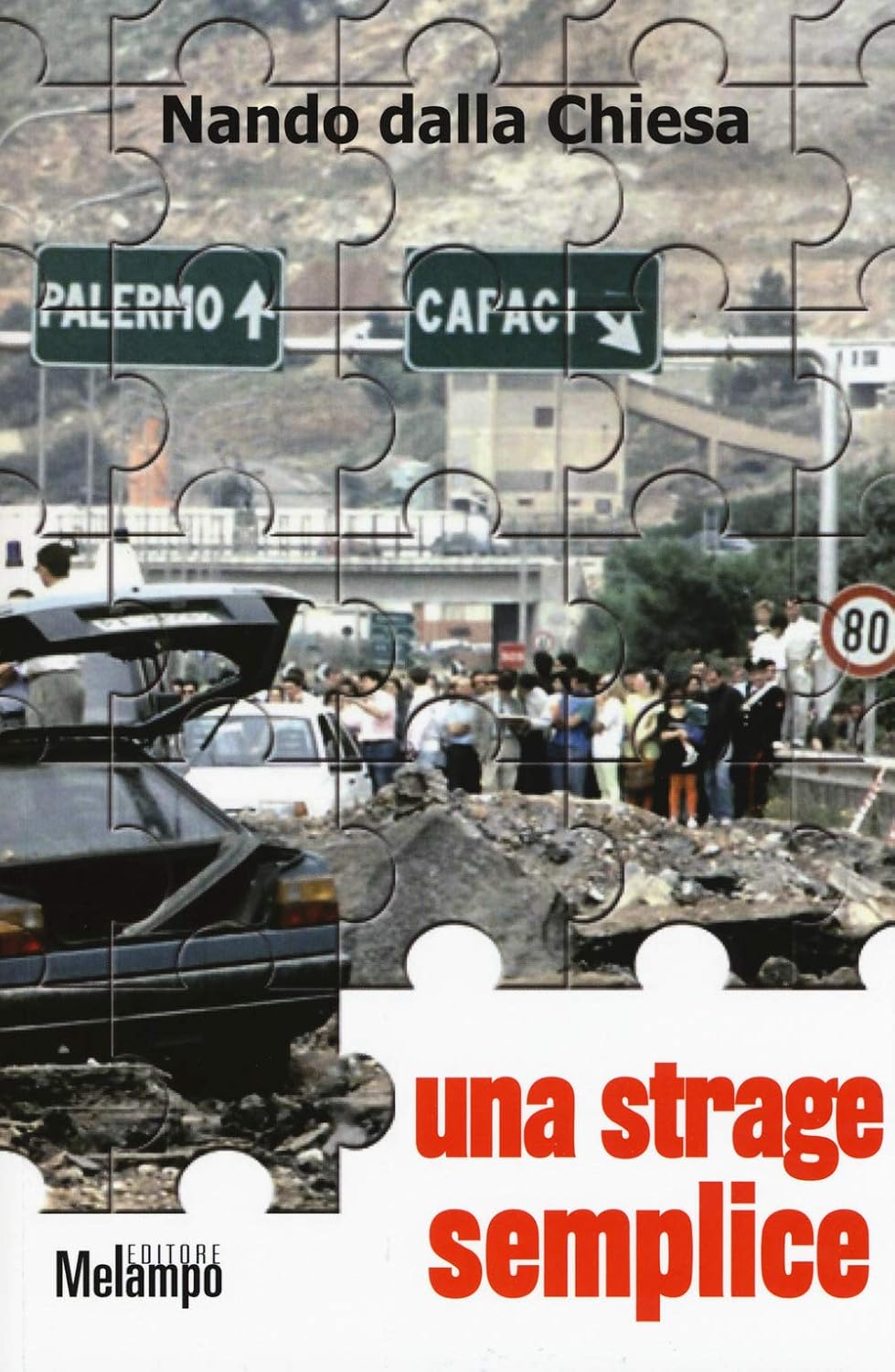






Commento all'articolo