Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso – Omar Onnis
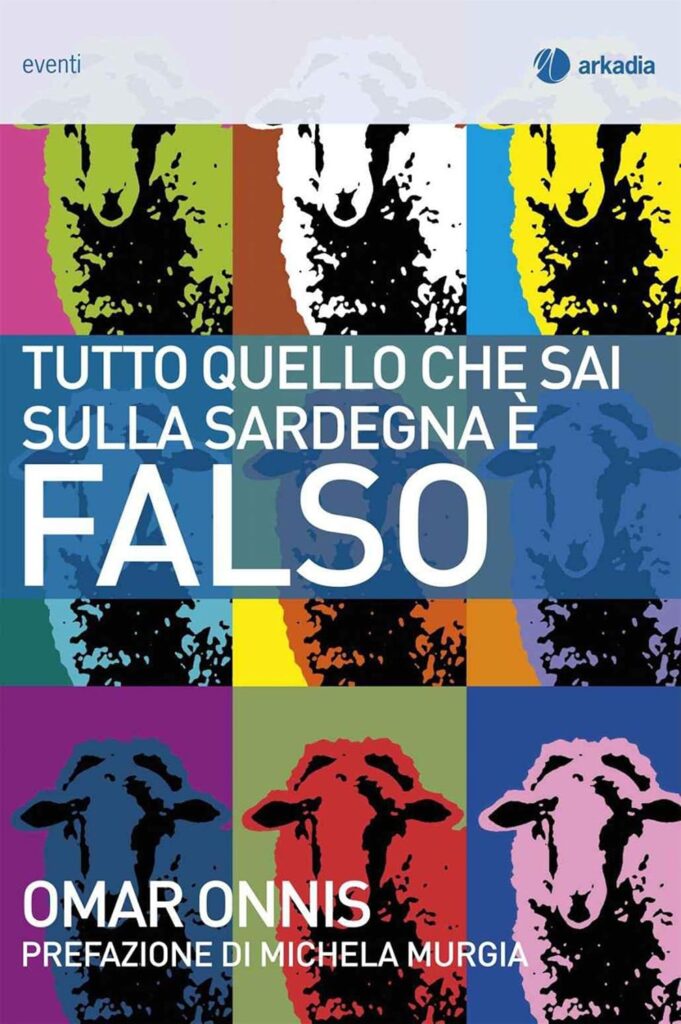
SINTESI DEL LIBRO:
Una leggenda nera un tempo diffusa presso le nostre comunità
vuole che, in un passato indeterminato, esistesse una figura
femminile a cui si demandava, in certi casi specifici, il compito di
porre fine alle lunghe agonie, liberando così l’anima dell’afflitto dai
vincoli terreni e sgravando la famiglia del suo mantenimento. Una
leggenda, appunto, su cui ultimamente si applicano due scuole di
pensiero contrapposte: quella che considera s’acabadora una figura
reale, una funzione sociale realmente incarnata da donne vere,
incaricate di tale incombenza, e dall’altra parte quella che nega
qualsiasi valenza storica e antropologica a questa figura,
relegandola nell’ambito dei racconti intorno al focolare.
In realtà non importa molto se un’acabadora sia mai esistita o no.
Ciò che conta è che questa figura ha fatto parte dell’immaginario dei
sardi. La sua è una funzione mitologica e ha a che fare con il
paradigma della figura femminile (madre, dunque depositaria della
vita, dunque depositaria della morte). Un paradigma oramai
ampiamente superato dai mutamenti culturali intervenuti negli ultimi
sessant’anni [→ Matriarcato].
Le polemiche sulla figura dell’acabadora stridono con la chiara
evidenza di una realtà culturale oramai del tutto emancipata dagli
stereotipi tradizionali, più complessa e variegata di quanto
pretendano il nostro mito identitario e chi lo perpetua. Di fatto, se
non fosse stato per un romanzo di successo, che ne sposta la figura
su un piano narrativo diverso, razionalizzandola e ricodificandola
secondo un gusto moderno, certamente ben pochi in Sardegna
avrebbero potuto conoscere anche solo il nome della acabadora. E
non ci sarebbe stato niente di male.
Agricoltura
La Sardegna è sempre stata una terra a vocazione agricola, dalla
rivoluzione del Neolitico (8000 anni fa circa) fino a pochissimi
decenni or sono. Non c’è fonte o documento antico, medievale o
moderno, che non ne decanti le potenzialità produttive, pur tenendo
conto delle difficoltà di tipo geologico, geografico e climatico nonché
delle durature incapacità dei governi. La densità di popolazione
dell’isola, mai particolarmente elevata, ha sempre consentito che la
disponibilità di suolo fosse largamente sufficiente alla sopravvivenza
dei sardi. A parte la qualifica di granaio di Roma, meritata
nell’antichità, basterà ricordare l’efficace politica monopsonista
(monopsonio = un solo acquirente; monopolio = un solo venditore)
del regno giudicale d’Arborea, le cui casse statali erano
abbondantemente rifornite dalla pratica di acquisire tutte le
eccedenze della produzione agricola per rivenderle all’estero, con
estremo ristoro della bilancia commerciale, e dunque delle possibilità
di investimenti (che consentiranno alla Sardegna arborense del XIV
secolo di tenere in scacco la potenza europea e mediterranea
emergente del periodo, il regno d’Aragona).
Anche nelle epoche successive, nonostante i fattori restrittivi del
clima e della primitività delle tecniche agricole, tipici per altro di
vastissime aree d’Europa per tutto l’Antico Regime, solo le calamità
naturali potevano compromettere un modello produttivo altrimenti
efficiente. Una delle ragioni del suo relativo successo era senz’altro il
perpetuarsi della proprietà indivisa del suolo e le potestà dei villaggi
in materia, vigenti persino sotto il feudalesimo iberico.
Nel Settecento, sulla scia del pensiero illuminista, gli osservatori
sardi e stranieri più aggiornati, di fronte alle potenzialità dell’isola,
segnalavano l’inefficienza di un sistema produttivo superato dai
progressi tecnici del secolo e per giunta sottoposto al fiscalismo
sabaudo e alla rapacità dei signori feudali (in quel periodo più liberi
dal dover patteggiare con le comunità locali, come invece era stato
consueto nel periodo spagnolo). Tuttavia, la vera crisi,
paradossalmente, il settore agricolo sardo ha cominciato a
conoscerla con la sua modernizzazione forzata, avviata nel corso
dell’Ottocento. Il cosiddetto “editto delle chiudende”, l’abolizione
degli usi civici, la privatizzazione della terra, non fecero altro che
polarizzare ulteriormente l’accesso alle risorse: da un lato un’esigua
minoranza che possedeva tutto, dall’altra la maggioranza della
popolazione che non possedeva più niente e non aveva più alcuna
voce in capitolo, neppure nelle questioni locali. Oltretutto,
l’accaparramento fondiario consentì ai nuovi padroni (che spesso
coincidevano con quelli vecchi, ma che avevano oramai maggiore
libertà d’azione) di destinare molti terreni agricoli al pascolo, da
affittare agli allevatori, a loro volta privati di aree libere e condivise a
cui accedere: una rendita sicura a fronte di investimenti minimi, se
non nulli.
È nell’Ottocento dunque che – come in altri ambiti – si genera la
vera crisi in Sardegna. Nel momento della grande svolta storica della
contemporaneità, della transizione demografica che trasferiva grandi
masse di persone e intere collettività dalla civiltà agricola a quella
industriale e avviava la rivoluzione sociale e politica a cui noi stessi
ancora apparteniamo, la Sardegna si trova imprigionata dentro
modelli produttivi rigidi e imposti dall’alto, rispondenti a logiche di
accumulo brutale e di sfruttamento cinico, senza la benché minima
controparte politica o culturale. L’agricoltura non poteva che subire
uno dei destini peggiori, in tale situazione. La stessa retorica della
Sardegna come terra povera, insufficiente a dare di che vivere ai
suoi stessi figli, nasce da lì. Non si parla mai di cattiva distribuzione
delle risorse, né di pessima gestione delle medesime. Prevale la
narrazione che vuole l’isola povera e avara per propria stessa
natura.
L’agricoltura viene piegata a forme di produzione lontane dalle
esigenze della popolazione. Col fascismo la Sardegna tornerà a
essere granaio di Roma e le stesse bonifiche risponderanno alle
esigenze non dei sardi ma dell’Italia autarchica. Nel secondo
dopoguerra, al momento di avviare gli investimenti del Piano di
Rinascita, lo Stato italiano li dirotterà interamente sul comparto
industriale, anziché su quello agricolo come era nelle previsioni di
chi aveva concepito quel disegno di intervento pubblico. Lo stesso
sistema di credito, fino al secondo dopoguerra a base rurale e
mutualistica, fu azzerato e trasformato in un sistema bancario a tutti
gli effetti, statale, distante dalle esigenze del territorio, in primis da
quelle agricole. La politica dei finanziamenti europei, poi, finirà di
devastare il settore. Ne conseguiranno espianti sconsiderati di
vigneti, abbandono delle campagne, anche in presenza delle
infrastrutturazioni necessarie, produzione subordinata alle esigenze
della grande distribuzione. Il risultato è che oggi i sardi consumano
sulle proprie tavole alimenti e bevande per lo più provenienti da
lontano, da fuori. Il settore agricolo si avvita in una crisi fatta di
investimenti sbagliati, attese di assistenzialismo a oltranza, rapacità
delle banche e pignoramenti manu militari, abbandono della terra.
Ma non c’è nulla di scritto, in questa sorte: non si tratta di un esito
inevitabile e nemmeno irreversibile. Non c’è una sola variabile
geografica, climatica, demografica – che impedisca alla Sardegna di
essere una terra largamente autosufficiente dal punto di vista
agroalimentare, o comunque vantaggiosamente inserita in un
circuito di scambi internazionali.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :






Commento all'articolo