Note di un anatomopatologo – F. González-Crussí

SINTESI DEL LIBRO:
Cerimoniali e rito scaturiscono dal profondo dell’animo, e lo sanno bene i
governanti, i quali ci negherebbero il pane piuttosto che osare alterazioni
nell’osservanza della tradizione. Ciò nonostante, le cerimonie funebri sono
soggette a mutamenti. I Daiachi del Borneo seguivano l’usanza di conservare
il cadavere dei capi nella casa comune dei vivi, pratica che dovettero
abbandonare costretti dai funzionari olandesi, ai quali non andava a genio
questa forma di promiscuità. Con zelo sanitario altrettanto commendevole,
come è noto, in India le autorità coloniali avversavano l’antica consuetudine
dei Parsi di Bombay, seguaci di Zoroastro, i quali collocano i corpi dei
defunti in cima ad alte costruzioni circolari dove gli avvoltoi, nel volgere di
ore, ne divorano tutte le carni. In generale gli europei intravidero foschi
contorni in questo rituale, e mostrarono poca simpatia per ciò che appariva
loro come un «segreto culto di morte». Eppure l’usanza dei Parsi risale ad
almeno sei secoli prima della nascita di Cristo e fu dettata dalla necessità,
tanto sentita ai giorni nostri, di ridurre l’inquinamento: i seguaci di Zoroastro
giudicano infatti il cadavere talmente immondo da contaminare gli «elementi
puri» dell’universo — terra, fuoco e acqua. In Europa e negli Stati Uniti
l’imbalsamazione era praticamente sconosciuta, prima della seconda metà del
diciottesimo secolo. La tecnica moderna di questo procedimento viene
generalmente attribuita all’anatomopatologo scozzese William Hunter. Prima
di allora, e negli Stati Uniti sino al periodo della Guerra di Secessione, i
cadaveri che dovevano essere trasportati, o comunque tenuti per giorni senza
sepoltura, venivano semplicemente mantenuti in ghiaccio: esistevano «tavoli
di refrigerazione», concavi, pieni di ghiaccio, in cui la salma era sistemabile
comodamente; ma, a parte questo esempio di rudimentale inventiva, la
tecnologia mortuaria non può dirsi fosse realmente posta al servizio della
gente comune.
Tra Oriente e Occidente la differenza è rivelatrice: per gli antichi Egizi
l’imbalsamazione altro non era che un singolo aspetto di una vita già
impregnata delle cose dello spirito e preoccupata della sorte dell’anima dopo
la morte del corpo. Nell’Occidente industriale è esistita una sollecitudine
altrettanto universale e compenetrante: essa ha nome «ricerca del profitto» e
ha molto contribuito al diffondersi della pratica dell’imbalsamazione, come
risulterà chiaro nelle pagine seguenti.
Pare che in Occidente imbalsamazione e guadagno abbiano marciato di
pari passo sin dall’inizio. John Hunter, fratello minore dell’anatomista
scozzese, si imbatté in un’eccezionale opportunità di applicare i metodi di
William. Una signora facoltosa, moglie di tale Martin Van Butchell, in base a
oscure e inconoscibili motivazioni redasse un testamento singolare: era suo
intendimento, debitamente legalizzato con tanto di suggelli e firme, che il
marito sopravvissutole potesse disporre della fortuna di lei per tutto il tempo
che ella fosse rimasta insepolta. A trapasso avvenuto, il marito agì con
determinazione tanto più ammirevole in quanto unita al cordoglio. John
Hunter fu convocato alla residenza e fluidi di recente invenzione vennero
inoculati per via arteriosa nelle spoglie mortali di Mrs. Van Butchell,
cosicché la dama, elegantemente rivestita dei suoi abiti più belli, finì in una
teca di vetro davanti alla quale poté ricevere amici e parenti.
Dopo un esordio così propizio, la pratica dell’imbalsamazione compì
progressi di carriera notevolissimi, ma in nessun posto altrettanto consistenti
come negli Stati Uniti, ove il governo la incoraggiò con tutto il peso della
propria autorità. Qui l’imbalsamazione è divenuta obbligatoria per legge ogni
qualvolta l’intervallo tra decesso e inumazione ecceda le quarantotto ore
(ventiquattro in alcuni Stati), oppure quando la salma debba essere trasportata
a una certa distanza. Come tutti sanno, affermare che l’imbalsamazione copre
in America un grande giro d’affari sarebbe molto riduttivo. Secondo
statistiche aggiornate, con la cremazione viene eliminata una quota inferiore
all’8 per cento della popolazione estinta di questo paese, e siccome metodi di
smaltimento alternativi, quali il cannibalismo o l’esposizione secondo il rito
di Zoroastro, probabilmente vi trovano un’applicazione del tutto saltuaria, ne
consegue che l’imbalsamazione rimane ancor oggi un’attività
economicamente importante. Questo vale così nella globale prospettiva
economica della nazione, come dal punto di vista più limitato dell’iniziativa
individuale.SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :
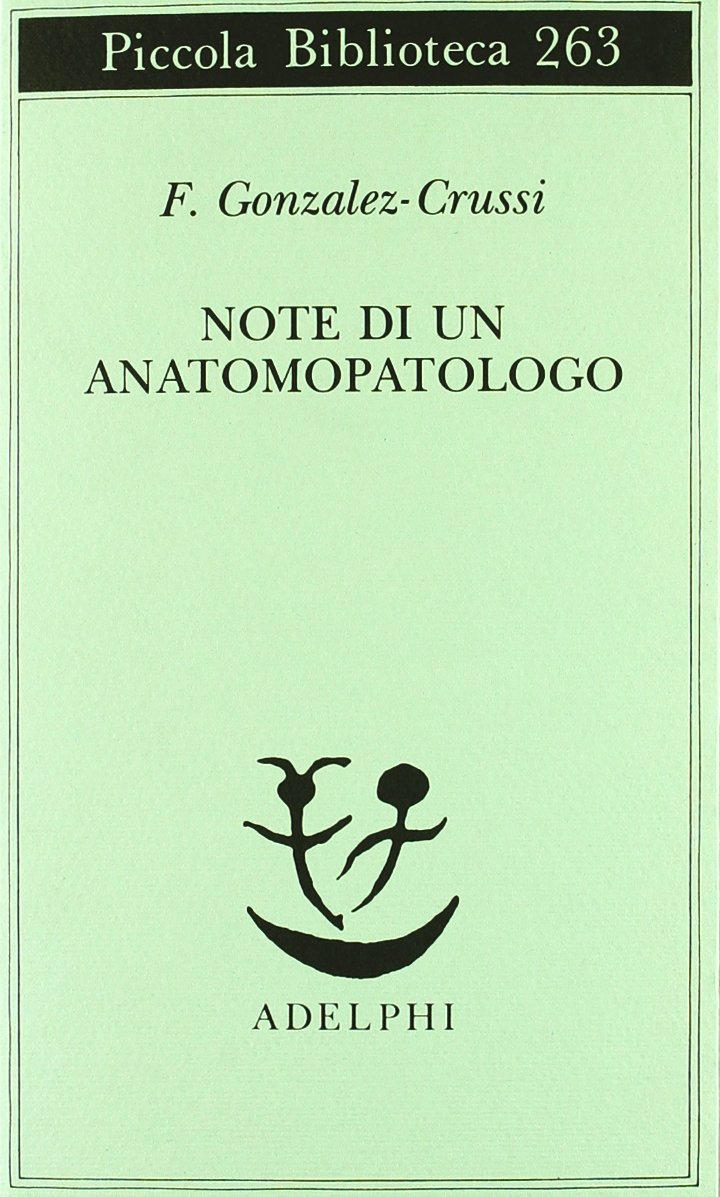






Commento all'articolo