Tra donne sole – Cesare Pavese
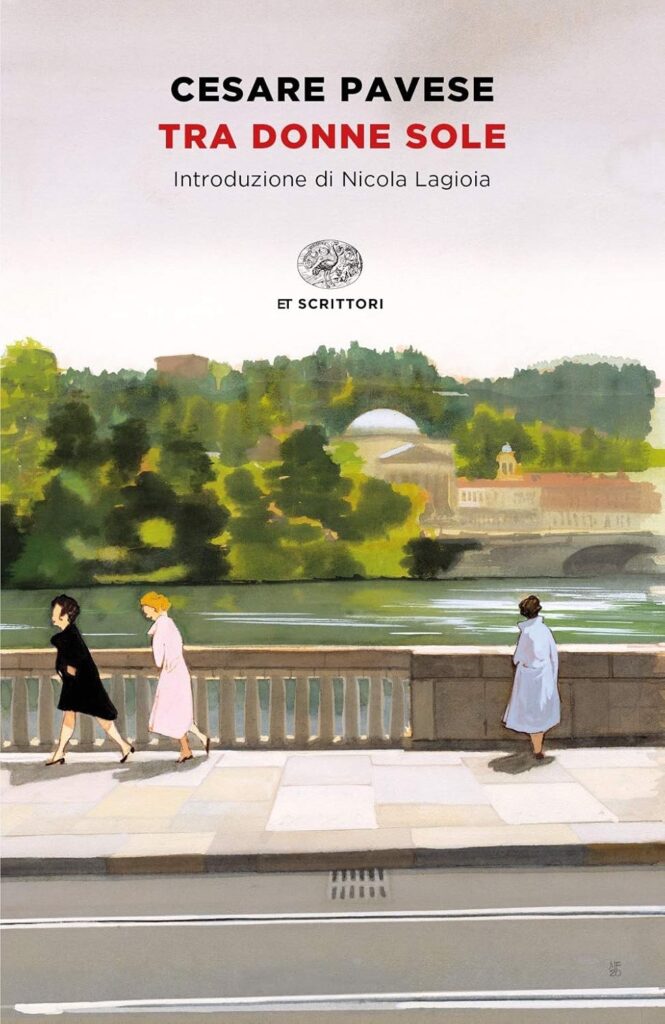
SINTESI DEL LIBRO:
Arrivai a Torino sotto l’ultima neve di gennaio, come succede ai
saltimbanchi e ai venditori di torrone. Mi ricordai ch’era carnevale
vedendo sotto i portici le bancarelle e i becchi incandescenti
dell’acetilene, ma non era ancor buio e camminai dalla stazione
all’albergo sbirciando fuori dei portici e sopra le teste della gente.
L’aria cruda mi mordeva alle gambe e, stanca com’ero, indugiavo
davanti alle vetrine, lasciavo che la gente mi urtasse, e mi guardavo
intorno stringendomi nella pelliccia. Pensavo che ormai le giornate si
allungavano, e che presto un po’ di sole avrebbe sciolto quella
fanghiglia e aperto la primavera.
Rividi cosí Torino, nella penombra dei portici. Quando entrai
nell’albergo non sognavo che il bagno scottante e distendermi e una
notte lunga. Tanto, a Torino ci dovevo stare un pezzo.
Non telefonai a nessuno e nessuno sapeva ch’ero scesa a
quell’albergo. Nemmeno un mazzo di fiori mi attendeva. La
cameriera che mi preparò il bagno mi parlò, china sulla vasca,
mentr’io giravo nella stanza. Sono cose che un uomo, un cameriere,
non farebbe. Le dissi di andarsene, che bastavo da sola. La ragazza
balbettò qualcosa, fronteggiandomi, scrollando le mani. Allora le
chiesi di dov’era. Lei arrossí vivacemente e mi rispose ch’era veneta.– Si sente, – le dissi, – e io sono torinese. Ti farebbe piacere tornare
a casa?
Annuí con uno sguardo furbo.– Fa’ conto allora ch’io qui torno a casa, – le dissi, – non
guastarmi il piacere.– Chiedo scusa, – mi disse. – Posso andare?
Quando fui sola, dentro l’acqua tiepida, chiusi gli occhi irritata
perché avevo parlato troppo e non ne valeva la pena. Piú mi
convinco che far parole non serve, piú mi succede di parlare.
Specialmente fra donne. Ma la stanchezza e quel po’ di febbre si
disciolsero presto nell’acqua e ripensai l’ultima volta ch’ero stata a
Torino – durante la guerra – l’indomani di un’incursione: tutti i tubi
eran saltati, niente bagno. Ci ripensai con gratitudine: finché la vita
aveva un bagno, valeva la pena di vivere.
Un bagno e una sigaretta. Mentre fumavo con la mano a fior
d’acqua, confrontai lo sciacquío, che mi cullava, coi giorni agitati che
avevo veduto, col tumulto di tante parole, con le mie smanie, coi
progetti che avevo sempre realizzato eppure stasera si riducevano a
quella vasca e quel tepore. Ero stata ambiziosa? Rividi le facce
ambiziose: facce pallide, segnate, convulse – ce n’era qualcuna che
si fosse distesa in un’ora di pace? Nemmeno morendo quella
passione s’allentava. A me pareva di non essermi mai rilassata un
momento. Forse vent’anni prima, quand’ero ancora una bambina,
quando giocavo per le strade e aspettavo col batticuore la stagione
dei coriandoli, dei baracconi e delle maschere, forse allora mi ero
potuta abbandonare. Ma in quegli anni per me carnevale non voleva
dir altro se non giostre, torrone e nasi di cartapesta. Poi, con la
smania di uscire, di vedere, di correre per Torino, con le prime
scappate nei vicoli insieme a Carlotta e alle altre, col batticuore di
sentirci per la prima volta inseguite, anche quest’innocenza era
finita. Strana cosa. La sera del giovedí grasso, quando papà s’era
aggravato, per poi morire, io piansi di rabbia e l’odiai pensando alla
festa che perdevo. Soltanto la mamma mi capí quella sera, e mi
prese in giro e mi disse di levarmi dai piedi, di andare a piangere in
cortile da Carlotta. Ma io piangevo perché il fatto che papà fosse per
morire mi spaventava e m’impediva dentro di abbandonarmi al
carnevale.
Squillò il telefono. Non mi mossi dalla vasca, perch’ero felice con
la mia sigaretta e pensavo che probabilmente proprio in quella sera
lontana m’ero detto la prima volta che se volevo far qualcosa,
ottenere qualcosa dalla vita, non dovevo legarmi a nessuno,
dipendere da nessuno, com’ero legata a quell’importuno papà. E
c’ero riuscita e adesso tutto il mio piacere era disciogliermi in
quell’acqua e non rispondere al telefono.
Questo riprese, dopo un poco, e pareva irritato. Non ci andai ma
uscii dall’acqua. M’asciugai lentamente, seduta nell’accappatoio, e
stavo spalmandomi una crema intorno alla bocca quando
bussarono. – Chi è?– Un biglietto per la signora.– Ho detto che non ci sono.– Il signore insiste.
Mi toccò alzarmi e girare la chiave. La veneta impertinente mi
tese il biglietto. Lo scorsi e dissi alla ragazza:– Non voglio vederlo. Ritorni domani.– La signora non scende?
Mi sentivo la faccia impiastrata, non potevo nemmeno farle una
smorfia. Dissi: – Non scendo. Voglio un tè. Digli domani a
mezzogiorno.
Quando fui sola, staccai il telefono, ma subito dall’ufficio
risposero. La voce raschiava sul tavolino, impotente come un pesce
fuor d’acqua. Allora gridai qualcosa nel telefono, dovetti dire ch’ero
io, che volevo dormire. Mi augurarono la buona notte.
Mezz’ora dopo, la cameriera non era ancora tornata. «Questo
succede soltanto a Torino», pensai. Feci una cosa che non avevo
mai fatto, come se fossi una ragazza sciocca. M’infilai la vestaglia e
socchiusi la porta.
Nel corridoio discreto, varie persone, camerieri, signori, la mia
impertinente, s’accalcavano davanti a una porta. Qualcuno,
sottovoce, esclamava qualcosa.
Poi la porta si spalancò, e piano, con molti riguardi, due camici
bianchi portarono fuori una barella. Tutti tacquero e fecero largo.
Sulla barella era distesa una ragazza – viso gonfio e capelli in
disordine – vestita da sera di tulle celeste, senza scarpe. Benché
avesse le palpebre e le labbra morte, s’indovinava una smorfia
ch’era stata spiritosa. Guardai d’istinto sotto la barella, se gocciava
sangue. Cercai le facce – erano le solite, chi sporgeva le labbra, chi
pareva ghignasse. Colsi l’occhio della mia cameriera – stava
correndo dietro la barella. Sulle voci sommesse del crocchio (c’era
pure una signora in pelliccia e si torceva le mani) si levò quella di un
dottore – uscí dalla porta asciugandosi le mani – e dichiarò ch’era
finito, si levassero dai piedi.
La barella sparí per le scale, sentii esclamare: – Fa’ piano –.
Guardai di nuovo la mia cameriera. Era già corsa a una sedia in
fondo al corridoio, e tornava col vassoio del tè.– S’è sentita male, che disgrazia, – disse entrandomi nella stanza.
Ma le brillavano gli occhi e non si tenne. Mi disse ogni cosa. La
ragazza era entrata in albergo al mattino – veniva sola da una festa,
da un ballo. S’era chiusa nella stanza; non s’era mossa tutto il
giorno. Qualcuno aveva telefonato, l’avevano cercata; un questurino
aveva aperto. La ragazza era sul letto, moribonda.
La cameriera continuava. – Prendere il veleno a carnevale, che
peccato. E i suoi sono cosí ricchi… Hanno una bella villa in piazza
d’Armi. Se si salva è un miracolo…
Le dissi che volevo dell’altr’acqua per il tè. E che non si fermasse
piú sulle scale.
Ma quella notte non dormii come avevo sperato e girandomi nel
letto mi sarei data dei pugni per aver messo il naso nel corridoio.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :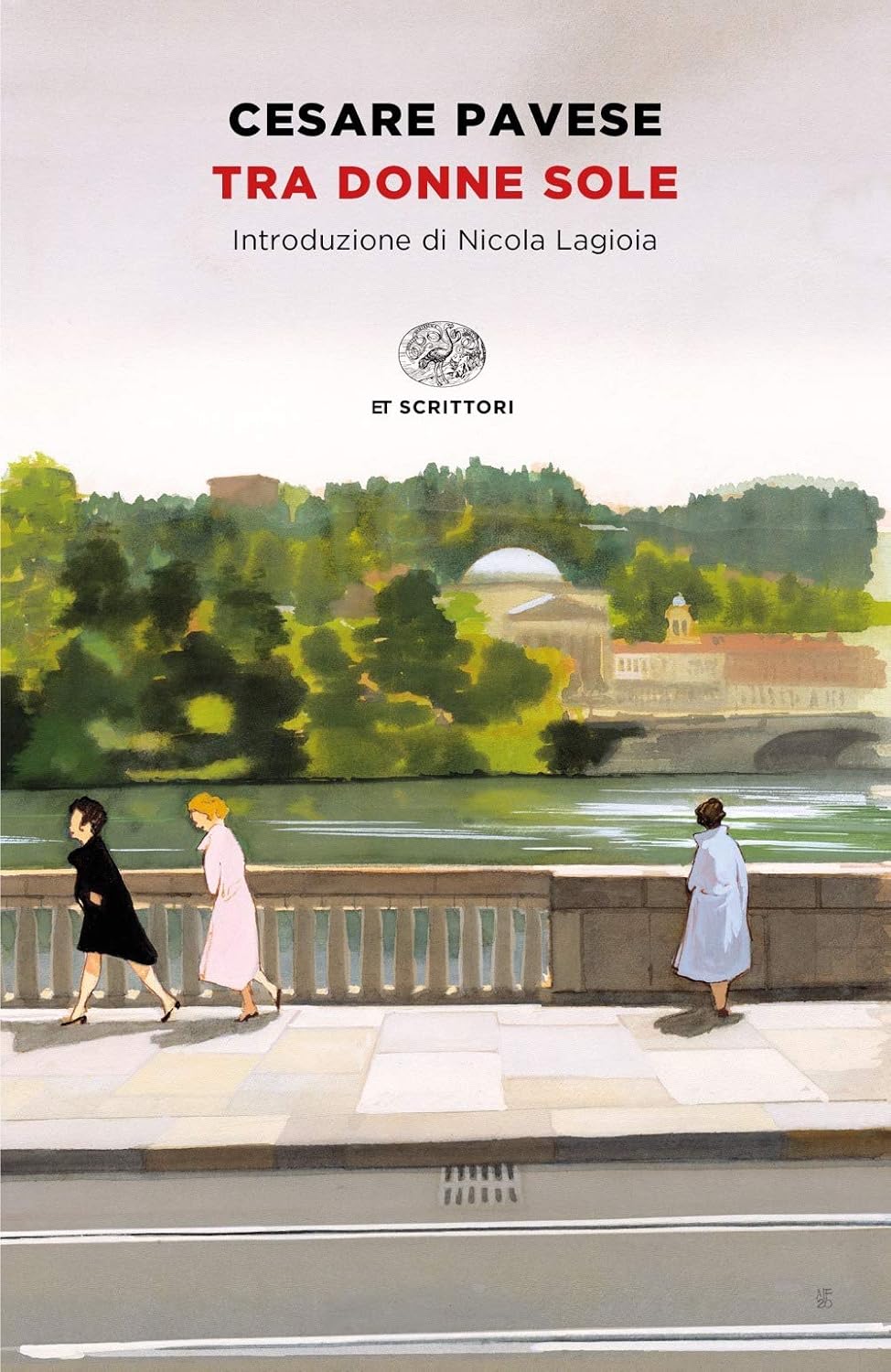






Commento all'articolo