Teoria della dittatura -preceduto da Orwell e l’impero di Maastricht – Michel Onfray

SINTESI DEL LIBRO:
Considero il pensiero politico di George Orwell come uno dei più
grandi, al pari di quello consegnato da Machiavelli nel Principe, da
La Boétie nel Discorso sulla servitù volontaria, da Hobbes nel
Leviatano e da Rousseau nel Contratto sociale. Orwell aiuta a
pensare la politica partendo da un’ottica socialista e libertaria. Il fatto
però di aver scelto di esprimere le proprie idee solo attraverso
romanzi e favole a soggetto animale ha fatto sì che i pensatori
istituzionali non gli prestassero alcuna attenzione: la letteratura lo
lascia ai filosofi e i pensatori lo lasciano agli studiosi di letteratura. Il
risultato è che nessuno se ne occupa veramente. Nel frattempo, nei
paesi in cui la gente si trova privata delle proprie libertà, lo si legge
sotto banco.
A parte Camus, sono pochissimi i pensatori del socialismo
libertario che si smarcano con convinzione dalla versione autoritaria
del socialismo. Bakunin e Kropotkin, per esempio, da bravi hegeliani
di sinistra, continuano nonostante tutto a strizzare l’occhio a Marx,
dal quale si differenziano certo sulla scelta dei mezzi con cui arrivare
al potere, ma niente affatto sui fini. Per tutti quanti, in ogni caso, la
realtà, più che come realtà, vale come idea. Ci volevano filosofi del
calibro di Proudhon per mettere in moto, a sinistra, un pensiero che
riuscisse a superare i paletti marxisti. In questo senso, anche 1984 e
La fattoria degli animali offrono un loro contributo.
I due libri di Orwell, li ho letti molto tempo fa. La Russia era ancora
sovietica e mio padre era ancora vivo, mio padre che nel suo
paesino natale (che è anche il mio paesino natale) aveva conosciuto
l’occupazione nazista e che, di questa occupazione, mi aveva
parlato a lungo nei miei anni d’infanzia. I totalitarismi che erano
serviti da referente per quei due libri, cioè quello nazionalsocialista e
quello marxista-leninista, sono molto lontani dalla realtà dei nostri
giorni. Anzi, oggi che quei due mostri sono ormai morti, può
addirittura sembrare che le opere di Orwell abbiano perso la propria
attualità. Che parlino di un tempo ormai defunto.
La peste, che Roland Barthes riteneva caricasse un po’ troppo il
mulo bolscevico e non abbastanza l’asinello nazista, può apparire un
libro antifascista datato perché troppo calcato sui particolari
totalitarismi del proprio momento storico. Allo stesso modo, anche il
valore dell’opera politica di Orwell sembrerebbe essere crollato
assieme al muro di Berlino.
Sarebbe però dimenticare che proprio alla fine della Peste Camus
ci spiega che quest’ultima non sparisce mai del tutto, dorme sempre
con un occhio aperto e gli basta pochissimo per ripresentarsi, con il
suo strascico di topi morti a segnare il ritorno dell’epidemia. La peste
era un libro che spiegava quello che era successo ieri ma che
aiutava (ed è questo il suo aspetto geniale) a decifrare non solo
quello che succede oggi, ma anche quello che succederà domani,
addirittura dopodomani. Anche Orwell è un autore di questo tipo:
pensa un passato che potrebbe essere il futuro e che spesso si
rivela essere anche il presente. Detta in altre parole: Orwell rientra in
un campo universale perché quella che ci propone è una teoria della
dittatura.
Da una parte, quindi, la teoria, che è etimologicamente
contemplazione, osservazione, disamina; dall’altra, la dittatura, che
va invece riformulata su nuove basi. Ai tempi della sua nascita a
Roma, la dittatura era l’eccezionale concessione dei sommi poteri da
parte del console, su mandato del Senato, a una singola persona
per un tempo determinato, mai più di sei mesi, allo scopo di
affrontare una situazione altrettanto eccezionale e a patto che tutti i
mezzi offerti servissero a risolvere il problema che aveva portato a
quella concessione del potere supremo. È così che, per esempio,
Silla viene incaricato di restaurare la repubblica.
Anche se Gengis Khan nella Cina tra il XII e il XIII secolo, anche
se Tamerlano nell’Uzbekistan e nel Kazakistan del Trecento e del
Quattrocento e anche se Cromwell nell’Inghilterra del Seicento ci
dimostrano che la dittatura appartiene a ogni epoca e a ogni
continente, sono soprattutto le dittature del Novecento a contribuire
alla definizione di una loro nuova tipologia.
Il
secolo del nucleare è stato in effetti anche il secolo delle
dittature, all’inizio nella sua formulazione marxista-leninista e in
seguito, come reazione ma in maniera gemella, nella sua versione
nazionalsocialista. La prova della loro gemellarità è fornita dal patto
germano-sovietico che ha celebrato il matrimonio tra i due mostri
totalitari dal 23 agosto del 1939 al 22 giugno del 1941. Una sottile
analisi di questo fenomeno la dobbiamo a Hannah Arendt e al suo
Le origini del totalitarismo, grosso lavoro in tre tomi pubblicato tra il
1951 e il 1983 – un’analisi in cui peraltro il nome di Orwell non
compare mai, non più di quanto avvenga nella sua opera completa o
nella sua corrispondenza.
In realtà, a me pare che neanche i nostri tempi post-totalitari
riescano a impedire la formazione di un tipo nuovo di totalitarismo. Al
contrario. La dittatura è una forma politica che continua a durare
attraverso i secoli e che, grazie alla propria dialettica e alla propria
plasticità, riesce ad assumere cadenze diverse secondo i tempi.
La Germania nazista è morta nel 1945, mentre la Russia sovietica
esala l’ultimo respiro nel 1991, provocando a catena la scomparsa
delle democrazie cosiddette popolari appartenenti al blocco
orientale. In linea teorica, per quello che riguarda l’Europa, i due
totalitarismi che Orwell aveva in mente non esistono più. In pratica,
però, scavalcando i tempi storici, quella cui pensava era una forma
pura di totalitarismo. 1984 e La fattoria degli animali offrono due
occasioni per pensare appunto questa forma pura.
Riassumo le tesi costitutive di questa Teoria della dittatura.
Come si può instaurare oggi una dittatura di tipo nuovo? Ho
messo a fuoco sette fasi principali: distruggere la libertà; impoverire
la lingua; abolire la verità; sopprimere la storia; negare la natura;
propagare l’odio; aspirare all’Impero. Ognuna di queste fasi è a sua
volta composta da momenti particolari.
Per distruggere la libertà, bisogna: assicurare una sorveglianza
continua; distruggere la vita personale; eliminare la solitudine;
divertire con le feste comandate; uniformare l’opinione; denunciare i
crimini di pensiero.
Per impoverire la lingua, bisogna: praticare una lingua nuova;
usare un linguaggio a doppia valenza; distruggere parole; piegare la
lingua all’oralità; parlare una lingua unica; eliminare i classici.
Per abolire la verità, bisogna: imporre l’ideologia; strumentalizzare
la stampa; diffondere notizie false; creare la realtà.
Per sopprimere la storia, bisogna: cancellare il passato; riscrivere
la storia; inventare la memoria; distruggere i libri; industrializzare la
letteratura.
Per negare la natura, bisogna: distruggere la pulsione di vita;
organizzare la frustrazione sessuale; imporre vincoli di norme
igieniche; procreare per via medica.
Per propagare l’odio, bisogna: creare un nemico; fomentare
guerre; ridurre il pensiero critico a problema psichiatrico; dare il
colpo di grazia all’ultimo uomo.
Per aspirare all’Impero, bisogna: indottrinare i bambini; gestire
l’opposizione; governare assieme alla classe dirigente; ridurre in
schiavitù grazie al progresso; dissimulare il potere.
Chi oserà dire che non siamo arrivati a questo punto?
E, se è vero che ci siamo arrivati: quand’è successo? E come?
Con chi? Dove?
*
Dopo la guerra, l’Occidente capitalista stabilisce un programma
imperialista da imporre sul continente europeo. L’esistenza del
blocco sovietico lo costringe però a venire a compromessi. La guerra
fredda rappresenta, per un certo periodo, la forma assunta dalla
battaglia fra questi diversi blocchi. Fino al 26 dicembre del 1991,
data della caduta del marxismo-leninismo europeo, l’Occidente
capitalista tende a contenersi perché sa che il contrattacco
comunista è possibile in ogni momento. I due blocchi si lanciano
minacce e accumulano armi nucleari.
Quello cui puntavano gli Stati Uniti, quello che il generale de
Gaulle non aveva permesso nel 1945, vale a dire il governo militare
alleato sui territori occupati (AMGOT), lo ha permesso invece
l’Europa di Jean Monnet.
Troppo poco spesso è stato ricordato che il nome in codice dello
sbarco alleato del 6 giugno del 1944 era Overlord e che la
traduzione di questo termine è: «signore sovrano»! Ora, il concetto
di «signore sovrano» implica etimologicamente una relazione di tipo
feudale tra un sovrano che, appunto, comanda e un vassallo che
invece è comandato. L’AMGOT sembra quindi palesemente indicare
un rapporto tra un paese sovrano (gli Stati Uniti) e un paese vassallo
(la Francia).
Il programma dell’AMGOT era di amministrare il paese riciclando i
prefetti del governo di Vichy, anticomunisti e di conseguenza
affidabili, e trasformare la Francia in una provincia governata dagli
americani. A questo preciso scopo, vengono addirittura formati nelle
università alcuni ufficiali americani e inglesi e coniate delle monete.
Per de Gaulle, però, di lasciare che gli Stati Uniti amministrino la
Francia non se ne parla neppure. Il generale vince il suo braccio di
ferro il 23 ottobre del 1944, quando il Governo Provvisorio della
Repubblica Francese viene riconosciuto de iure da Stati Uniti, Gran
Bretagna e Unione Sovietica. La Francia vince una battaglia, ma non
vince certo la guerra.
Per governarla, de Gaulle è costretto a creare un mito: quello della
Francia in maggioranza resistente e solo in minima parte
collaborazionista. Questa favola è il prezzo da pagare per evitare di
doversela prendere con chi aveva collaborato con il governo di Vichy
o con i tedeschi – come avevano fatto peraltro anche i comunisti nei
primi quasi due anni della guerra, il tempo che è durato il patto
germano-sovietico.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :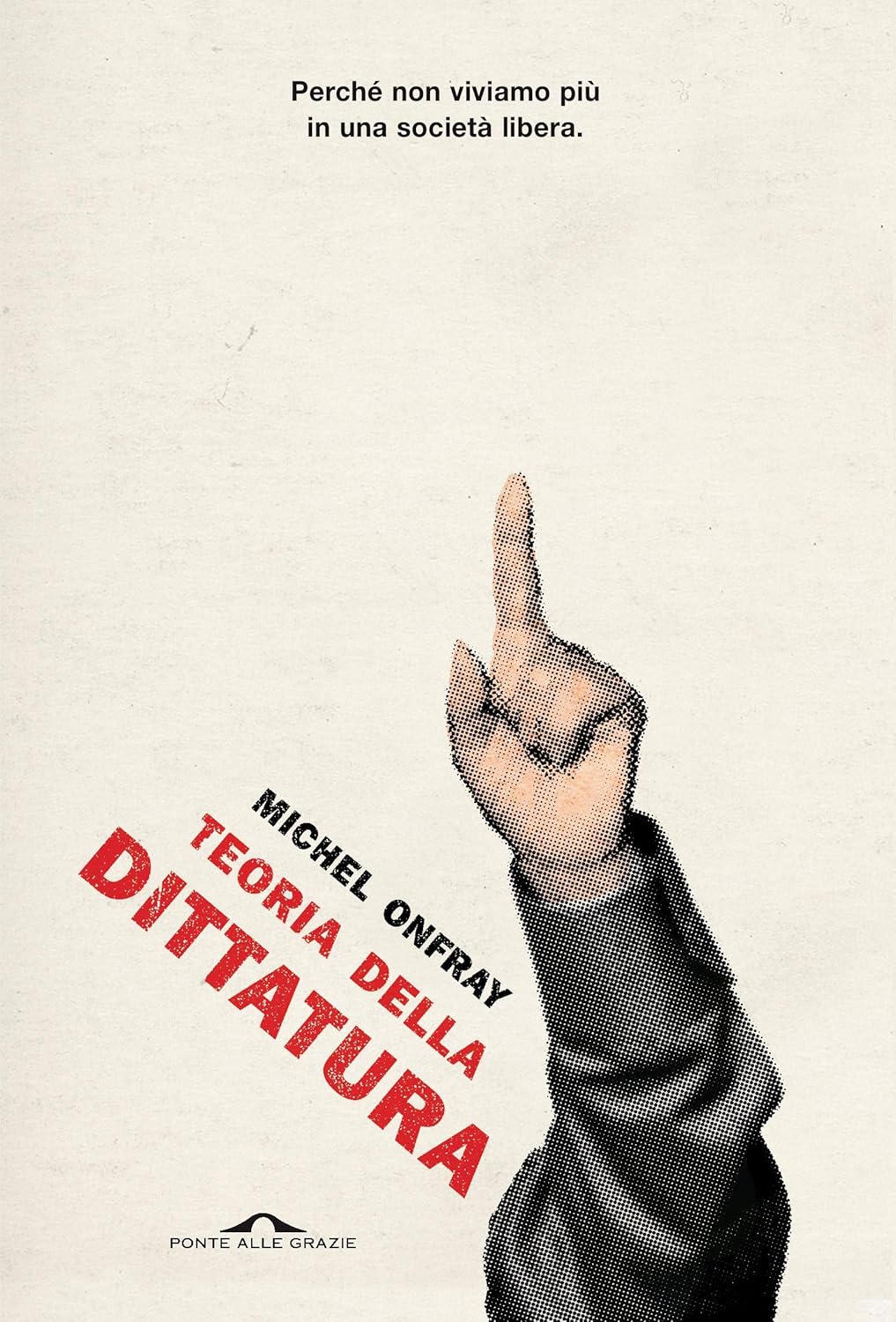






Commento all'articolo