Su e giù per le scale – Monica Dickens
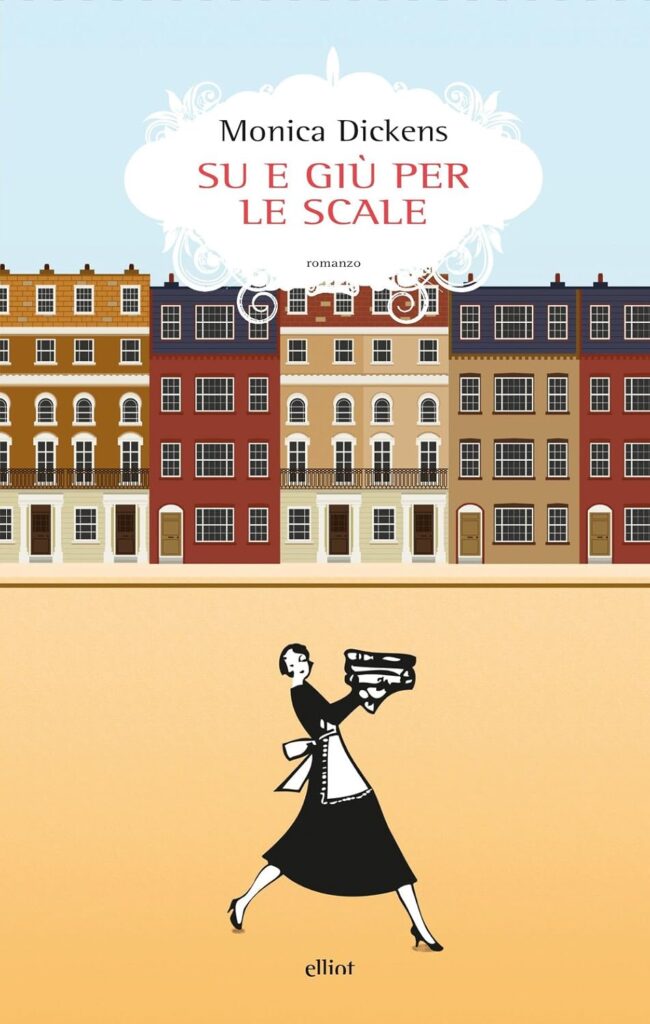
SINTESI DEL LIBRO:
Ne avevo abbastanza. Mi ero svegliata all’alba di una grigia giornata
d’autunno, non riuscivo a riaddormentarmi e pensavo alla mia vita. Le tre del
mattino non sono l’ora più propizia per la meditazione, come tutti sanno. Mi
sentivo in preda a un profondo abbattimento.
Ero appena ritornata da New York. Il folle ciclone d’allegria, al quale laggiù
la gente pare riesca a sopravvivere, mi aveva fatto roteare beatamente per
ripiombarmi in una Londra che pareva piatta e scipita. Mi sentivo inquieta e
insoddisfatta e di un umore spaventoso.
“Nella vita” pensavo “deve pur esserci qualcosa di più, oltre ai ricevimenti
noiosi, in mezzo a gente che non è nemmeno simpatica! Che esistenza senza
scopo… galleggiare così, nella speranza che qualcosa venga a interrompere
tanta monotonia. Devo tirarmi fuori da questa palude”.
Qui ebbi il lampo di genio.
«Troverò un lavoro!».
Lo dissi ad alta voce e mi fece una gran buona impressione, anche se il mio
cane non ebbe l’aria di esserne scosso. Più ci pensavo e più l’idea mi piaceva,
soprattutto dal punto di vista del denaro. Ne avrei guadagnato.
La mia fantasia prese il volo, come succede alle fantasie quando si è a
letto… soldi, pellicce, automobili… Tornai con uno sforzo alla realtà e cercai di
pensare a un lavoro adatto.
Esaminai le varie possibilità.
Da quando avevo terminato la scuola, mi ero preparata con scarso
entusiasmo ad affrontare varie professioni. Come succede a tutti a quell’età,
per un certo periodo credetti fermamente che il palcoscenico mi riservasse un
radioso successo e, al mio ritorno da Parigi, avevo ottenuto il permesso di
frequentare una scuola d’arte drammatica.
«Prova qualsiasi cosa almeno una volta» dicevano i miei genitori e così,
piena di speranze e di ambizioni, mi iscrissi a una scuola d’arte drammatica di
Londra. Non erano trascorse due settimane che sia io sia gli esperti del luogo
eravamo convinti che non sapevo recitare e che, con ogni probabilità, mai
avrei imparato. Era scoraggiante, ma continuai, mentre il mio complesso di
inferiorità si ingigantiva. Faceva parte del programma della scuola lo
“smussare gli angoli alle ragazze” (non agli uomini, sono troppo rari e
preziosi). Soltanto quelle dotate di una gran forza d’animo e di vera ambizione
possono affrontare le tempeste di quei feroci sarcasmi e di quelle osservazioni
che si riversano sulle loro teste tremanti. È un sistema giusto, perché soltanto
quelle che sono dotate di vero talento e di un’eccezionale forza d’animo
riescono a sopportarlo, per poi iniziare una vita ancora più dura. Le incerte e
le inette, come ero io, si scoraggiano agli inizi di una carriera destinata
all’insuccesso e così vengono loro risparmiate molte sofferenze.
Una volta convinta di non avere la vocazione per il teatro, trascorsi un
anno divertentissimo a passeggiare sul palcoscenico nei panni della cameriera
o della sorella di qualche personaggio. E contemplare un lago immobile al
tramonto, esprimere dolore, paura ed estasi in rapida successione era
veramente spassoso, soprattutto se eseguito in compagnia di altre cinquanta
ragazze in calzamaglia nera molto attillata.
Non mi rendevo conto di quanto potesse essere irritante per gli insegnanti
trovarsi tra i piedi qualcuno che si trascinava senza ambizioni nella polvere
sollevata dalle allieve stelle, e quando mi ritrovai sul marciapiede, con i libri
sotto un braccio e la calzamaglia sotto l’altro, fui davvero molto sorpresa.
Potevo diventare indossatrice, ma abbandonai subito l’idea; era l’ultima
risorsa delle ragazze della buona società, decorative e futili, che vengono
assunte dalle case di moda perché vi attirano le loro ricche amiche e passano le
giornate a ciondolare per le sale, indossando abiti superbi in pose di
tormentata superiorità.
Non mi pareva facesse al caso mio e così mi decisi per la cucina. Mi
interessava ed ero convinta di saperne molto. Avevo imparato qualcosa a
Parigi, ma il mio interesse si era risvegliato dopo alcune lezioni in una
meravigliosa scuola di cucina.
Vi entrai che non sapevo bollire un uovo e ne uscii con l’aragosta alla
Thermidor e le crêpe Suzette sulla punta delle dita. Non avevo però imparato
a preparare le uova all’ostrica né l’arrosto: in quella scuola le ricette troppo
semplici non venivano nemmeno prese in considerazione. Frequentai quindi
per un po’ di tempo una squallida scuola di cucina inglese, in cui due vecchie
zitelle erudivano una folta schiera di allieve. Quando non avevano il tempo di
dirmi che cosa dovevo cucinare, mi ordinavano: «Acquaio, signorina
Dickens», e la signorina Dickens doveva ripulire gli intrugli delle altre alunne
finché non le capitavano la fortuna e il permesso di preparare un budino.
La mia intenzione di lavorare come cuoca suscitò in famiglia un coro di
fragorose risate. Nessuno mi credeva capace di cucinare, giacché in casa mi
avevano sempre impedito di avvicinarmi ai fornelli. La nostra cuoca
sessantacinquenne, un po’ picchiatella, regnava assoluta in cucina da trent’anni
e considerava pentole, fornelli e tutti gli arnesi culinari di sua esclusiva
proprietà.
Una volta, mentre lei dormiva nella sua camera, mi ero infilata in cucina
per preparare un’omelette. Senza far rumore, avevo staccato la padella dal
gancio e avevo tolto le uova dalla scansia, ma il sibilo del gas la svegliò.
Stavo rompendo il primo uovo quando lo stropiccio di un paio di
pantofole, seguito immediatamente da un grido di raccapriccio, mi fece
sobbalzare e l’uovo andò a finire sul pavimento.
Il disastro, per non parlare del fatto che stavo usando la sua padella
prediletta, la sconvolse tanto che andò a rinchiudersi nella dispensa insieme
alle provviste, e quella domenica fummo costretti a mangiare banane.
Se la famiglia non cooperava, avrei cercato lavoro per conto mio e non
avrei detto niente se non a cose fatte. Decisi quindi di rivolgermi a un’agenzia.
Avevo trovato un annuncio su un giornale e, appena non ci fu più nessuno
che mi chiedesse: «Dove vai?», indossai il cappello più modesto e corsi fuori.
Ero emozionata e nervosa, come se andassi a fare un’audizione.
Trovai subito la casa, volai su per i tre piani di scale e infilai con il fiato
mozzo una porta che diceva: “Entrate senza bussare”.
La squallida luce verdastra dell’ufficio mi calmò. Sedetti umile sull’orlo di
una sedia, a occhi bassi. Vedevo luccicare il mio naso, e forse andava bene così,
mi dava un’aria più onesta. La donna seduta alla scrivania mi esaminò per un
pezzo attraverso il pince-nez mentre io cercavo di capire se portasse o no la
parrucca. Avevo appena deciso che erano troppo sporchi e mal curati e perciò
dovevano essere i suoi capelli veri, quando mi resi conto che mi stava facendo
delle domande. Risposi con un mormorio roco e di colpo entrai nei panni del
mio patetico personaggio. Lei mi fece capire con delicatezza che desiderava
sapere perché cercassi quel genere di impiego e io le servii subito una madre
vedova in disperata lotta contro la miseria. Mi immedesimai tanto nella parte
che dopo un po’ avevo le lacrime agli occhi, lei tossì e cambiò argomento.
Quando poi mi spiegò che era difficile trovare lavoro senza esperienza e senza
referenze, mi sentii ancora più derelitta. La donna esaminò alcune carte e mi
chiese se avevo fretta. In quel momento suonò il telefono. Prese il ricevitore e
mentre ascoltava continuava a guardarmi. Poi disse: «Sì, ho qualcuno qui in
ufficio che potrebbe andar bene». Scrisse un numero e riattaccò. Mi porse il
foglietto dicendomi: «Telefonate a questa signora, vuole una cuoca, subito.
Dovreste incominciare domani con un pranzo per dieci persone. Credete di
farcela?».
«Oh sì!» affermai, benché non avessi mai cucinato per più di quattro
persone. La ringraziai, pagai uno scellino e mi precipitai al primo telefono
pubblico. Feci appello a tutto il mio spirito, mi incipriai il naso, respirai a
fondo e composi il numero. Una voce cinguettante mi informò che stavo
parlando con la signorina Cattermole. Affermai risolutamente che ero proprio
quella che ci voleva per lei.
«Ne siete sicura?» continuava a chiedere. «Ne siete proprio sicura? È un
pranzo in onore di mio fratello, è appena tornato dal B.A., sapete?».
Manifestai un’adeguata emozione anche se, per quanto ne sapevo, B.A. poteva
essere un incarico nelle colonie o un penitenziario, o qualsiasi altra cosa. Mi
accettò per il pranzo. Se mi fossi dimostrata all’altezza delle mie affermazioni,
mi avrebbe assunta. Credetti opportuno chiederle di specificarmi meglio il
menù del pranzo.
«Oh, un pranzo molto semplice: cocktail d’aragosta, brodino ristretto,
rombo Mornay, fagiano con contorno, macedonia di frutta e pasticcini».
Col tremito nella voce promisi di arrivare all’ora giusta e la salutai.
Trascorsi le ore che mi separavano dal momento fatale assorta nella
febbrile lettura di tutti i libri di cucina che riuscii a trovare. L’atteggiamento
incredulo e ironico della mia famiglia non migliorò affatto la mia sicurezza.
Annunciai a mia madre che era vedova e lei la prese abbastanza bene.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :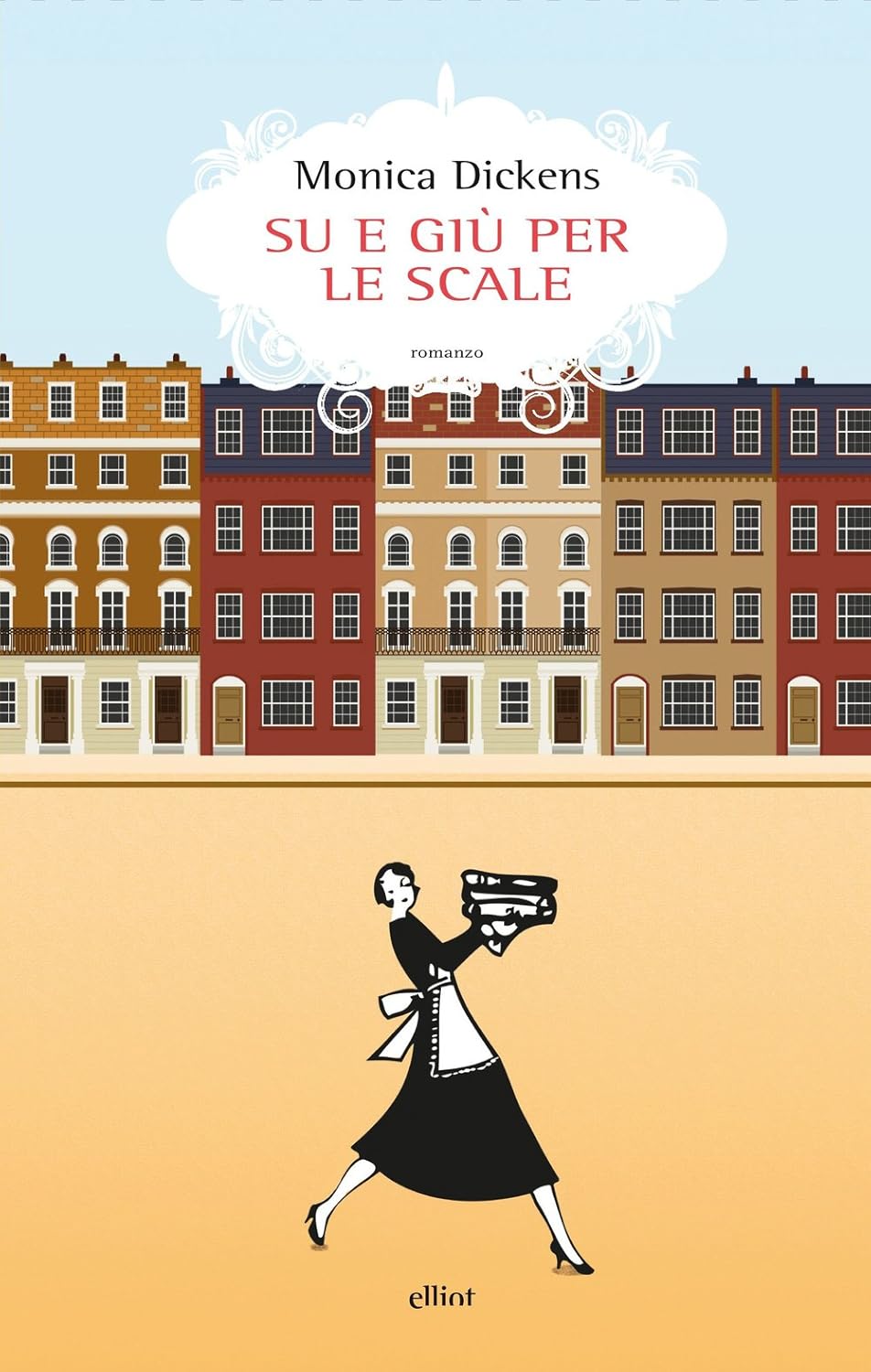






Commento all'articolo