Storia del silenzio – Eugenia Rico
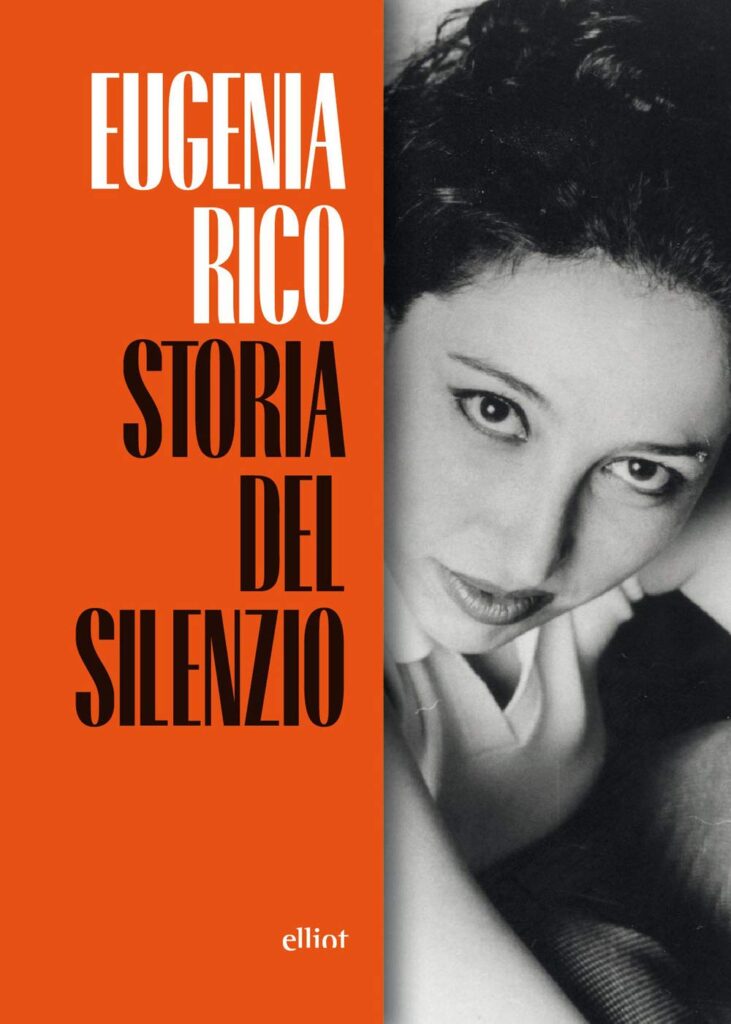
SINTESI DEL LIBRO:
Il silenzio può essere assordante. Il silenzio attraversa il mondo.
Il silenzio degli umani, delle loro auto, delle loro macchine, delle loro
fabbriche.
Madrid è sepolta nel silenzio dall’obitorio del Palacio de Hielo fino
all’ospedale da campo dell’IFEMA.
Venezia è sepolta nel silenzio dal Lido senza Mostra al Canal
Grande senza barche.
New York è in silenzio da Times Square al Bronx.
Nel silenzio degli uomini si sentono gli uccelli.
Non ricordiamo più quando è iniziato il silenzio.
Tutto fa pensare che sia iniziato a gennaio e sia divenuto
insopportabile il 23 febbraio mentre su Piazza San Marco volava
l’Aquila. Di colpo la piazza si è fermata, la folla in silenzio ha
cominciato a guardare i cellulari, come la scena di un film in cui tutti
eravamo comparse: il Carnevale di Venezia è stato cancellato, che è
un po’ come chiudere la vita.
La vita sta per fermarsi. Avete cinque minuti per scendere.
Le masse hanno abbandonato la piazza in fila indiana, in modo
ordinato, gridando con tutta la voce, in modo che le grida restassero
quando tutti fossero andati via.
Le finestre a ogiva dei palazzi, che tanto avevano desiderato vedere
la ritirata dell’esercito dei turisti, si sono chiuse in segno di lutto.
Il fantasma della peste attraversava Venezia.
La maschera del medico della peste avanzava per il mondo.
Il Coronavirus, una parola che non avevamo mai sentito e che ora
diventava il nostro mantra, era arrivato lì dove perfino Napoleone
aveva fallito: chiudere il Carnevale, chiudere la città delle feste.
Era domenica 23 febbraio.
A Venezia, un mese prima che nel resto del mondo, la storia del
silenzio iniziava.
In principio fu la Cina. Ma la Cina sembrava lontana. Il lontano
Oriente.
Poi hanno chiuso Milano e la Lombardia, Venezia e il Veneto. Il resto
dell’Italia e il resto del mondo ci compativa e ci trattava come
lebbrosi. Poi hanno chiuso tutta l’Italia, e il resto del mondo ci
compativa e ci trattava come lebbrosi. Sembrava che l’Italia non
avrebbe più rialzato la testa.
Poi hanno chiuso la Spagna, e la Germania ha detto: noi non siamo
l’Italia, a noi questo non può succedere. Al momento della verità, la
Germania era proprio come l’Italia. Hanno chiuso la Germania, e nel
Regno Unito, un primo ministro che sembra un cartone animato,
Boris Johnson, ha detto: «A noi non interessano i vecchi, ci interessa
solo l’economia». Fino a quando è venuto fuori che Boris Johnson
era uno di quei vecchi che non contano. Nella metafora perfetta del
neoliberismo, il primo ministro al quale non importava la salute degli
altri è finito in terapia intensiva.
L’Europa è stata chiusa. Gli Stati Uniti hanno interrotto i voli con
l’Europa e il loro Presidente ha marchiato gli europei come i nuovi
lebbrosi.
Come una macchia d’olio, ogni giorno arrivava la notizia di un nuovo
Paese in quarantena. Le generazioni che non avevano vissuto le
guerre avrebbero dovuto abituarsi al linguaggio militare. «Siamo in
guerra contro un nemico invisibile» dicevano i giornali.
L’epicentro era a Milano, l’epicentro era a Madrid, l’epicentro era a
New York: il mondo era l’epicentro. Se Galileo ci ha insegnato che la
Terra è rotonda, il Coronavirus ci ha insegnato che è piccola.
In Germania, giovani neonazisti tossivano in faccia agli anziani, a
Barcellona un sindaco guidava ubriaco e rompeva la quarantena al
grido di: «Non ne posso più». Il mondo si divideva in due: quelli che
avevano paura e quelli che non l’avevano. I vecchi e i giovani. I
corona-credenti e i corona-scettici. Quelli impauriti e quelli
terrorizzati.
Tutti rinchiusi in casa.
Su WhatsApp arrivavano bufale di ogni genere. Nel mondo della
letteratura, la tradizionale allergia dei letterati alla tecnologia stava
per sparire: tutti trasmettevano in diretta su Instagram, tutti a
consigliare libri in video fatti in casa.
Quando sembrava che la popolazione non fosse sufficientemente
paralizzata dalla paura del virus e della fine del mondo, si è aggiunta
la paura della crisi economica. Il Fondo Monetario Internazionale ha
parlato di una crisi più grave di quella del ’29.
Ed è qui che coloro che hanno studiato la storia hanno un piccolo
vantaggio.
Annunciare una crisi vuol dire crearla. La paura ha un effetto
astringente sul denaro. I mercati dicono che il denaro ha paura.
Cioè, hanno paura le persone che possiedono il denaro.
La crisi del ’29 finì lo stesso giorno in cui Roosevelt fu eletto
Presidente e annunciò il New Deal. Un’iniezione di denaro pubblico
senza precedenti, per dare lavoro a tutti e fare in modo che la ruota
dell’economia riprendesse a girare. La crisi finì lo stesso giorno in cui
annunciò gli aiuti, perché il denaro, meglio, coloro che lo
possedevano abbandonarono la paura e iniziarono a investire. Le
parole di Roosevelt misero fine alla crisi. Oggi abbiamo bisogno di
qualcuno che annunci il nostro New Deal, che annunci la fine della
crisi prima che inizi. Non si può annunciare una crisi peggiore di
quella del ’29, a meno che non si voglia provocare una catastrofe.
La crisi del ’29 portò in auge il fascismo e il comunismo. La crisi del
’29 provocò la guerra civile spagnola e la Seconda Guerra Mondiale.
La crisi del ’29 creò le condizioni per massacrare, durante
l’Olocausto, milioni di ebrei, zingari, omosessuali e persone con
disabilità mentali. Non si può annunciare un’altra crisi del ’29 e
starsene con le braccia incrociate come fa il Fondo Monetario
Internazionale. Qualcuno dovrebbe dire ai suoi rappresentanti:
«Anche voi siete esseri umani. Sappiamo dove vivete e dove potete
nascondervi».
Elias Canetti dice: «Tutto ciò che imparo lo trasformo in paura».
La storia del silenzio è anche la storia della paura.
All’uomo si può togliere tutto, purché lo si tolga a poco a poco.
Prima hanno chiuso le scuole, poi hanno chiuso i negozi, i bar
aprivano fino alle sei di pomeriggio, i bar non aprivano, fino a
quando è stato chiuso tutto. E anche noi ci siamo chiusi. La società
si è trasformata in una rete sociale.
Tutti eravamo particelle di un essere che twittava, comunicava per
impulsi elettrici, come il nostro cervello. La gente organizzava feste
virtuali, beveva spritz virtuali. La vita era virtuale.
In
televisione vedevano medici che piangevano, medici che
morivano. Solo medici e sacerdoti si avvicinavano ai malati. In fin dei
conti il medico è un sacerdote, e il sacerdote è un medico dell’anima.
I
primi giorni arrivavano barzellette, video, catene, ma un po’ alla
volta è rimasto solo il silenzio.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :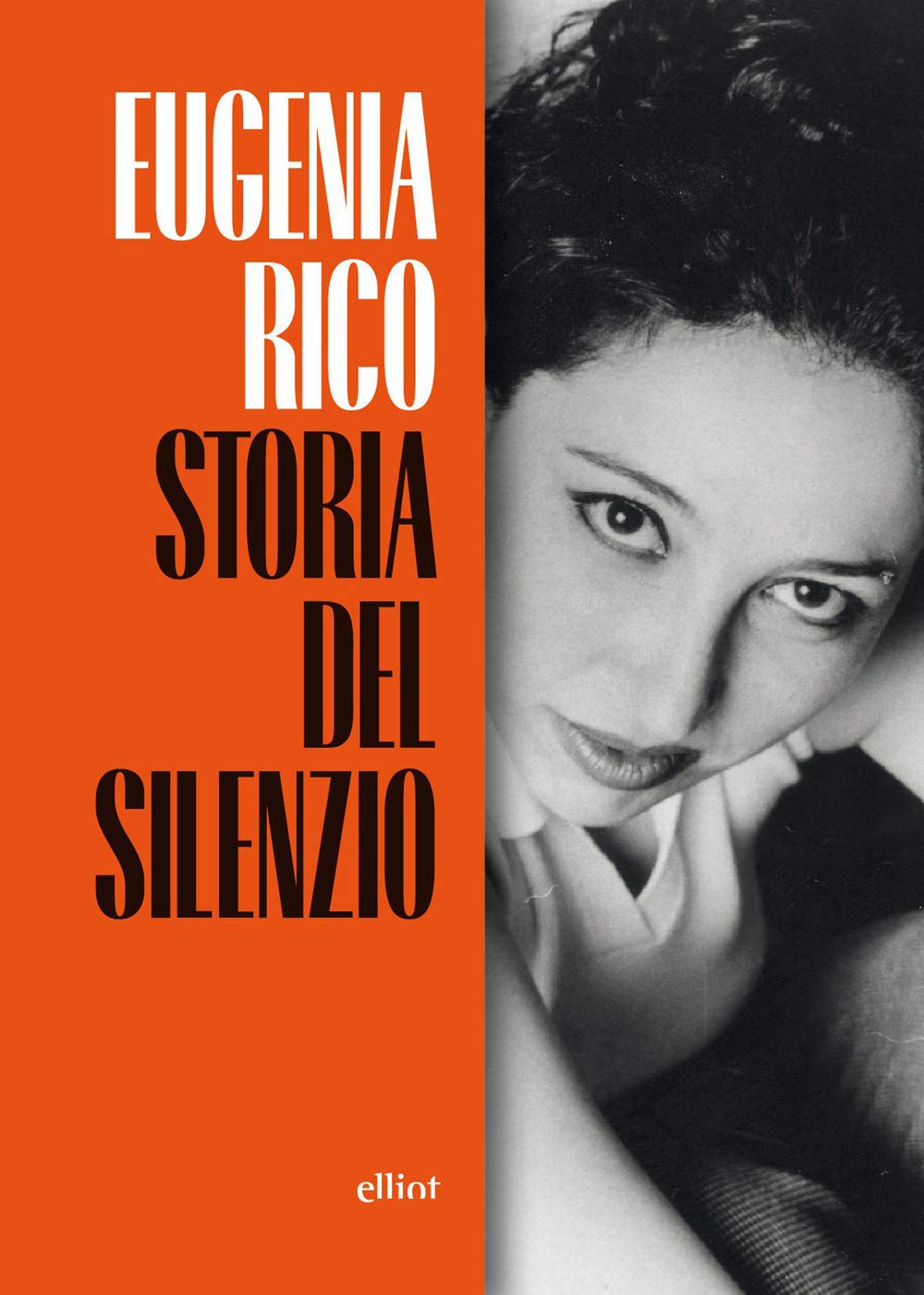






Commento all'articolo