Storia del mondo greco antico – François Lefèvre
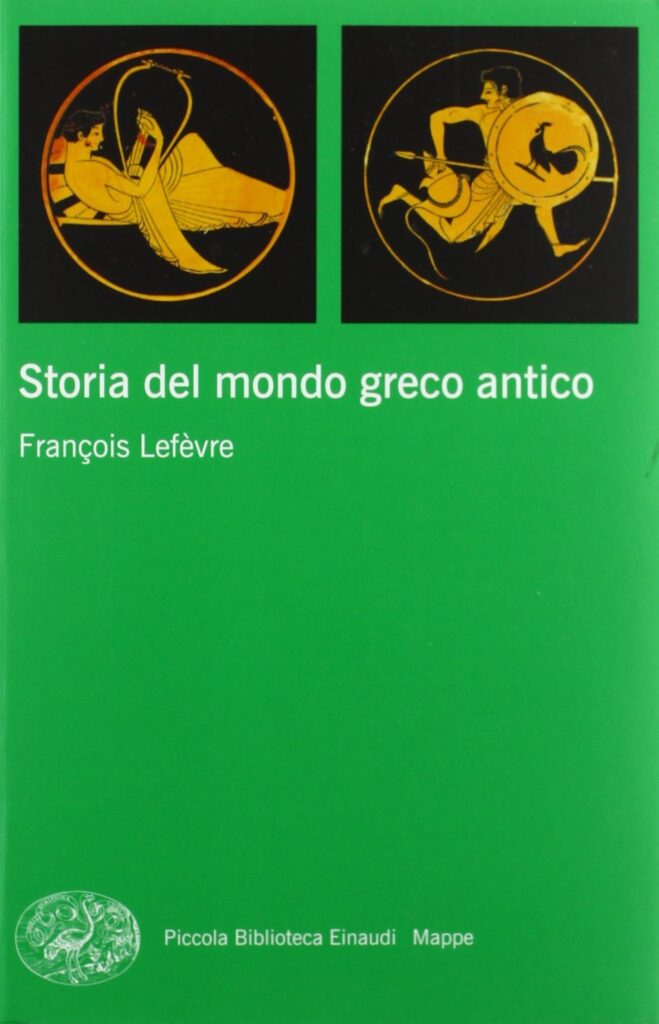
SINTESI DEL LIBRO:
I
popoli indoeuropei che verranno un giorno qualificati come
ellenici, chiamati talvolta «Proto-Greci», sono arrivati tardi nella
penisola balcanica, probabilmente verso la fine del III millennio. Ma
l’insediamento umano vi è adeguatamente attestato almeno a partire
dalla fine del Paleolitico medio, ossia circa 40 000 anni prima della
nostra èra. Le regioni interessate sono in particolare l’Epiro, la
Tessaglia, il Peloponneso e alcune isole come Corcira e l’Eubea, che
probabilmente erano ancora attaccate al continente. Nel Paleolitico
superiore (35 000-9000 circa) si pratica in Argolide la navigazione,
come mostra l’impiego dell’ossidiana di Melo. Dopo questo periodo, il
Mesolitico (all’incirca IX-VIII millennio) è meno noto, ma sembra fare
la sua comparsa un piccolo attrezzo adatto alle pratiche agricole e
che annuncia la fase successiva, il Neolitico (7000-3500 circa), il
quale in Grecia non segue lo sviluppo lento e progressivo che ha
avuto nel Vicino Oriente: quest’ultimo, da cui provengono per
esempio diversi cereali e specie animali domestiche, ha
manifestamente esercitato un’influenza che ha consentito un rapido
apprendimento delle tecniche nel versante europeo dell’Egeo,
secondo modalità su cui ancora si discute (diffusione con o senza
spostamento di gruppi umani, ecc.). Con l’avanzare della
sedentarizzazione, gli insediamenti si moltiplicano, anche se in modo
diseguale. La Tessaglia, per esempio, sembra essere, nelle prime
fasi del Neolitico, una delle regioni piú ricche e piú popolate.
Allevamento (capre e montoni), coltivazione dei cereali e di
leguminose, abbondante materiale litico e osseo, diffusione della
ceramica caratterizzano questo periodo di espansione. Mentre Creta
era stata anch’essa precocemente colonizzata, è nel Neolitico
recente (a partire dal 4800 circa), che tracce di insediamento sono
attestate con chiarezza nelle Cicladi e nella maggior parte delle altre
isole. In generale, gli scambi sembrano sempre piú ad ampio raggio,
ormai diffusi per tutto l’Egeo e differenziati a seconda dei tipi di
produzione (utensili di pietra lavorata, ceramica, «beni rari» come le
parures), mentre si sviluppano le tecniche (lame di selce, asce di
pietra levigata, ceramica fine policroma, ecc.) Strutture di tipo
megaron (edificio rettangolare bi- o tripartito che presenta, sullo
stesso asse, portico d’accesso, sala centrale oblunga ed
eventualmente una stanza collegata in fondo) tradiscono una forma
di differenziazione sociale (cfr. per esempio il sito di Dimini, in
Tessaglia). Dietro questi fenomeni, ritroviamo particolarismi regionali
che lasciano presupporre sia lo sviluppo di tradizioni locali risalenti al
Mesolitico, sia influenze diverse, per esempio migrazioni di contadini
anatolici per via marittima (cfr. le costruzioni cretesi in mattoni crudi,
forse di ispirazione asiatica).
Carta 2.
Il bacino egeo dal Neolitico al IX secolo.
2. La prima Età del Bronzo e l’arrivo dei «Proto-Greci».
L’uso dei metalli allo stato grezzo non era sconosciuto nel Neolitico
(Grecia del Nord, Attica e isole), ma è nella prima Età del Bronzo (o
Bronzo Antico, BA, all’incirca nel III millennio) che si diffonde
progressivamente la metallurgia (cfr. i giacimenti di piombo, di rame e
d’argento a Sifno e a Citno). Tra i principali siti archeologici, citiamo
Dikili Tash, nella Macedonia orientale, Eutresi in Beozia, Manika in
Eubea (alcuni chilometri a nord di Calcide), Kolonna a Egina, Lerna in
Argolide, Cnosso a Creta, Phylakopi nell’isola di Melo e Poliochni in
quella di Lemno, infine Troia in Asia Minore. L’accrescimento
numerico di insediamenti piú concentrati è una tendenza netta che
tradisce un’espansione demografica e un certo arricchimento,
accompagnato probabilmente dall’emergere di una élite contadina
(probabile comparsa dell’aratro, che presuppone l’impiego di bovini
da traino). Le tecniche agricole e artigianali si perfezionano (vigna,
ulivi, contrappesi e fusi per la filatura e la tessitura, fornace per
vasellame, ma la svolta sarà evidente solo nel Bronzo Medio). È in
questo contesto che si sviluppa la raffinata civiltà delle Cicladi, che ha
lasciato siti fortificati e celebri statuette antropomorfe di marmo,
talvolta di dimensioni abbastanza grandi e di interpretazione ancora
controversa, senza contare le «padelle per friggere» (oggetti in
terracotta cosí denominati per la loro forma, ma la cui funzione è
incerta) che recano rappresentazioni di navi di concezione già molto
evoluta. Non è da meno il continente, che ospita la civiltà dell’Ellade,
con le sue «case a corridoio» di cui Lerna ha fornito l’esempio piú
notevole: la «casa delle tegole», edificio di 25 × 12 metri, costituito da
stanze quadrangolari circondate da corridoi a partire dai quali si
sviluppano scale che portano al piano superiore, dotato di un tetto
ricoperto di tegole. In una delle stanze sono inoltre stati ritrovati sigilli
d’argilla che fanno pensare a una forma di economia controllata e
centralizzata, forse organizzata secondo il modello antropologico
delle chefferies, le comunità sottoposte a un «capo», fondate su
rapporti di parentela e piú o meno gerarchizzate.
Verso la fine di questo periodo (transizione tra il BA II e il BA III,
attorno al 2300), si osservano distruzioni su vasta scala, anche se
non omogenee, in particolare in Argolide (incendio della «casa delle
tegole») e nelle Cicladi, oltre a numerosi cambiamenti nella cultura
materiale e nei comportamenti (costruzioni absidate, ceramica e
utensili nuovi, tumuli e pratiche funerarie, ecc.) L’opinione oggi
prevalente, pur se con molteplici sfumature, colloca in questo
momento una tappa fondamentale, in base a un ragionamento che si
regge su due termini principali. In primo luogo, non si conoscono
sconvolgimenti cosí rilevanti tra questa fase e il momento in cui il
greco è sicuramente parlato nella penisola, ossia l’epoca delle piú
antiche tavolette in lineare B trovate nei palazzi (probabilmente XV
secolo, cfr. cap. V). In secondo luogo, il greco utilizzerà sempre
parole di parlate differenti, per esempio toponimi o termini tecnici in
nth, come labyrinthos (forse il nome minoico del palazzo di Cnosso),
che è naturale considerare come mutuato dalle lingue locali
preesistenti («substrato pre-ellenico», un insieme a cui i Greci
attribuiranno, fra altri, il nome di «Pelasgi»). Il concorso di questi due
elementi, archeologico e linguistico, porta a situare in questo
orizzonte l’arrivo delle prime popolazioni ellenofone, vale a dire verso
il 2300 a. C. Peraltro, sulla questione continueranno a fiorire ipotesi e
ricostruzioni divergenti: alcuni, considerando eccessivo lo scarto
rispetto alle prime tracce scritte, hanno voluto avvicinare questa
migrazione al XV secolo, altri invece hanno fatto risalire la diffusione
delle lingue proto-indoeuropee all’inizio del Neolitico. Le cronologie
piú dettagliate a cui è giunta oggi l’archeologia mostrano del resto
che non tutte le regioni sono state coinvolte contemporaneamente,
allo stesso ritmo o con la stessa ampiezza, e che alcuni elementi
della nuova cultura materiale erano già in uso prima delle distruzioni.
Si potrebbe dunque parlare di «infiltrazione graduale», per lo meno
tanto quanto si parla di «invasione violenta». Resta da precisare chi
fossero questi nuovi arrivati.
Il
greco (si tratta infatti, prima di tutto, di considerazioni
linguistiche) appartiene alla famiglia indoeuropea, che raggruppa in
particolare le lingue antiche dell’India, della Persia e dell’Anatolia
(ittita, ecc.), le lingue slave, germaniche, italiche e celtiche. Queste
lingue presentano rilevanti similitudini lessicali e grammaticali e, sulla
scia degli studi di Georges Dumézil, sono state messe in luce anche
somiglianze tra le strutture teologiche e istituzionali. Si è dunque
supposto che queste popolazioni fossero imparentate e provenissero
da una stessa regione, forse le steppe della Russia meridionale (ma
ne sono state proposte altre), da cui sarebbero sciamate a partire dal
Neolitico, in ondate successive. Anche il ramo ellenico s’insedia
nell’Egeo a strati, individuabili in base ai dialetti conosciuti dal periodo
miceneo fino all’epoca storica (cfr. capp. V e VI). Bisogna aspettare
tuttavia alcuni secoli perché i nuovi arrivati facciano parlare di sé: non
sappiamo se la Creta del leggendario re Minosse, la prima civiltà
europea paragonabile per il suo splendore a quelle d’Egitto e
dell’Oriente, fosse indoeuropea.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :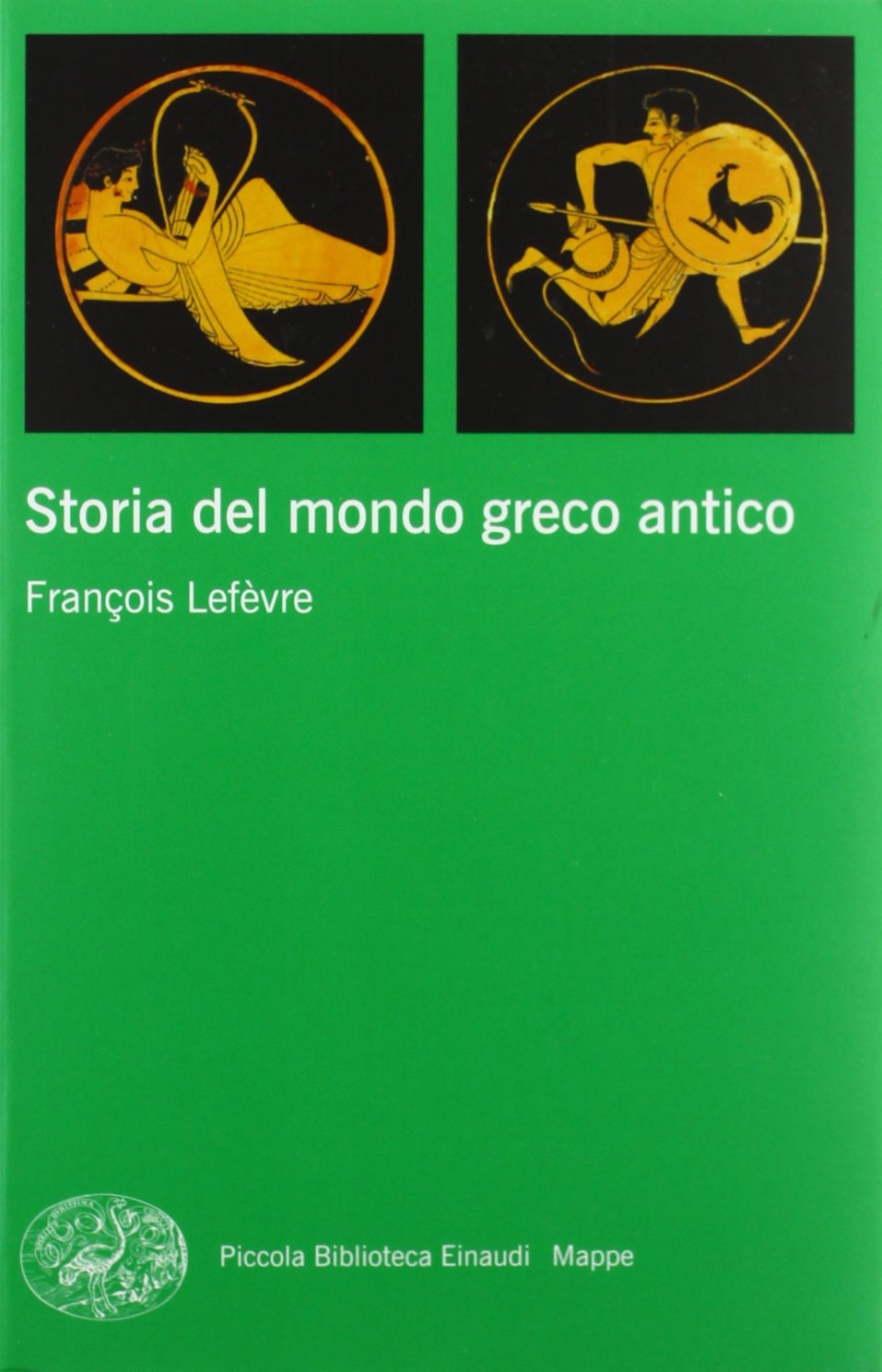






Commento all'articolo