Stile moderno – Saggi di estetica sociale – Georg Simmel
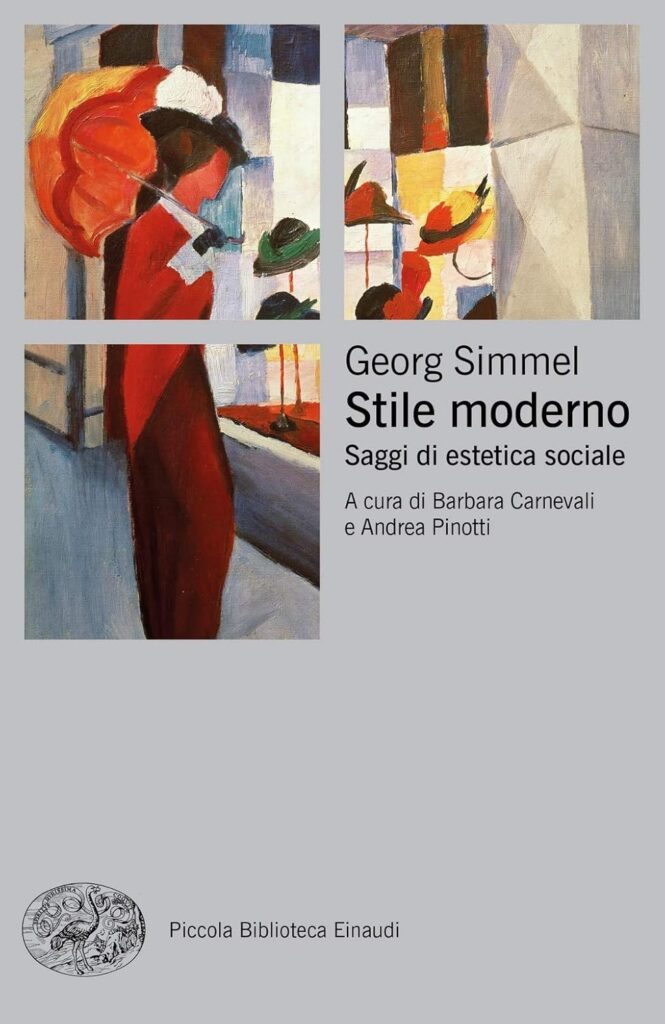
SINTESI DEL LIBRO:
Lo studio dell’agire umano deve il suo fascino sempre rinnovato
all’inesauribile varietà di combinazioni che si ottengono miscelando
pochi toni di base, sempre gli stessi, con una sontuosa palette di
gradazioni e sfumature in perenne mutamento, sempre diverse.
Tutte le tendenze, gli sviluppi, i contrasti della storia umana si
possono ricondurre a un repertorio sorprendentemente ristretto di
motivi originari. Anche il poeta lirico e il drammaturgo, come ha
osservato qualcuno, non fanno in realtà che rielaborare in forme
mutevoli un nucleo ridottissimo di variabili, perché i destini di un
personaggio soggiacciono a un numero finito di possibilità interiori
ed esteriori. Lo stesso vale per tutti gli altri ambiti in cui opera
l’uomo, anzi: il repertorio dei motivi di fondo si va progressivamente
restringendo a mano a mano che allarghiamo la visuale, finché,
quando prendiamo in considerazione la vita nei suoi termini piú
generali, ci troviamo quasi immancabilmente a che fare con una
dualità, e la vita stessa, nelle sue conformazioni sempre diverse, ci
appare come un prodotto della lotta, del compromesso, della
combinazione di quei due principî antinomici. Ciascuna epoca tende
a ridurre la proliferazione incontrollata delle proprie manifestazioni a
un antagonismo binario tra opposte tendenze del pensiero e della
vita, la cui dualità esprime nella forma piú semplice le grandi direttrici
di fondo dell’esistenza umana. Eppure quella contrapposizione vitale
profonda, insita in tutto ciò che è umano, si può afferrare solo per
simboli ed esempi, e in ogni grande epoca storica tende a
cristallizzarsi in una configurazione specifica che poi funge da
paradigma e forma prototipica. Ai primordi della filosofia ellenica, per
esempio, ritroviamo la grande disputa tra Eraclito e il pensiero
eleatico: per l’uno l’essere consisteva in un eterno fluire, e il divenire
del mondo si adempiva ai suoi occhi nella varietà di infiniti contrasti
che trapassavano senza posa gli uni negli altri; per gli eleati, invece,
sotto il velame dell’ingannevole apparenza sensibile riposava un
essere unico in perpetua quiete, onnicomprensivo, indiviso, l’unità
assoluta e indifferenziata di tutte le cose. E questa è appunto la
forma prototipica che la grande antitesi alla base della natura umana
assume nel pensiero greco, il cui intero arco storico è fatto di
variazioni su quel tema. Con l’avvento del cristianesimo entra in
gioco un’altra configurazione: il contrasto tra il principio divino e il
principio terreno. In tutte le forme specificamente cristiane della vita
quella polarità si esprime come antinomia ultima e assoluta tra
opposte direttrici dell’esistenza: un’alternativa alla quale occorreva
ricondurre tutte le differenze nel volere e nel pensare, ma che a sua
volta non ammetteva alcuna ulteriore riduzione, cioè non rimandava
ad alcuna dualità piú profonda. Le concezioni della vita che si sono
affermate in epoca moderna hanno quindi ulteriormente elaborato
quel motivo nella forma di un contrasto fondamentale tra la natura e
lo spirito. Quanto al presente, quel dualismo che divide gli esseri
umani, anzi, che polarizza ciascuna psiche al proprio interno, ha
trovato espressione nella formula che vede la tendenza socialista
contrapporsi alla tendenza individualista. In quell’alternativa di fondo
sembra essersi manifestata in forma tipica una disparità irriducibile,
inscritta nel carattere degli esseri umani e delle loro istituzioni: uno
spartiacque divide la loro corrente in due rivoli che si divaricano per
poi tornare a convergere, determinando la realtà in funzione del
rispettivo dosaggio e dei loro effetti sinergici. Il discrimine che corre
tra questi due modi di pensiero sembra trovare un prolungamento in
tutti gli interrogativi di cui è fatta la vita, e quella forma di
configurazione del carattere che in ambito socio-politico si esplicita
nell’opposizione tra tendenze socialiste e tendenze individualiste si
ritrova anche in ambiti lontanissimi da quella sfera, concretizzata e
inscritta nelle materie piú diverse. All’estremo superiore come a
quello inferiore dell’esistenza, la stessa struttura governa gli interessi
puramente materiali della vita e la visione estetica del mondo. E
appunto a proposito di estetica, l’essenza della contemplazione e
della rappresentazione risiede ai nostri occhi proprio nella capacità
di far trasparire il tipico nell’individuale, la legalità nell’accidentale, la
sostanza e il significato intrinseco negli aspetti esteriori e transeunti
delle cose. Nessuna manifestazione fenomenica sembra eludere
questa riduzione a ciò che in essa è gravido di significato ed eterno.
Perfino le cose piú vili, perfino le piú brutte possono tradursi in un
gioco di colori e forme, sentimenti ed esperienze capace di conferire
loro una pregnanza e un fascino; quando le esaminiamo con la
necessaria cura perfino nelle cose indifferenti, la cui manifestazione
isolata ci appare banale o addirittura ripugnante, ci sembra di
sorprendere una radiazione o un’eco di quell’unità ultima di tutte le
cose che riverbera su ogni fenomeno come bellezza e senso
quell’unità che ogni filosofia, ogni religione, ogni attimo di elevazione
e trasporto del sentire si sforzano di esprimere per simboli. Di fronte
a questo immergersi nella profondità di ciò che esiste, quando si
accetta di portarlo alle sue estreme conseguenze filosofiche,
scompare qualunque differenza di grado nella bellezza delle cose. E
allora la nostra visione del mondo diventa panteismo estetico:
qualunque segmento della realtà cela la possibilità di un riscatto dato
da una pregnanza estetica assoluta, e da qualunque segmento della
realtà – a condizione di saper vedere – traspaiono tutta la bellezza e
tutto il senso della totalità del mondo. A quel punto, però, la singola
entità perde ogni significato in quanto tale: quel significato che le
ineriva in quanto cosa specifica, diversa da tutte le altre. Perché
quella pregnanza individuale va perduta nel momento in cui si
afferma che la ricreazione e l’approfondimento del reale in chiave
estetica, in quanto possibili sempre e comunque a proposito di tutto
ciò
che esiste, concederebbero finalmente alle differenze
contenutistiche e qualitative della bellezza singola di esprimersi
senza piú limitazioni; in cui si precisa che non si tratta di fare di ogni
erba un fascio, ma di garantire alle cose pari diritti estetici; in cui si
ribatte che un simile sguardo si limiterebbe a cancellare le differenze
di rango tra gli enti, ma non le differenze di toni e valori, le differenze
sensibili e intelligibili, la differenza tra l’Allegro e l’Adagio. Una simile
concezione, che ambisce a contemperare le attrattive di una parità e
omogeneità assolute con quelle dell’individualismo estetico, però,
pecca contro quest’ultimo. Perché solo la gerarchizzazione dei valori
– il primato di ciò che è piú significativo su ciò che è piú indifferente,
il
potenziamento e lo sviluppo organico che dalla materia inerte
fanno scaturire la materia animata, da ciò che ancora grezzo
ricavano ciò che è piú raffinato – ha il potere di conferire agli esiti
supremi di quella sequenza un risalto, una statura e una luce propria
alla quale in un regime di perfetta equipollenza estetica nessun ente
potrebbe mai aspirare: laddove un chiarore uniforme illumina tutto
senza distinzione le cose piú basse vengono equiparate alle piú alte,
ma quelle piú alte, in compenso, vengono equiparate alle piú basse.
Le sensazioni umane non possono fare a meno del contrasto: a
questo riguardo la percezione del valore funziona esattamente come
la sensibilità cutanea o termica. Non possiamo sempre muoverci alla
stessa quota, e meno che mai rimanere sempre all’altezza delle
vette che ci è dato toccare solo nei nostri istanti supremi. Per cui
l’elevazione delle cose infime all’altezza dell’estetica si paga con la
rinuncia a quegli slanci vertiginosi che, sebbene rari e occasionali,
possono darsi soltanto per contrasto, sullo sfondo di un mondo
meno nobile, piú torpido e piú oscuro. A far dipendere il valore delle
cose dallo scarto che le separa, però, non è soltanto questo vincolo
per cui la nostra capacità percettiva funziona solo grazie al
contrasto, magari per un difetto congenito della nostra natura che
potremmo sentirci tentati di voler trascendere, no: quel differenziale
è in sé e per sé all’origine di una bellezza positiva. Il mondo è fatto di
tenebre e di luce, i suoi elementi non trascorrono gli uni negli altri in
modo amorfo e generico, come se si equivalessero tutti, ma
ciascuna realtà occupa un gradino specifico in una tassonomia di
valore, trovando posto tra qualcosa di piú elevato e qualcosa di piú
basso; e le cose piú rudimentali e modeste si giustificano fungendo
da supporto o da sfondo, e quindi dando maggiore risalto alle realtà
piú sofisticate, luminose e nobili: e in questa gerarchizzazione
l’immagine del mondo trova di per sé un valore e un fascino di
suprema levatura estetica. Giungiamo cosí a un bivio: la persona
che non esita a sacrificare mille realtà inferiori per una sola realtà
superiore, facendo risiedere il pregio delle cose tutte nel loro
culmine, dal quale irradiano verso il basso il senso e il valore che
competono a ciascuna secondo il proprio livello, non si intenderà mai
con la persona che, invece, è convinta di sorprendere la voce del
Signore nell’ultimo dei vermi e sente come giusta ed equa la pretesa
delle cose a non valere piú o meno delle altre. E chi sente come uno
spettacolo necessario l’articolazione e l’ordinamento per gradi, chi
non rinuncia alla bellezza di un’immagine del mondo organizzata
secondo il piú e il meno, non potrà mai condividere il vissuto di chi
scorge l’armonia delle cose nella loro pari dignità, e agli occhi del
quale le attrattive sensibili e il loro contrario, la bruttezza, oppure il
caos piú assurdo e la forma piú compiuta, altro non sono che meri
involucri esteriori, perché oltre quel velo, afferrato secondo la sua
sostanza, l’essere è sempre bello, sempre intriso di spirito, e di
quella bellezza omogenea aspireremmo a dissetarci. Pretendere di
trovare un terreno d’intesa, magari per conciliare le due posizioni nel
nome di un concetto e di una teoria capaci di far apparire questi due
opposti sentimenti del valore come compatibili tra loro, o addirittura
convergenti in qualche anelito di ordine superiore, al limite
adducendo il fatto che in molti di noi, seppure a dosaggi variabili,
operano entrambi i principî, sarebbe come pretendere di far
dimenticare la differenza tra il giorno e la notte adducendo
l’esistenza del crepuscolo. Siamo vicini alle sorgenti di tutto ciò che è
umano, le fonti dalle quali, secondo gli ambiti che le loro correnti
vivificano, scaturiscono i titanici contrasti del socialismo e
dell’individualismo in politica, del sapere panteistico e della
conoscenza atomistica nelle scienze, della equiparazione e della
differenziazione tra le cose in estetica. Quelle fonti come tali, cioè
quegli orientamenti ultimi della nostra natura, non si possono
indicare a parole: si danno a conoscere solo nei singoli fenomeni, in
quanto influenzano o per cosí dire compenetrano i contenuti empirici
della vita, o se non altro si possono indicare come quelle forze senza
nome che plasmano la materia della nostra esistenza secondo forme
eternamente inconciliate, ma proprio per questo capaci di sollecitarsi
a vicenda, facendo scattare quegli stimoli sempre nuovi che
conferiscono alla vita della nostra specie il suo tipico carattere
irrequieto, quello di un’eterna lotta e oscillazione tra estremi opposti,
tanto che appagare un’esigenza significa già cedere alle seduzioni
dell’altra. E solo in quel movimento ha luogo la conciliazione, l’unica
possibile: non uno sterile teorema che pretendesse di ridurre
l’antagonismo all’unità concettuale, ma appunto l’eterno incontro e
l’eterna lotta di opposti antinomici nel quadro di una specie vivente,
anzi, nell’interiorità di ogni singolo individuo. Perché l’anima umana è
sublime e sovrana proprio in quanto la sua “vita vivente”, quella sua
unità che sfugge a ogni concetto, è dinamizzata senza posa da forze
che, prese ciascuna per sé, sgorgano da fonti del tutto incompatibili
e ambiscono a sfociare in direzioni del tutto diverse.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :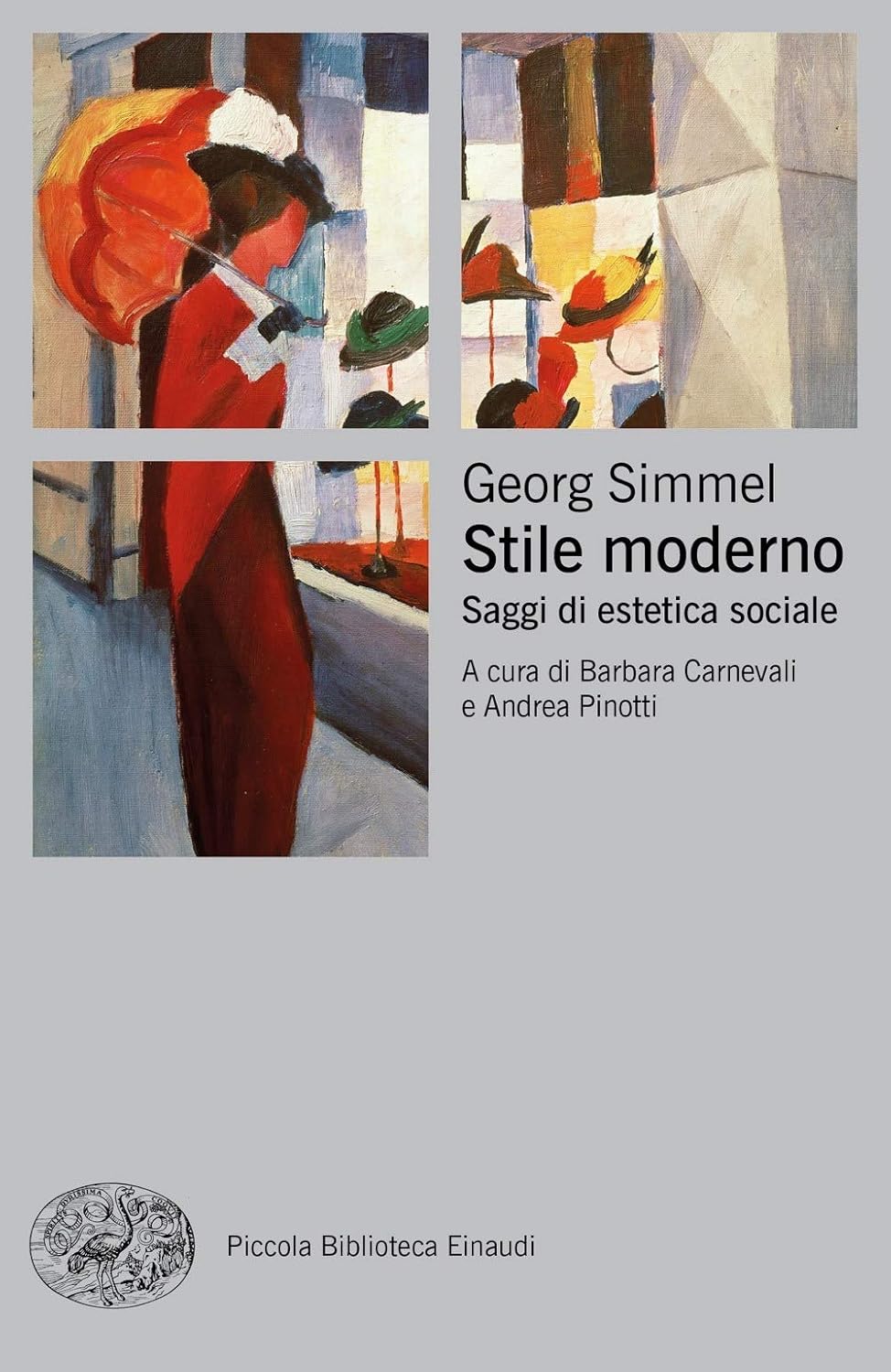






Commento all'articolo