SPQR – Storia dell’antica Roma – Mary Beard
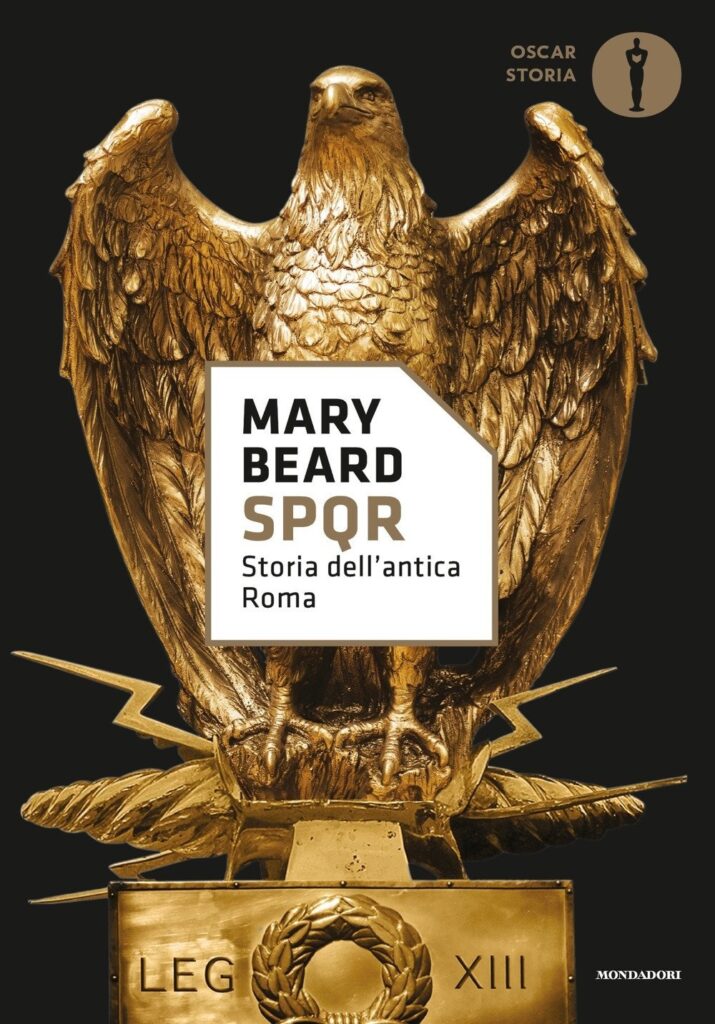
SINTESI DEL LIBRO:
La nostra storia dell’antica Roma inizia verso la metà del I secolo a.C.,
più di seicento anni dopo la sua fondazione. Inizia con promesse di
rivoluzione, con una cospirazione terroristica per distruggere la città,
con operazioni segrete e arringhe pubbliche, con una battaglia
combattuta da romani contro altri romani, e con cittadini (innocenti o
no che fossero) arrestati e sommariamente giustiziati in nome della
sicurezza della patria. L’anno è il 63 a.C. Da una parte troviamo Lucio
Sergio Catilina, un insoddisfatto aristocratico in bancarotta, che, a
quanto si credeva, aveva architettato un piano per assassinare i
magistrati eletti di Roma e bruciare la città stessa, cancellando nel
contempo tutti i debiti, dei ricchi come dei poveri. Dall’altra parte
Marco Tullio Cicerone, il celebre oratore, filosofo, sacerdote, poeta,
politico e arguto narratore, una delle vittime designate della congiura;
un uomo che, per tutta la vita, non smise mai di sfruttare le proprie
doti oratorie per vantarsi di come aveva smascherato il terribile
complotto di Catilina e salvato lo stato. Fu il suo momento di massima
gloria.
Nel 63 a.C. Roma era una metropoli con oltre un milione di abitanti,
più vasta di qualsiasi altra città d’Europa prima del XIX secolo; e,
sebbene non avesse ancora imperatori, dominava su un impero che si
estendeva dalla Spagna alla Siria, dalla Francia meridionale al Sahara.
Era una caotica miscela di lusso e sporcizia, di libertà e sfruttamento,
di orgoglio civico e spietata guerra civile. Nei capitoli seguenti
torneremo molto indietro nel tempo, fino ai primi giorni della città e
alle prime imprese, belliche e non solo, del popolo romano.
Rifletteremo su ciò che si cela dietro alcune storie della Roma arcaica
che ancora oggi ci colpiscono, come quella di «Romolo e Remo» o
quella dello «stupro di Lucrezia». E ci porremo domande che gli
storici si sono fatti fin dall’antichità. Come, e perché, una piccola e
insignificante città dell’Italia centrale è riuscita a diventare più grande
di ogni altra città dell’antico Mediterraneo e a dominare un impero
così esteso? C’era per caso qualcosa di speciale nei romani? Con la
storia di Roma, però, non è opportuno iniziare il racconto dal
principio. È soltanto a partire dal I secolo a.C. che possiamo esplorare
Roma nei più vividi dettagli attraverso gli occhi degli stessi
contemporanei. Un numero straordinariamente elevato di testi
proviene da quest’epoca, dalle lettere private ai discorsi pubblici, dalla
filosofia alla poesia: epica ed erotica, erudita e di strada. Grazie a tutto
ciò, possiamo ancora seguire il tran-tran quotidiano e gli affari dei
grandi uomini politici. Possiamo ascoltare le loro trattative e spiare i
loro compromessi, osservare i loro tradimenti e le loro pugnalate alla
schiena, reali o metaforiche. Possiamo persino assaporare la loro vita
privata: i bisticci coniugali, i problemi finanziari, il dolore per la morte
di figli amatissimi o talvolta di uno schiavo particolarmente
apprezzato. Nessun periodo nella precedente storia dell’Occidente
può essere conosciuto altrettanto bene o così in profondità (l’Atene
classica non ci ha lasciato testimonianze ugualmente ricche e
diversificate). Soltanto più di un millennio dopo, nella Firenze
rinascimentale, troviamo un luogo che possiamo conoscere in modo
così dettagliato.
Per di più, è proprio nel I secolo a.C. che gli autori romani
iniziarono a studiare sistematicamente i primi secoli della loro città e
del loro impero. L’interesse per il passato di Roma risale senza dubbio
a un periodo ancora precedente: possiamo leggere, per esempio,
un’analisi dell’ascesa di Roma scritta da un greco residente nella
capitale attorno alla metà del II secolo a.C. Ma è soltanto a partire dal I
secolo a.C. che gli studiosi e i critici romani cominciarono a porsi gran
parte delle domande che ci facciamo ancora oggi. Affiancando alla
ricerca erudita una buona dose di immaginazione ricostruttiva,
delinearono un quadro della Roma arcaica dal quale ancora oggi
dipendiamo. Ai nostri giorni vediamo la storia romana, almeno in
parte, attraverso gli occhi del I secolo a.C. In altre parole: la storia di
Roma, come noi la conosciamo, comincia qui.
1. I possenti archi e le colonne del Tabularium, incorporati nel Palazzo di
Michelangelo, si stagliano ancora a un’estremità del Foro romano. Eretto
soltanto un paio di decenni prima del consolato di Cicerone nel 63 a.C., deve
essere sembrato allora una delle più splendide opere architettoniche di Roma.
La sua funzione è meno chiara. Era senz’altro un edificio pubblico, ma non
necessariamente l’«archivio di stato» (tabularium), come si ritiene spesso.
Il 63 a.C. è una data rilevante in questo secolo cruciale. Fu l’anno in
cui la città si trovò sull’orlo della catastrofe. Negli oltre mille anni che
percorreremo in questo libro, Roma dovette affrontare numerose
sconfitte e gravi pericoli. Attorno al 390 a.C., per esempio, una banda
di predatori galli occupò la città. Nel 218 a.C. il condottiero
cartaginese Annibale attraversò le Alpi con i suoi trentasette elefanti e
inflisse terribili perdite ai romani, che riuscirono a sconfiggerlo solo
dopo grandissimi sforzi. Le stime romane dei caduti nella battaglia di
Canne, nel 216 a.C. (settantamila morti in un solo pomeriggio), fanno
di questo scontro una carneficina pari a quella di Gettysburg o del
primo giorno della Somme, se non addirittura maggiore. Nel terzo
decennio del I secolo a.C., lasciando un ricordo quasi altrettanto
terribile nell’immaginario romano, un esercito improvvisato composto
da ex gladiatori ed evasi, sotto il comando di Spartaco, si dimostrò un
osso davvero duro per alcune mal addestrate legioni romane. I romani
non furono mai così invincibili in battaglia come tendiamo a credere o
come essi volevano far credere. Nel 63 a.C., comunque, dovevano
affrontare un nemico interno, un complotto terroristico nel cuore
stesso dell’establishment cittadino.
Possiamo ripercorrere la storia di questa crisi fin nei minimi
dettagli, giorno per giorno, addirittura ora per ora. Sappiamo
perfettamente dove si è svolta gran parte degli eventi, e in certi casi
possiamo ancora osservare gli stessi monumenti che dominavano la
scena nel 63 a.C. Possiamo seguire le operazioni segrete con cui
Cicerone ottenne le sue informazioni sul complotto, e come Catilina fu
costretto a lasciare la città e a riunirsi con il suo esercito improvvisato
per affrontare le legioni romane in una battaglia che gli costò la vita.
Possiamo anche ascoltare una parte delle discussioni, delle polemiche
e degli interrogativi che la crisi sollevò e che a distanza di oltre
duemila anni ripropone. La dura risposta di Cicerone (comprese le
esecuzioni sommarie) esprime in forma particolarmente chiara
questioni che ci preoccupano ancora oggi. È legittimo eliminare dei
«terroristi» scavalcando le giuste procedure di legge? Fino a che punto
si possono sacrificare i diritti civili in nome della sicurezza nazionale?
I romani non smisero mai di discutere sulla «congiura di Catilina»,
come venne chiamata. Catilina era un uomo assolutamente malvagio,
oppure si può dire qualcosa in sua difesa? A quale prezzo si evitò la
rivoluzione? Gli eventi del 63 a.C., e gli slogan allora coniati, hanno
continuato a riecheggiare per tutto il corso della storia dell’Occidente.
Alcune delle parole pronunciate durante gli infuocati dibattiti che
seguirono la scoperta del complotto sono ancora impiegate nella
nostra retorica politica e, come vedremo, continuano a comparire sui
volantini, sugli striscioni, e persino nei tweet, dell’odierna protesta
politica.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :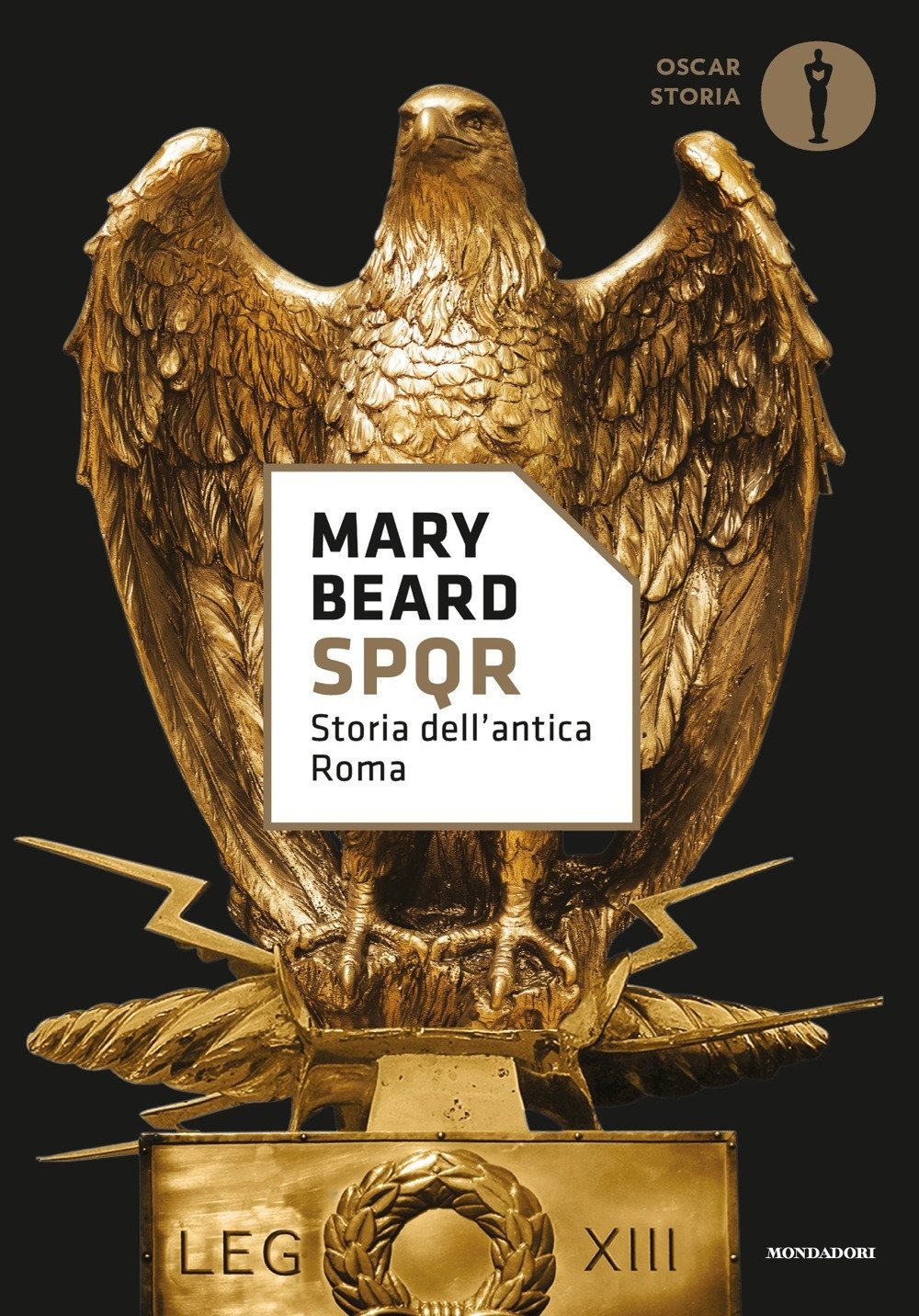






Commento all'articolo