Società – per azioni – Beppe Sala
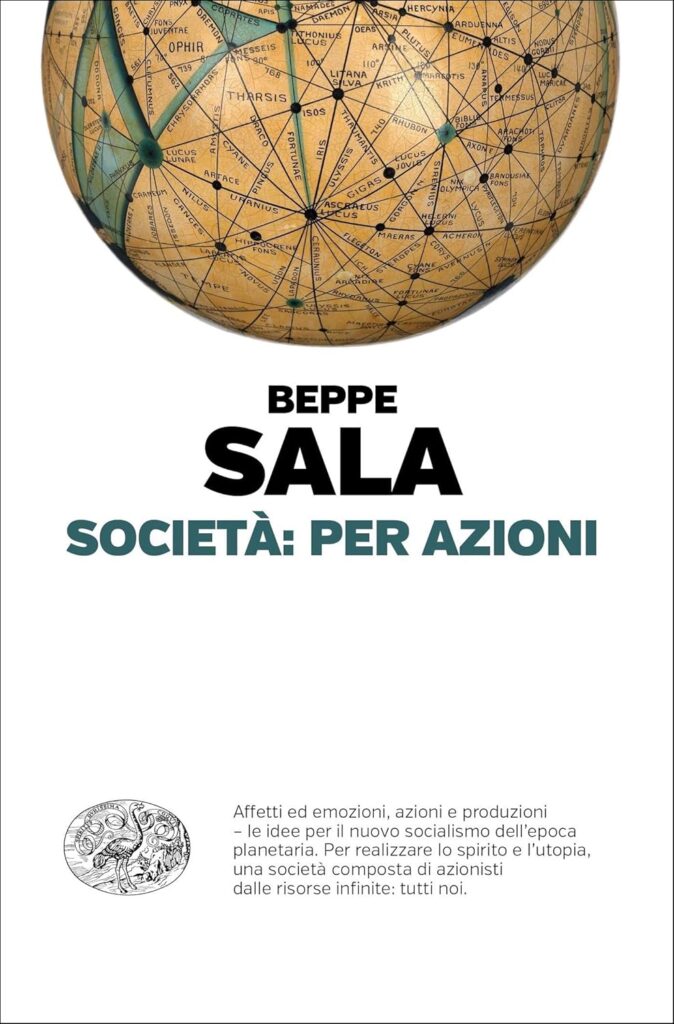
SINTESI DEL LIBRO:
Ho indagato me stesso.
E mi sono domandato come potrebbe uno nascondersi a ciò che
è stato e che è divenuto.
Formandomi mi sono accorto delle trasformazioni che ho subito e
che forse sono simili, o addirittura identiche, ai cambiamenti a cui
sono stati esposti tutti gli altri, arrivando qui e ora, in un tempo
contraddittorio come sono tutti i tempi. Contraddittorio in maniera
diversa, però. In maniera specifica.
Mi sono chiesto dove vedere l’inizio di tutto questo e l’inizio era un
giorno primaverile del 1978 a Milano. Precisamente il 9 maggio
1978, di mattina, nel chiuso illuminato a neon di una biblioteca
universitaria. Riflettevo su un testo di economia aziendale. Mi
sembrava così incongruo, con le sue formulazioni astratte, rispetto
alla vita reale di un maggio stranamente profumato. Milano è una
città in cui l’olfatto si neutralizza. Le grandi città hanno da sempre
questo problema, il rischio di addormentare i sensi, lo sguardo
costretto tra geometrie innaturali, gusto e odorato abbattuti dalla
chimica e dall’inquinamento. L’inquinamento, nel ’78, si chiamava
smog. La metropoli in un certo senso anestetizza, riduce le
percezioni, perché è un mondo trasformato. Mi sentivo un po’
astratto, come le formulazioni dell’economia aziendale.
All’inizio non notai il commesso. Sedevo orientato verso la parete
a est, tutti gli studenti bocconiani chini sui testi, in assenza di bisbigli.
Un silenzio che oggi, in un’epoca che ne è totalmente priva, si
direbbe assordante. Ero troppo concentrato, per notare l’entrata del
commesso.
Si trattava di un momento della vita in cui ero in assoluto troppo
concentrato su me stesso. Venivo dalla provincia, la Brianza operosa
e taciturna, da cui avevo anzitutto appreso l’operosità, appunto,
come tratto essenziale del vivere. Fare senza parlare. O, al limite,
fare e solo dopo parlare. Il corrispettivo del valore di ogni azione in
soldi. Un’etica del lavoro rigorosa. L’iscrizione all’università Bocconi,
costosa per la mia famiglia, mi serviva a confermare quel
temperamento, ma anche a liberarmene. La provincia
indubbiamente mi costituiva, ma non mi bastava. Cercavo una
forma, una dimensione personale, che mi permettesse di
trascendere le mie origini, a partire proprio dall’elemento
professionale, dal culto eccessivo del lavoro: vivere per lavorare,
anziché lavorare per vivere.
Chino sul libro e su me stesso, un giovane che cerca di
sprovincializzarsi, concentrato su ciò che ha da realizzare. Prima di
tutto, sé stesso. Privo di substrato, assetato di ciò che la famiglia
non poteva dare, proiettato in avanti, confuso sull’identità, all’inizio
della propria storia.
Il commesso entrò dalla porta con cautela. Era tutto molto calmo,
un ambiente ovattato. Non notai le basette eccessive dell’uomo, il
suo maglione a collo alto – me ne resi conto in un secondo
momento. Colsi invece il colorito: il pallore del meridionale adottato
da una terra di nebbia e di piogge insistenti, dove la luce è graduata,
grigia. La pelle di tutti noi era ingrigita, erano anni vissuti in bianco e
nero. Però il pallore del commesso in qualche modo mi colpì, forse
anche per lo sguardo stravolto e il modo in cui si chinò verso uno
studente seduto in una fila vicino all’ingresso, sussurrando qualcosa
di indefinito. Che si allargò come un’onda. Un mormorio istantaneo,
un brusio generalizzato, come un vasto telefono senza fili, una voce
che correva in ogni direzione fino a raggiungermi. Dopo 55 giorni di
sequestro, era stato ritrovato cadavere il presidente democristiano
Aldo Moro. Avevo vent’anni.
La reazione fu che non ci fu reazione. O fu molto limitata. Spento
quel sussurro generale, i corpi si ricomposero e ripresero la postura
di studio. Non successe granché. La storia della nazione giungeva al
suo collasso e nessuno si mosse. Osservavo le nuche di chi si
ingobbiva sui libri di testo, nelle file davanti a me. Io stesso non feci
che riprendere a studiare. Ascoltai la notizia, la elaborai, tornai sul
libro di testo. Ma nell’elaborazione qualcosa era accaduto.
La disponibilità di immagini istantanee era impensabile nel
maggio del 1978. Avremmo dovuto attendere le edizioni speciali dei
quotidiani nel pomeriggio o lo schermo di qualche televisore
sintonizzato sul telegiornale, per vedere l’immagine conclusiva di
Aldo Moro, quella che apriva un capitolo infinito della nostra storia. A
quei tempi passavano lunghe ore prima di appropriarsi di
un’immagine, anche se quelle ore forse non ci sembravano così
lunghe – oggi ci sembrerebbero intollerabilmente lunghe. Così, di
fronte alla notizia ma non alla foto, divenuta storica, del cadavere di
Aldo Moro nel bagagliaio della Renault 4, io sentii che era il
momento dell’esistenza collettiva e individuale in cui è richiesto di
esprimere un pensiero. E però avvertii questo: non ce la faccio.
La morte di Moro è un attimo genetico per la storia italiana, ma
per me lo è doppiamente, perché è il primo istante politico in cui
misuro appieno la mia insufficienza.
Lì, in quell’istante, mi accorgo che nei 55 giorni del sequestro non
avevo compreso a fondo la vastità, la profondità di un dramma in
atto e la sua tragedia così incisiva, la possibilità di una ferita che non
gronda semplicemente sangue, ma che non si cicatrizzerà. È
qualcosa che avrei realizzato negli anni seguenti e che ancora oggi
non smetto di avere presente.
Se la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi, la
politica è l’anticipazione di una guerra condotta con differenti
modalità. A ogni mutamento significativo della politica, a ogni ciclo
che termina perché se ne innesti uno successivo, si sperimenta uno
smarrimento generalizzato, la paura dei corpi sociali che erano
abituati all’ordine precedente delle cose. La politica prefigura sempre
un’apocalisse, ma tratta inesauribilmente perché la fine non arrivi. La
morte di Aldo Moro portava a compimento proprio quest’apocalisse:
l’uomo della trattativa infinita, il lento progressista alla ricerca di una
soluzione pratica da assumere insieme, incappa nella sua stessa
fine, che coincide con l’estinguersi di un intero ordine precedente, di
cui era stato l’interprete più acuto e progettuale. Dopo il suo
omicidio, secondo la profezia inscritta nelle lettere che inviava dalla
sua prigione, il suo sangue sarebbe ricaduto su chi apparteneva
all’ordine precedente e avrebbe continuato a riversarsi in quello
successivo.
All’indomani della morte di Moro si apriva un tempo di tipo
diverso. Una democrazia diversa, fondata sull’immagine che avrei
visto a sera, non ricordo più se in bianco e nero o a colori tremuli:
l’immagine spaventosa, il cadavere del presidente in un bagagliaio,
attorno al quale si agitano forze dell’ordine, giornalisti, alti funzionari,
poca gente.
Lo vidi nello schermo, come tutti. Ma io con il sentimento
sgradevole di non essere parte del momento, di non avere le risorse
per reagire. Parlo di me. Sarebbe irrilevante il racconto di una storia
individuale, se non fosse l’inizio di un processo in cui matura una
scelta politica, cioè comprendere che davvero ci si salva – e si va
avanti – soltanto se si agisce insieme e non solo uno per uno.
Separato in mezzo agli altri, a quel gruppo di studenti che stanno
insieme e sono divisi gli uni dagli altri, tutti compresi dall’esigenza di
studiare e di creare un futuro in forma di carriera, io avverto chi sono
e sento di non avere le forze per rispondere alla storia, perché sono
troppo compreso nella mia storia. A vent’anni avverto il peso delle
mie lacune, che mi grava il doppio, perché sono comunque
consapevole della vicenda collettiva. Devo colmarle, quelle lacune.
La mano sinistra di Aldo Moro nel bagagliaio della Renault 4 è
appoggiata sull’addome, pallida sul cappotto scuro, quasi in un gesto
di pudore estremo e io non sono all’altezza di quel gesto.
Ero nato a Milano ma cresciuto in Brianza, cioè una provincia
chiusa per temperamento naturale. La natura, nella costanza con cui
aveva prodotto nei secoli una nebbia gelida e impenetrabile,
determinava la personalità di chi viveva in quel territorio, dove
godersi i caminetti accesi e il comfort dei tempi nuovi era la norma.
Un territorio costellato di paesi i cui nomi chiudevano in «ago» e in
«ate» e producevano in ogni caso una musica pesante al forestiero
(Mezzago e Caponago, Albiate e Limbiate, Ornago e Burago,
Lazzate e Vimercate…) Carlo Emilio Gadda dice una cosa molto
acuta e definitiva, quando scrive che i sentimenti di suo padre
«imbrianzirono sempre di più». La Brianza è un fatto morale ed è
rappresentata in primis dall’industriosità brianzola, cioè la capacità di
abbassarsi umilmente, per lavorare a crescere, e non smettere di
crescere, risolvendo il mondo in una produttività rigorosamente etica,
doverosamente scarna di parole e di manifestazioni. Troppo scarna
per me.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :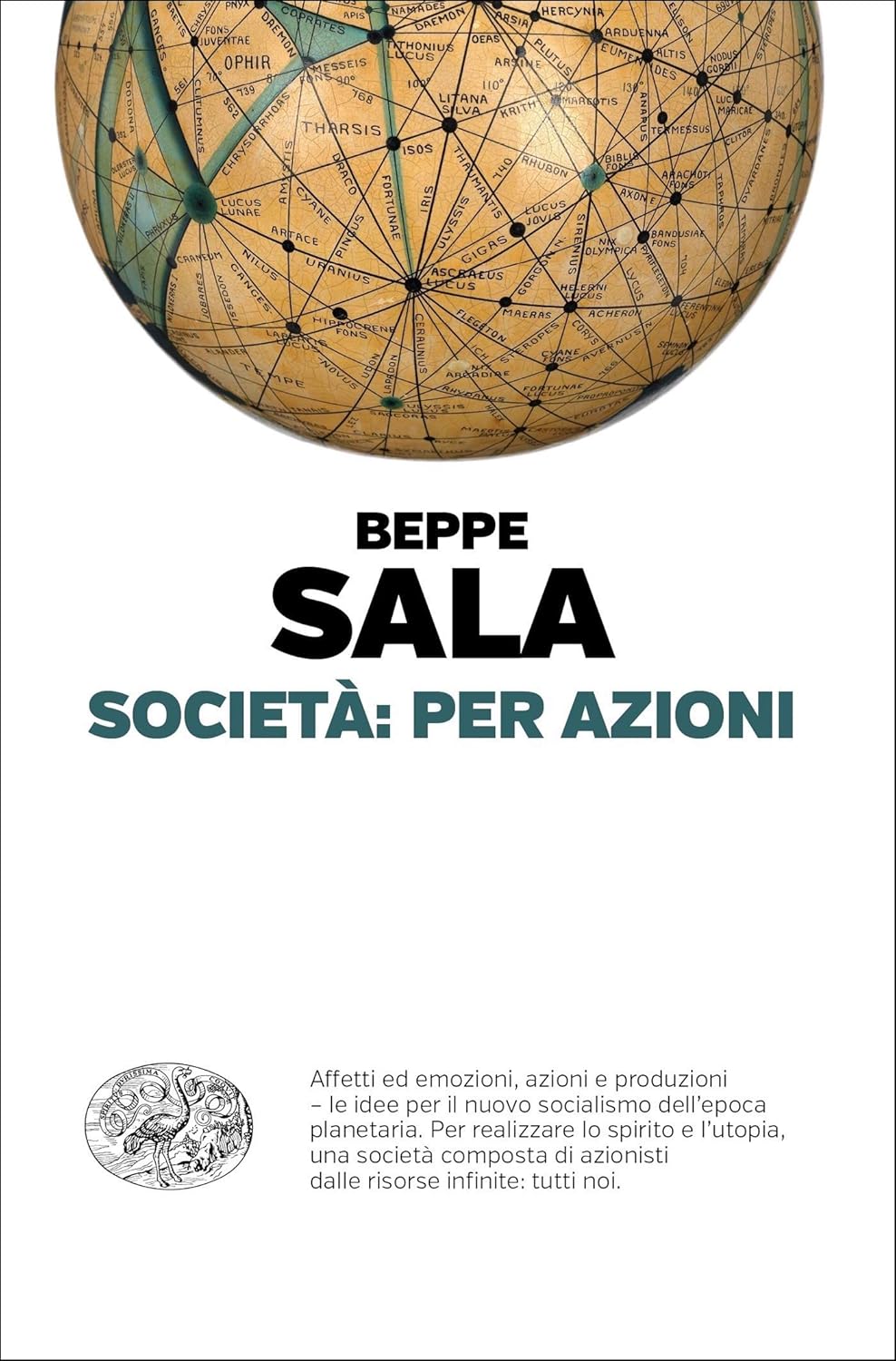






Commento all'articolo