Nel nome di Dante – Diventare grandi con la Divina Commedia – Marco Martinelli
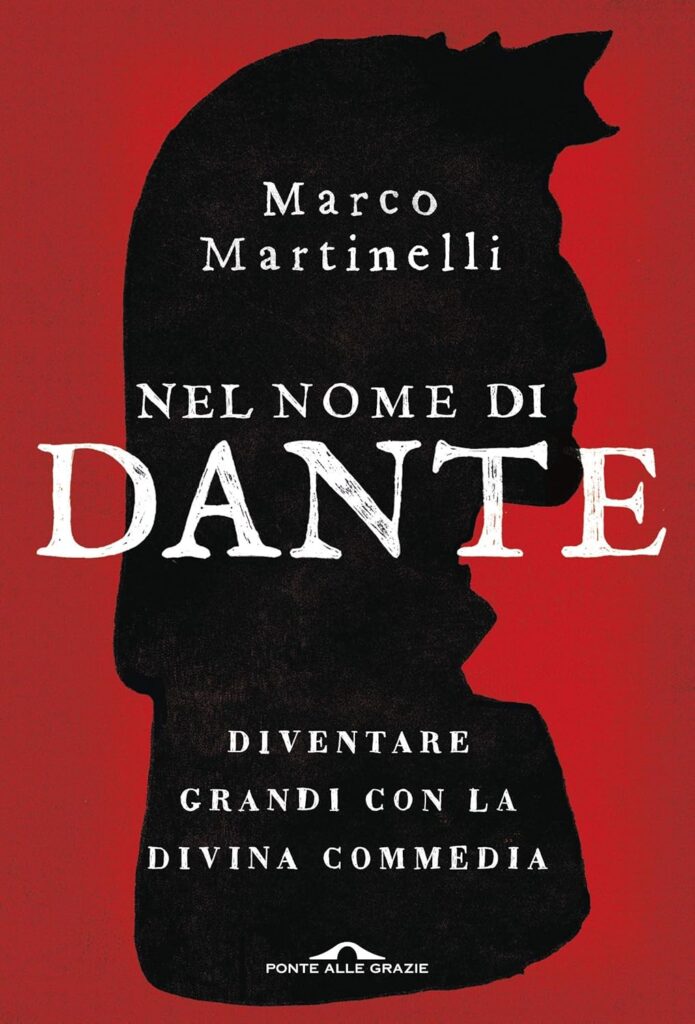
SINTESI DEL LIBRO:
Mio padre aveva un modo tutto suo di svegliarmi. Entrava silenzioso
nella stanza, si sedeva accanto a me, sui bordi del letto, e
cominciava a raccontare. Era la sua voce, sottile e amorevole, a
svegliarmi. E le storie erano sempre diverse, storie che avrei poi
ritrovato a scuola, come gli Orazi e i Curiazi, Edipo e la Sfinge, come
la favola del lupo e dell’agnello di Fedro, quella gli piaceva
particolarmente e la inframmezzava con citazioni dall’originale latino,
«Lupus et agnus venerant, siti compulsi»; oppure mi raccontava di
quando era in «collegio», così chiamava il campo di concentramento
dove lo avevano rinchiuso i tedeschi dopo l’8 settembre del ’43, e il
caporale gli intimava: «Martinelli, ein lied!», e a lui toccava intonare
un canto che gli altri prigionieri, in coro, avrebbero seguito, e
d’altronde, «cosa dovevamo fare? Deprimerci perché eravamo in
gabbia? Piangere? Meglio imparare il tedesco, e cantare, che prima
o poi ne saremmo usciti»; oppure erano le scenette dei suoi film
preferiti, Totò e l’onorevole, Peppone e Don Camillo, che lui
ricostruiva a braccio, per come se le ricordava, improvvisando,
divertendosi e divertendomi, oppure era una citazione, perfettamente
a memoria, dell’amato Don Lisander, il Manzoni: «La quale storia, se
non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche
un pochino a chi l’ha raccomandata. Ma se invece fossimo riusciti ad
annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta». Io facevo resistenza
per poco, perché quella voce suadente mi faceva cedere in fretta:
appoggiavo i gomiti sul letto, e osservavo il babbo narratore
gesticolare nella penombra. Non saprei dire con precisione quando
iniziò questo rituale, questi battesimi al nuovo giorno con la voce di
mio padre, mi pare nei primi anni della scuola media, avrò avuto
dieci o undici anni, quando mi divisero da Maria, la mia sorella più
piccola, e cominciai a dormire da solo, nella stanzetta che dava
sull’unico terrazzo di casa, un piccolo appartamento nella periferia
ravennate. Questo rituale mattutino andò avanti fino alla fine delle
superiori. Non c’è mai stato tra noi l’appuntamento della favola
serale, quella prima di addormentarsi: il babbo narratore preferiva il
mattino, e lo faceva quando gli era possibile, quando era a Ravenna
con noi, perché il lavoro spesso lo teneva lontano in altre città.
Quando non toccava a lui, toccava alla mamma di svegliarmi: e qui
la musica cambiava. Entrava decisa nella stanza, tirava su la
serranda facendo entrare la luce, e poi a voce alta: «È ora di alzarsi!
È ora! Sveglia!» Un trauma: e a quel metodo, sì, che mi veniva di far
resistenza, di starmene sotto le lenzuola, di oppormi: ma lei,
imperterrita, come un sergente dei marines, non aveva pietà, e mi
tirava via le lenzuola con uno strattone. Vincenzo e Luciana erano
molto diversi, ma quello che mi ha sempre sorpreso, in quella
coppia, era il pendolo del maschile e del femminile, e di come se lo
scambiavano e lo ripartivano. Voglio dire che mio padre aveva in sé
tanta dolcezza, quella che di solito riferiamo al femminile, mentre la
mamma aveva tratti di durezza che siamo soliti ascrivere al
maschile. Sono stereotipi, lo so. Quando andavo al liceo, papà mi
accompagnava fino all’entrata, e prima di lasciarci ci baciavamo. I
miei compagni, abituati a un rapporto da uomini con i loro babbi
fieramente romagnoli, se ne stupivano: «Be’ tu e tuo babbo vi
baciate ogni mattina? Mah…» Per contro la mamma si innervosiva
per niente, una volta mi sgridò perché la ringraziavo: «E perché mi
dici sempre grazie? Me lo dici cento volte al giorno! Grazie grazie
grazie! Non dirmi grazie in continuazione, non ce n’è bisogno, non
siamo estranei, capito?»
Ma questo non dovrebbe essere un libro su Dante Alighieri? Certo, è
sicuramente un libro su Dante Alighieri. Un poco di pazienza…
Papà amava scherzare. Sempre. E quello scherzare era il suo modo
di giocare con le parole, con le lingue, con la poesia, con la musica.
Con le date: poteva dirti su due piedi quando era morto Hegel e
quando era nato Kant, e Tommaso d’Aquino e Karl Marx, e se gli
chiedevi però quali fossero i pensieri, le concezioni di questi grandi
filosofi, lui alzava le braccia e apriva la bocca: «Ah… mah… chi lo
sa? Io non lo so, non li ho mai letti». «Papà non è vero!» «È vero,
figlio mio. Ma se vuoi sapere quando è nato e morto Benedetto
Croce…» «Sentiamo!» lo sfidavo io, e lui: «Croce? Benedetto, dici?
Semplice: 1866, 1952». E se andava soddisfatto e sornione, come
se mi avesse battuto a ping-pong. Non era uomo di concetti, di
grandi discorsi: non ci educava con i discorsi, ma giocando. Mio
padre è stato il mio primo maestro, per tutta l’infanzia e
l’adolescenza, e senza mai atteggiarsi a maestro. Aveva un piacere
della lingua che definirei combinatorio, musicale e insieme visivo, il
piacere di giocare con le parole e i suoni e i numeri, forme da
mettere in relazione tra loro: più che la retorica del bel parlare, che
anzi lo annoiava, amava le strutture che formano le frasi, un divertito
scomporre e ricomporre. Giocava con le citazioni dei classici in
latino, di motti e sentenze ne conosceva a centinaia, ma non li
faceva mai cadere dall’alto, li distillava come armi segrete, a
sorpresa, con relativa traduzione, e te li diceva sempre con toni e
modalità recitative buffonesche. Come battute. Ce li tirava addosso
quando meno ce l’aspettavamo, e ci sfidava la volta dopo a
dimostrare di ricordarceli: e poi giù espressioni dall’inglese e dal
tedesco, storpiate in modo comico, fino al dialetto reggiano (senza
farsi sentire dalla mamma, cui non piaceva che in casa si parlasse in
dialetto, «che poi i miei figli non imparano l’italiano a scuola!»), fino
ai canti popolari che gli piacevano tanto, lombardi e napoletani e
friulani. Ce li insegnava, insieme ai canti alpini, alla guida della
bianca Simca 1000, la piccola automobile che i miei avevano
comperato a metà degli anni Sessanta, forse frutto di un buon 12 al
Totocalcio: quando si andava in vacanza, al mare o in montagna, i
viaggi si trasformavano in un concerto corale, il guidatore intonava, e
noi, io e mia sorella dietro, con la mamma che cedeva e pure lei si
univa al canto, tutti a squarciagola a modulare «O ce biel cjscjel a
Udin / oh ce biele zoventut», tutti in coro come in quel campo di
concentramento tedesco.
Un maestro buffone. Ho avuto la fortuna di avere un precettore
personale, come ce l’avevano i nobili di un tempo, solo che Vincenzo
non interferiva mai con la mia carriera scolastica, non mi faceva mai
ripassare le lezioni, quasi non ne voleva sapere. Gli bastava che
andassi bene, che i voti fossero buoni, punto. Se volevo ragionare
con lui di letteratura o di filosofia, si schermiva, proclamando la sua
ignoranza. Lui sviluppava la sua bislacca pedagogia in parallelo. Era
capace di saltar su, nel mezzo di una conversazione a tavola, dove
la mamma si lamentava di qualcuno che aveva fatto fortuna, soldi e
potere, e magari non se li meritava, saltava su con una strofetta
settecentesca del Metastasio, canticchiandola come un rap (che
all’epoca non c’era ancora, o comunque in casa non si sapeva certo
cosa fosse):
Se a ciascun l’interno affanno
si vedesse in fronte scritto
quanti son, che invidia fanno,
ci farebbero pietà.
E alla mamma che lo guardava stranita, Vincenzo allargava
sorridente le braccia e concludeva: «E ho detto tutto», citando così,
dopo Pietro Metastasio, Peppino De Filippo.
A Ravenna non è possibile non inciampare su Dante. È la città che
conserva le sue ossa, che nei secoli ha tenuto vivo il culto del padre
della lingua. Segni che lo ricordano ce ne sono ovunque: per dire, io
ho frequentato la scuola media «Guido Novello», il nobile protettore
di Dante nel suo ultimo rifugio, e il liceo classico è intitolato a «Dante
Alighieri», e sempre a «Dante Alighieri» è intitolato anche il
principale teatro della città, costruito nell’Ottocento, e il teatro Luigi
Rasi, in cui lavoro con la mia compagnia da quasi tre decenni, era
nel Duecento la chiesa di Santa Chiara, gestita all’epoca dalle
clarisse, dove molto probabilmente Dante, terziario francescano,
sarà andato a partecipare alla messa. Nell’abside romanica, che
ancora oggi campeggia in fondo al palcoscenico, erano affrescati da
un allievo di Giotto, Pietro da Rimini, i ritratti di San Francesco e
Santa Chiara, per cui Dante nutriva una particolare venerazione.
Andando al liceo in bicicletta, accompagnato da mio padre, era
inevitabile per noi passare davanti al tempietto settecentesco del
Morigia che accoglie le spoglie mortali del poeta, e talvolta papà
diceva, con tono finto-misterioso: «il ghibellin… fuggiasco!», e giorni
dopo mi buttava lì solo la prima parte della frase, perché io la
concludessi. Perché mi restasse in mente: era il suo gioco, la sua
arte della memoria. Un’estate ci vennero a trovare, da Reggio
Emilia, i nonni paterni: era la prima volta che accadeva, anche se la
nostra famiglia si era trasferita a Ravenna già da diversi anni: tra le
varie tappe di visita alla città, ci capitò di fermarci davanti alla tomba
di Dante, e lì il nonno Silvio, mezzo cieco da un occhio, guardando la
targa della via con l’iscrizione: «Dante Alighieri – Firenze 1265
Ravenna 1321», commentò in dialetto reggiano: «Oh, l’è mort zovan!
L’e mort in dal Vintun!» Aveva scambiato il sommo poeta per un suo
coetaneo morto nella prima guerra mondiale, «morto giovane, morto
nel Ventuno». Papà ne fu molto divertito, non fece nulla per togliere
al
suo poco istruito genitore l’illusione di aver ritrovato un
commilitone della Grande Guerra, e quell’inversione di 1321 in 1921
non poteva non rientrare nella sua strampalata passione
combinatoria per le date. Ma non solo alle date, si appassionava
Vincenzo: anche le vite lo interessavano. Perché le vite erano
sequenze di avventure, le vite non erano che lunghi racconti, da cui
potevi estrarre immagini che restavano in testa: quella di un uomo in
fuga, braccato, un «politico» cui avevano minacciato il rogo se
tornava nell’amata patria fiorentina, il «ghibellin fuggiasco», che a un
certo punto «fece parte per sé stesso», restò solo, solo con i suoi
ideali e i suoi ricordi, abbandonato dai vecchi compagni di partito, di
«parte» appunto, solo con la sua scrittura, solo con la sua fede e i
suoi sogni potenti, che alla fine diventarono la carne del «sacro
poema». Sulla vita di Dante tornava spesso, i suoi chiodi fissi erano
la solitudine e la fuga. Non lo interessava il monumento Dante, a
Vincenzo i Grandi della Storia non interessavano in quanto Grandi.
Gli interessava guardarli in controluce: come delle parole che puoi
rovesciare, anagrammare, e ti suonano in un altro modo. A scuola la
professoressa mi disse che Dante non era ghibellino: era guelfo.
Aspettai la sera per sciogliere il dubbio e sapere con certezza da
papà se Dante era ghibellino, come diceva lui, o guelfo, come diceva
la professoressa. «Be’, in effetti… lui era guelfo… ma anche un po’
ghibellino…» E vedendo la mia faccia stranita, aggiungeva: «La vita
è complicata. E anche la politica». Ma insomma, protestavo io, o era
guelfo o era ghibellino. E lui, con i suoi occhi azzurri penetranti:
«Studia, figliolo. Mica posso dirti tutto io».
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :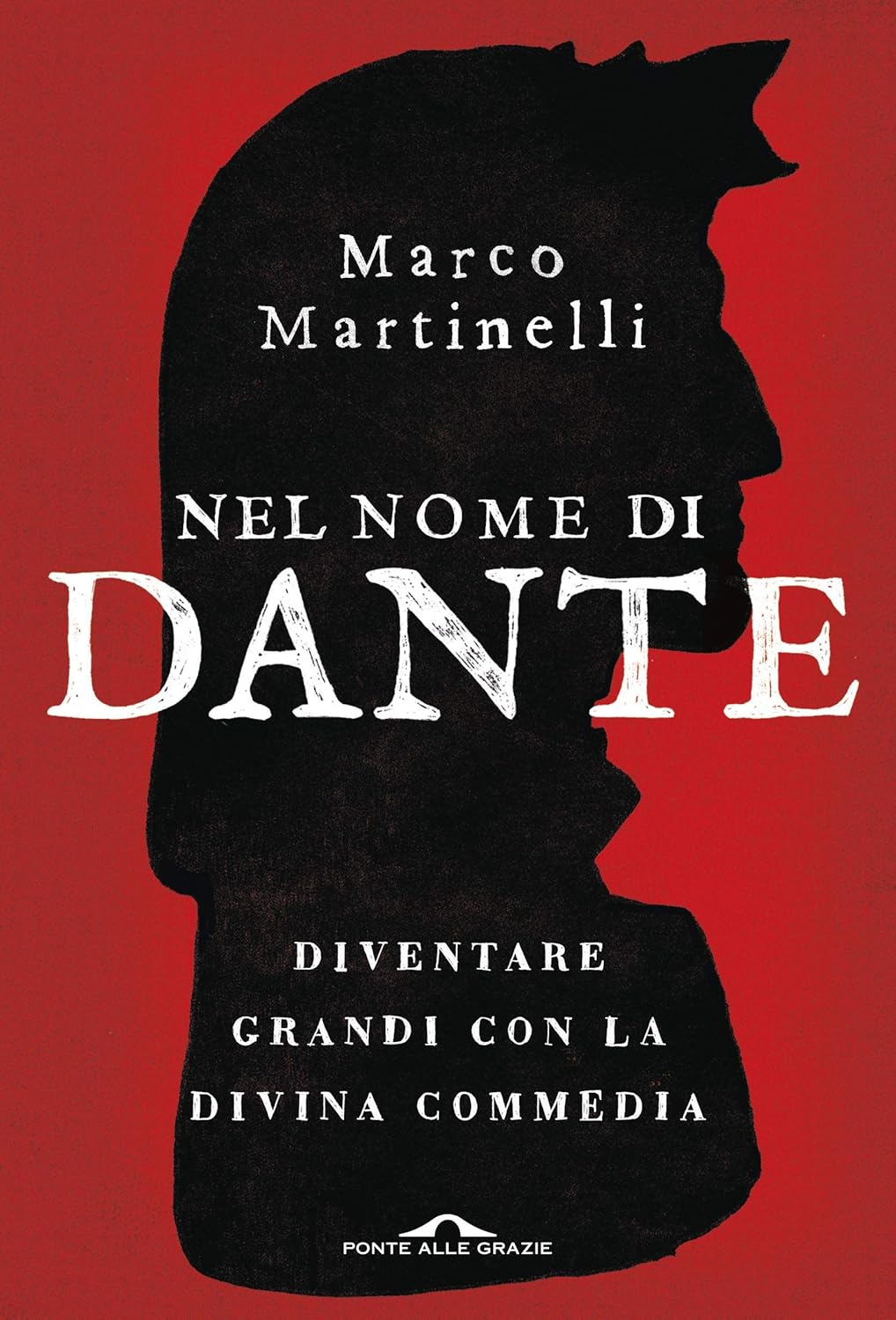






Commento all'articolo