Moneta, sviluppo e democrazia: Saggi su Economia Sociale di Mercato e teoria monetaria – Francesco Forte
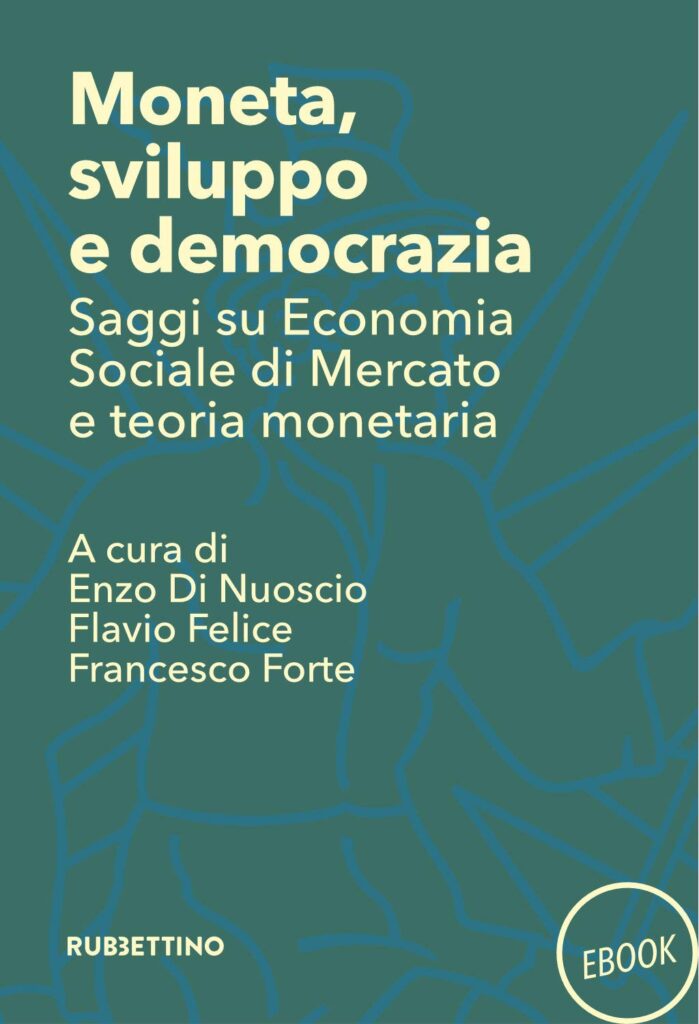
SINTESI DEL LIBRO:
La questione monetaria tedesca si manifesta principalmente
attraverso due fenomeni: in Germania il livello dei prezzi è in
continua salita e, in stretta connessione con questo, c’è l’aumento
del prezzo delle valute estere. Entrambi i fenomeni possono essere,
come avviene il più delle volte, definiti deprezzamento della moneta.
Una peculiarità di questo processo sta nel suo andamento. Lo
sviluppo non è avvenuto in un’unica fase, bensì in modo discontinuo.
Periodi prolungati di stabilità dei prezzi delle merci e delle valute,
come ad esempio negli anni 1920-1921, si sono alternati con periodi
caratterizzati da un turbolento aumento e transitori contraccolpi.
Un’ulteriore particolarità dello sviluppo tedesco è che i prezzi delle
valute estere sono perlopiù stati i precursori dell’aumento interno dei
prezzi delle merci. Occorre chiarire quali siano state le cause di tali
fenomeni, ossia dell’aumento dei prezzi delle merci e
dell’apprezzamento delle valute estere, la discontinuità dello
sviluppo e il procedere nel tempo dell’aumento del prezzo delle
valute. Questo è il primo compito cui se ne aggiunge uno di tipo
politico-economico. Si tratta di analizzare come si possa evitare un
ulteriore aumento dei prezzi delle merci e delle valute estere.
L’analisi della seconda questione dovrà essere basata su quanto
prodotto dalla prima.
L’obiettivo del presente scritto è mostrare, in chiave critica, come
si possa cercare di risolvere le suddette questioni a partire da due
punti di vista sostanzialmente diversi. L’autore ritiene necessaria una
riflessione critica, poiché in molti ambienti, specialmente in quelli che
contano, predominano idee erronee sui concetti basilari della
questione monetaria tedesca, che sbarrano il passaggio a richieste e
provvedimenti adeguati di politica monetaria. Soltanto superando tali
errori sarà possibile costruire una valida e autonoma valutazione.
1. L
1.1 Le cause dell’aumento dei prezzi secondo la teoria della bilancia
dei pagamenti
1.1.1 Descrizione
In Germania, fino a poco tempo fa, vi fu una particolare unanimità
nella valutazione complessiva della questione del deprezzamento
della moneta. Da parte dell’opinione pubblica, del governo, degli
imprenditori, dei lavoratori e, infine, anche della stampa, fu assunto,
salve rare eccezioni, sostanzialmente un unico punto di vista. Le
origini dell’enorme rialzo dei prezzi delle merci e dell’aumento dei
tassi di cambio esteri si ricercavano generalmente nelle dinamiche
del mercato e della produzione di merci.
Già durante la guerra prevalse l’opinione che la riduzione della
produzione fosse la causa principale dell’aumento dei prezzi delle
merci, e la diminuzione dei tassi di cambio nel periodo bellico fu
ricondotta principalmente al fatto che le esportazioni fossero
fortemente diminuite, mentre le importazioni mantenevano, a causa
del
fabbisogno bellico, dimensioni considerevoli
1
.
Volumi di
importazioni elevati e volumi di esportazioni bassi erano, secondo
l’allora opinione prevalente, sinonimi di una bilancia dei pagamenti
passiva, che, a sua volta, doveva avere come conseguenza diretta
la diminuzione del tasso di cambio tedesco. Inoltre, di frequente si
evidenziavano gli influssi della speculazione, tanto che, nel
complesso, l’aumento dei prezzi delle merci e la riduzione del tasso
di
cambio furono ricondotti alla scarsità delle merci a livello
nazionale e alla bilancia dei pagamenti passiva, unitamente alla
speculazione. Simili tentativi di spiegazione potrebbero anche
essere definiti come la «teoria ingenua della bilancia dei
pagamenti».
Dopo la guerra si è proseguita la via ormai intrapresa in relazione
alla spiegazione del deprezzamento del marco. Anche allora si
ricercarono le cause primariamente nel campo della produzione e
del mercato delle merci. I tentativi di spiegazione sono soltanto stati
sviluppati e adattati ai nuovi fenomeni del dopoguerra
2
.
I
tratti
fondamentali della concezione dominante della catastrofe del marco
erano i seguenti: durante la guerra un elevato fabbisogno
dell’economia nazionale era rimasto insoddisfatto. Di conseguenza,
dopo la fine della guerra, era necessaria una quota consistente di
importazioni di generi alimentari e di materie prime. Tuttavia, anche
negli anni successivi, le importazioni mantennero una quota
rilevante, dato che, a causa della cessione di territori, era diminuita
la disponibilità di generi alimentari e materie prime, e dato che, fino
al giorno d’oggi, l’economia nazionale tedesca produce soltanto
all’incirca il 60% rispetto ai livelli registrati in tempi di pace. A ciò si
aggiungono, in misura modesta, inutili importazioni di lusso. Già le
importazioni di merci comportano dunque grandi debiti verso Paesi
esteri. Questi debiti vengono accresciuti dal pagamento degli
interessi derivanti da prestiti che abbiamo ottenuto, soprattutto
durante la guerra, da Paesi esteri, dai pagamenti effettuati a favore
della navigazione estera per i relativi servizi di trasporto e
specialmente dalla fuga di capitali all’estero. A tali grandi importi di
pagamento si aggiungono, inoltre, i debiti derivanti dal Trattato di
pace, i pagamenti in contanti, le prestazioni in natura e i pagamenti
compensativi. Nell’insieme, bisogna, dunque, continuamente
adempiere a enormi impegni nei confronti di Paesi esteri.
D’altra parte, si registrano – ancora secondo la teoria della
bilancia dei pagamenti – poche entrate estere. Le esportazioni sono
diminuite molto più delle importazioni, per cui si è ridotto anche il
reddito proveniente dalle esportazioni. Secondo i calcoli dello
Statistisches Reichsamt (Ufficio di statistica del Reich), tra gli anni
1919 e 1922, le importazioni ammontarono in media all’incirca al
60% del volume delle importazioni del periodo prebellico, mentre le
esportazioni, rispetto al relativo volume registrato nel 1913,
raggiunsero meno del 20% nel 1919, il 50% nel 1920, il 36% nel
1921 e il 39% nel 1922. Tale riduzione delle esportazioni è
l’inevitabile risultato della contrazione della produzione e della
politica commerciale della maggior parte dei Paesi esteri che, in
base alle condizioni stabilite nel diktat di Versailles, godono di un
trattamento preferenziale e unilaterale verso il nostro Paese, mentre
sulle importazioni provenienti dalla Germania gravano spesso
condizioni speciali particolarmente dure. E non solo sono diminuite
le entrate derivanti dalle esportazioni, ma soprattutto, a causa della
guerra e del relativo esito, si sono anche ridotte le entrate da
interessi provenienti dalle proprietà tedesche all’estero, dal momento
che una parte considerevole delle proprietà è stata sottratta. Allo
stesso modo si sono ridotte a una frazione le entrate della flotta
mercantile tedesca.
Il
confronto è inteso non solo a mostrare che il valore delle
importazioni supera in misura significativa quello delle esportazioni,
ovvero che la bilancia commerciale è passiva, ma soprattutto a far
emergere che anche la bilancia dei pagamenti, ossia il confronto tra i
debiti e i crediti della Germania, che risultano da pagare o sono già
stati pagati nell’arco di un anno, presenta un passivo netto. Per il
periodo di quattro anni compreso tra il 1919 e il 1922, il passivo
totale
della
bilancia dei pagamenti ammontò, secondo lo
Statistisches Reichsamt, a 14 miliardi di marchi oro (Goldmark),
tralasciando tuttavia tutte le voci impossibili da definire in cifre, come
ad esempio la fuga di capitali. Il passivo della bilancia dei pagamenti
costituisce la base della maggior parte delle riflessioni sulla
questione monetaria tedesca. Si ritiene inoltre che il necessario
pareggio del saldo passivo della bilancia dei pagamenti avvenga
sostanzialmente attraverso l’esportazione di cartamoneta dalla
Germania. Il fatto che attraverso il traffico vacanziero e l’acquisto di
terreni, azioni ecc. venga pareggiato l’intero saldo passivo viene
infatti negato da coloro che sostengono questo punto di vista
3
.
Inoltre, si sostiene che, nel passato, i mercati esteri abbiano
acquistato cartamoneta volentieri, poiché si credeva in una ripresa
della Germania. Tuttavia, più grande era il deflusso verso l’estero,
più bassa era la capacità di assorbimento. Nello stesso tempo, con il
progredire della politica di conquista francese, il resto del mondo
diede un giudizio più sfavorevole sulla situazione. Ne risultò il crollo
del tasso di cambio tedesco e, di conseguenza, il rialzo del livello dei
prezzi all’interno del Paese. I prezzi delle merci importate
aumentano, in effetti, automaticamente con i tassi di cambio esteri;
peraltro, i nuovi acquisti effettuati da parte di mercati esteri fanno
nuovamente salire il livello nazionale dei prezzi, il quale a sua volta,
benché con esitazione, fa salire i redditi in Germania. L’incremento
della massa monetaria è, secondo la teoria della bilancia dei
pagamenti, soltanto un altro anello della catena. Infatti, i prezzi
oscillanti ma tendenzialmente crescenti mettono continuamente in
disordine il bilancio dello Stato. Oltre a ciò, l’obbligo di consegnare
all’Intesa le valute estere detenute dal Reich ha rilevanti
conseguenze, tanto che qualsiasi aumento dei tassi di cambio esteri
porta immediatamente il bilancio pubblico in disavanzo. Dunque,
finché persisterà l’attuale catastrofe monetaria, un pareggio del
bilancio pubblico appare impossibile e, considerata la limitata
possibilità di contrarre prestiti presso il pubblico, sarà necessario
mettere in circolazione cartamoneta mediante l’emissione di buoni
del Tesoro acquistati dalla Reichsbank. Perciò, l’incremento di
cartamoneta, come conseguenza diretta del disavanzo del bilancio
pubblico, è, in ultima analisi, una conseguenza della passività della
bilancia dei pagamenti, responsabile dell’aumento dei prezzi delle
merci e dei cambi esteri. Un ragionamento simile riguarda
l’incremento della cartamoneta messa in circolazione mediante
l’operazione di sconto delle cambiali commerciali. L’entità di queste
operazioni di sconto dipende primariamente dall’intensità della
circolazione di cambiali e dal livello dei prezzi delle merci acquistate
mediante cambiali. Pertanto, anche in questo caso, la quantità di
cartamoneta messa in circolazione si adatta alla domanda e
soprattutto al livello dei prezzi.
SCARICA IL LIBRO NEI VARI FORMATI :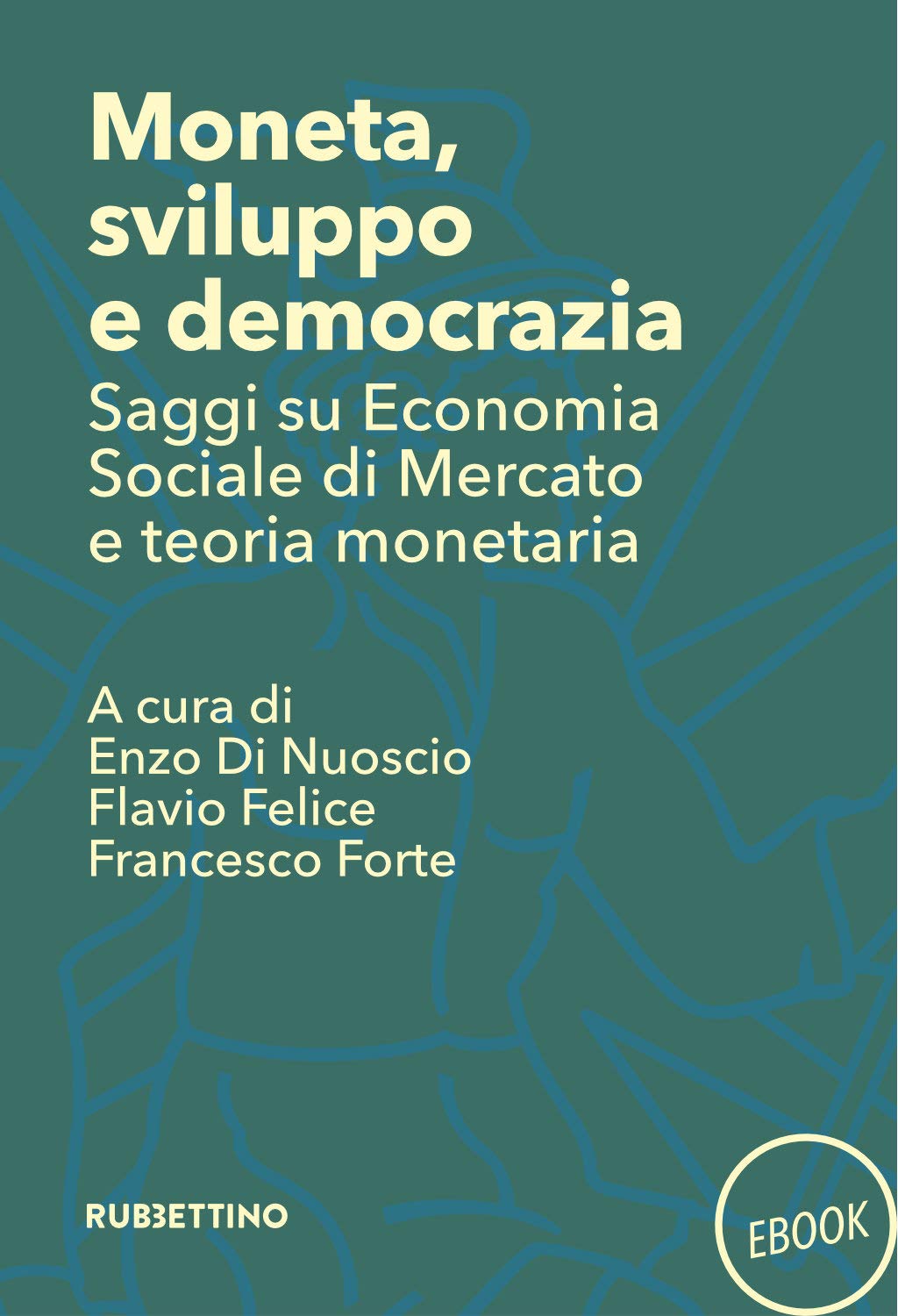





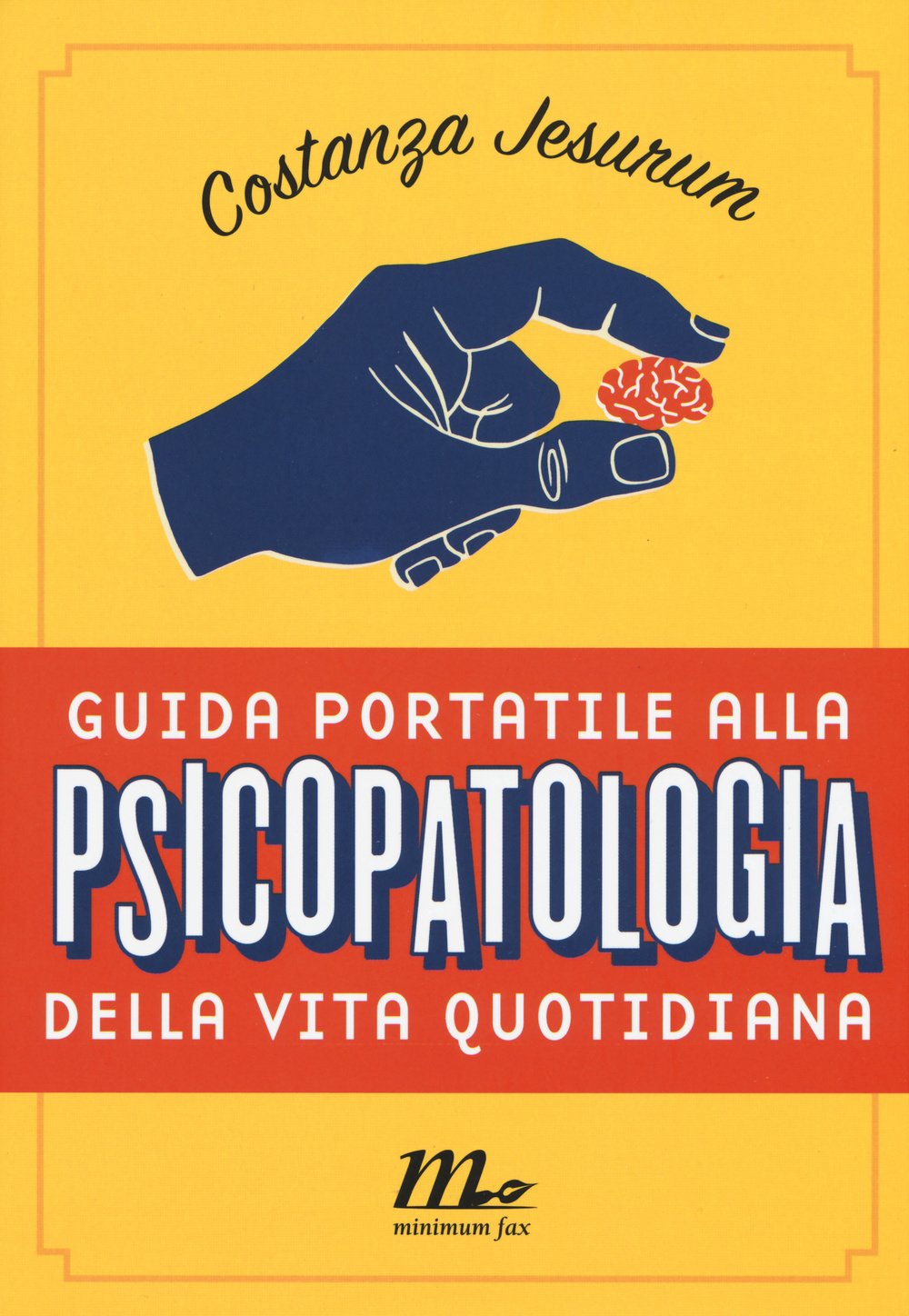
Commento all'articolo